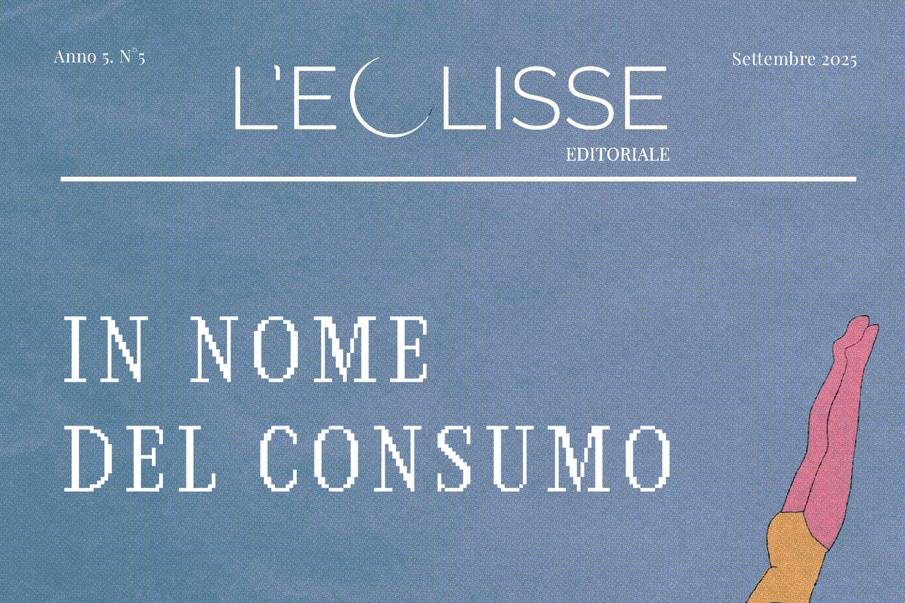Mangia, consuma, crepa: parallelismi tra Week End e La grande abbuffata

Tra tutti i registi delle varie avanguardie degli anni Sessanta, Jean-Luc Godard e Marco Ferreri sono due di quelli che più duramente hanno criticato la nascente società dei consumi.
Jean-Luc Godard non ha bisogno di molte presentazioni: svizzero emigrato in Francia, critico per i Cahiers du Cinéma diretti da André Bazin, nel 1960 esordisce con il lungometraggio Fino all’ultimo respiro (À bout de souffle) e cambia per sempre il modo di fare cinema, diventando ispirazione per i giovani cineasti di tutto il mondo e testa della cosiddetta Nouvelle Vague. Godard è sempre stato anti-establishment, ma è verso la metà degli anni Sessanta, in particolare nel 1967, che si avvicina alle teorie marxiste e maoiste, inaugurando una seconda, ricca fase della sua carriera registica, profondamente militante e ancora più radicale nello stravolgere il linguaggio filmico e le pratiche industriali. Ad esempio, nel 1969 forma il collettivo Groupe Dziga Vertov (in omaggio all’avanguardista sovietico autore de L’uomo con la macchina da presa, Čelovek s kinoapparatom, 1929), con l’obiettivo di rifiutare la tradizionale struttura gerarchica in cui il regista è “l’autore”, l’architetto dell’opera che comanda su tutti e si prende la maggior parte dei meriti. Ad inaugurare questa fase, nel 1967, escono due film: La cinese (La chinoise), ultima collaborazione con Anna Karina, e soprattutto Week End – Un uomo e una donna da sabato a domenica (Week End), una visione apocalittica della società contemporanea.
Marco Ferreri, oggi, è decisamente meno noto di Godard, anche perché è difficile incasellare la sua lunga carriera in movimenti o affiliazioni. Influenzato dal cinema del regista ibero-messicano Luis Buñuel e dalla sua prima vocazione di vita, la veterinaria, Ferreri è stato un maestro del grottesco. Infatti, i suoi film sono spesso crudi, sempre pessimisti (benché molto divertenti), interessati al corpo umano anche nei suoi aspetti più ripugnanti, espressione di una rabbia verso la società del “boom”. Dopo un primo periodo in Spagna, in cui Ferreri si lega allo sceneggiatore Rafael Azcona (già collaboratore di Carlos Saura), la carriera del regista oscilla costantemente tra Italia e Francia. Negli anni, forma sodalizi con un ristretto, ma affiatato, gruppo di attori: Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Catherine Deneuve, più tardi Gérard Depardieu e Ornella Muti. Attivo fin dagli anni Cinquanta, è dal 1969 che, con Il seme dell’uomo e soprattutto Dillinger è morto, i toni grotteschi di Ferreri si alzano sempre di più, per poi esplodere negli anni Settanta, con i suoi capolavori antiumanisti: L’ultima donna (La dernière femme, 1976), Non toccare la donna bianca (Touche pas à la femme blanche, 1974), Ciao maschio (1978) e quello che, ancora oggi, è il suo film più famoso, La grande abbuffata (La grande bouffe, 1973).
La grande abbuffata vede protagonista un quartetto di uomini di successo: un giudice (Philippe Noiret), un pilota d’aerei (Marcello Mastroianni), un imprenditore della gastronomia (Ugo Tognazzi) e il direttore di un’emittente televisiva (Michel Piccoli). I quattro si ritirano per un fine settimana in una villa isolata, nei dintorni di Parigi, per mangiare, mangiare e mangiare. La villa è un luogo in cui le donne non sono ammesse, se non come un ulteriore oggetto di consumo, una specie di bunker omosociale in cui i “maschi” capitalisti cercano di creare una realtà autosufficiente. Almeno fino all’arrivo di Andréa, maestra di scuola elementare che non solo non rifiuterà le bizzarre regole della casa, a differenza delle tre prostitute invitate da Marcello (i protagonisti hanno gli stessi nomi degli attori che li interpretano), ma che, anzi, le adotterà e applicherà anche contro la volontà dei quattro uomini. Andréa è un personaggio complicato: la sua sessualità esplicita e la sua totale stoicità nel continuare a mangiare (oltre al suo nome, la cui radice deriva dal greco anér, andrós, “uomo”) si allineano perfettamente ai marcatori della mascolinità all’interno del film, che sono allegorie per ciò che tradizionalmente viene considerato simbolo di mascolinità nella società occidentale. D’altro canto, nel corso del film assume, nei confronti degli uomini, due ruoli tradizionalmente femminili, ovvero quello della madre surrogata e quello della prostituta, per poi incarnare, infine, nuovamente un ruolo materno, questa volta estremizzato al punto di diventare una sorta di angelo della morte.
L’inquadratura finale è altamente simbolica: dopo la morte del quartetto iniziale, arriva un carico di carne che gli uomini avevano previsto di consumare. Andréa chiede ai galoppini-macellai di spargere in giardino le carcasse – che, non senza un certo gusto del macabro abbastanza comune nel cinema del regista, ricordano da vicino la sorte di Marcello, Michel, Ugo e Philippe – e i cani accorrono per cibarsene. A questo punto, Andréa comincia a rientrare nella villa e Ferreri allarga il campo, riunendo i tre elementi (la donna sulle scale, le carcasse e i cani) in un unico, profetico abbraccio, sullo sfondo del giardino che sempre di più pare un cimitero. Come in tutti i film di Ferreri, l’umanità corrotta (rappresentata dai quattro amici) è destinata a scomparire e, a ereditare la Terra, restano una donna e i cani.

Anche in Week End l’apocalisse dell’uomo consumatore si gioca nel rapporto di genere. Mireille Darc è Corinne, una donna dalle elaborate fantasie erotiche, intrappolata in una coppia in cui a farla da padrone è Roland (Jean Yanne). Quello che dovrebbe essere un semplice e breve tragitto da Parigi alla casa dei genitori di Corinne, dove, come ogni sabato, cercheranno di avvelenare il padre di lei per ottenere una ricca eredità, diventa un viaggio fuori dalla civiltà, inaugurato da una lunghissima carrellata (più di nove minuti, ancora oggi una delle più lunghe della storia del cinema) sulle macchine incolonnate nel traffico, fino a rivelare una serie di incidenti via via più brutali. La macchina, primo simbolo del consumismo, viene distrutta nel fuoco. Fedele al suo motto, «l’immaginazione al potere», Godard immerge i suoi personaggi in un viaggio sempre più onirico, in cui incontrano, tra gli altri, Cagliostro ed Emily Bronte, senza mai rinunciare ai sanguinosi incidenti automobilistici che li circondano come promemoria inevitabili del collasso della società dei consumi. Dopo essere finalmente arrivati alla casa dei genitori di Corinne, dove il padre è già morto, i due si imbattono in un gruppo di guerriglieri, che li renderà prigionieri. Alla fine, Corinne diventa la nuova partner del capo dei guerriglieri, uccide Roland e ne mangia le carni.

Sebbene Week End abbia una forma ben più libera del rigoroso La grande abbuffata, entrambi si interrogano sul ruolo dell’arte nella società dei consumi ed entrambi dipingono un panorama non proprio roseo: nel film di Ferreri, il personaggio di Piccoli ama la musica e la danza, eppure è uno dei più feroci nei confronti delle prostitute. Week End non solo si conclude con il provocatorio cartello “Fine del cinema”, ma ci mostra anche Emily Bronte, arsa viva per essere derubata mentre recita una poesia. In entrambi i film, il cibo e il sesso hanno un ruolo fondamentale e sono fortemente legati. Chiaramente, per Ferreri il cibo, soprattutto la sovrabbondanza di cibo, è il lapalissiano simbolo del consumismo. «Ma perché mangiate tanto? Non può essere fame, non può», chiede a un certo punto una delle prostitute, la meno entusiasta della trovata dei quattro amici. In un’altra scena, Marcello dice a Michel, che, bloccato dalle flatulenze, non riesce a ingerire altro cibo, di pensare di essere un bambino denutrito in India. Consumare, consumare fino a morire: è questa la tragedia auto-imposta dei quattro uomini. Il cibo, che dovrebbe essere fonte di vita, si trasforma in strumento di morte proprio tramite l’eccesso, l’abbondanza sregolata, in un’allegoria chiarissima del post-boom. Non a caso, Ugo, principale responsabile del patto suicida, in quanto cuoco di tutte le elaborate pietanze consumate nella villa, è l’unico a non avere mai dubbi sullo stesso e a rifiutare ogni distrazione. Marcello, al contrario, è il più legato alla dimensione edonistica del consumo: è lui a chiamare le prostitute, stanco di limitarsi a osservare foto erotiche durante la cena, e spesso salta dei pasti per avere incontri sessuali; inoltre, segretamente, cerca di riparare una vecchia Bugatti che ha nascosto nel garage. Eppure, tutti i suoi impulsi vitalistici sono ingabbiati dalla mentalità consumistica e, difatti, quando finalmente riesce a far partire la Bugatti, si limita a guidarla fino al limitare del giardino della villa e a tornare indietro in retromarcia, come un animale in trappola.


Le donne del film, invece, si rifiutano di continuare a mangiare dopo una sola notte di eccessi (le prostitute), oppure mangiano per fame genuina (Andréa, che è l’unica nell’intero film a gridare: «Ho fame!»). Allo stesso modo, Andréa vive il sesso nella villa isolata come qualcosa di liberatorio e volitivo, lontana dalle regole della società borghese e vicina a uno stato di natura simbolizzato dalla sua connessione con gli animali del giardino, come i tacchini e i già citati cani. Anche in Week End Corinne ribalta i ruoli di genere e salva la sua vita dall’apocalisse dei consumi tramite il sesso, inizialmente relegato al subconscio dei sogni e delle fantasie, raccontate al suo analista nella lunga sequenza iniziale, e infine scatenato con una forza animalistica nell’atto cannibale che conclude il film (e che ancora una volta lega i temi del sesso e del cibo). A differenza della madre e la figlia sulla spiaggia nel finale di Ciao maschio1, però, né Andréa, né Corinne sono figure angelicate o purgate delle costruzioni del vecchio mondo, pronte a costruire una società più equa: entrambe sono, in qualche grado, responsabili della morte dei simboli patriarcali che le opprimevano, ma non c’è nessun arco della redenzione nei percorsi dei personaggi. I due registi lasciano allo spettatore l’atroce sospetto che le donne ricostruiranno la società secondo le stesse regole che hanno imparato in quella appena tramontata.
Questo pessimismo di fondo è interessante soprattutto per quanto riguarda il film di Godard. Non solo perché la poetica di Ferreri ha sempre sostenuto un certo pessimismo leopardiano, mentre Godard ha sempre ammirato i prodotti dell’ingegno umano, soprattutto in campo filosofico e letterario, ma anche per un banale dato cronologico. In mezzo ai due film v’è, infatti, quella data che ormai è un simbolo: il Sessantotto. Non è raro trovare, negli anni Settanta, film che riflettono sul fallimento del sogno sessantottino, da Harold e Maude (Harold and Maude, Hal Ashby, 1971) a C’eravamo tanto amati (Ettore Scola, 1975). Al contrario, i contemporanei di Week End tendevano ad un ottimismo totalizzante, «bandiera rossa la trionferà», Woodstock e compagnia. Forse, Godard aveva presentito che il progetto rivoluzionario del maggio francese sarebbe stato frustrato e amputato, e nella sua rabbia cieca contro la società occidentale aveva piantato i semi del dubbio: bandiera rossa la trionferà? Curiosamente, è dopo il Sessantotto che i film del Groupe Dziga Vertov acquistano un certo ottimismo politico, come Crepa padrone, tutto va bene (Tout va bien, 1972), altro film dove, per citare nuovamente il cineasta, «il personale è politico» e la vocazione attivista scocca nuovamente in seno alle tribolazioni di una coppia eterosessuale.
Oggi, in un’epoca in cui il consumismo è ancora più rampante e sembra davvero che fagociti tutto, anche noi stessi, e in cui le vittorie politico-sociali di quella turbolenta stagione politica non sembrano più così sicure e irremovibili, Week End e La grande abbuffata sono documenti storici che rischiano di diventare inquietanti specchi del presente. In un’era in cui la nostra sensibilità è completamente anestetizzata dalla costante ripetizione su mass e social media anche delle immagini più atroci, quelle che Godard e Ferreri hanno creato riescono ancora a scioccare. Nel secolo in cui da ogni dove giungono proclamazioni di morte del cinema, è ancora il cinema a dirci che, forse, neanche noi ci sentiamo tanto bene.
Note
- Ciao Maschio fa il paio abbastanza bene con La grande abbuffata, pur estremizzando alcuni elementi (l’impotenza cronica, fisica e sociale, dell’uomo moderno; il destino apocalittico della civiltà, simile alla decadenza dell’Impero Romano, nonché la complicata eredità del fascismo; la rinegoziazione dell’identità femminile, tra calchi del maschio patriarcale e potenza rinnovatrice) e ribaltandone altri, per esempio sostituendo alla bolla claustrofobica della villa parigina una New York deserta, in cui gli spazi ampi la fanno da padrone.