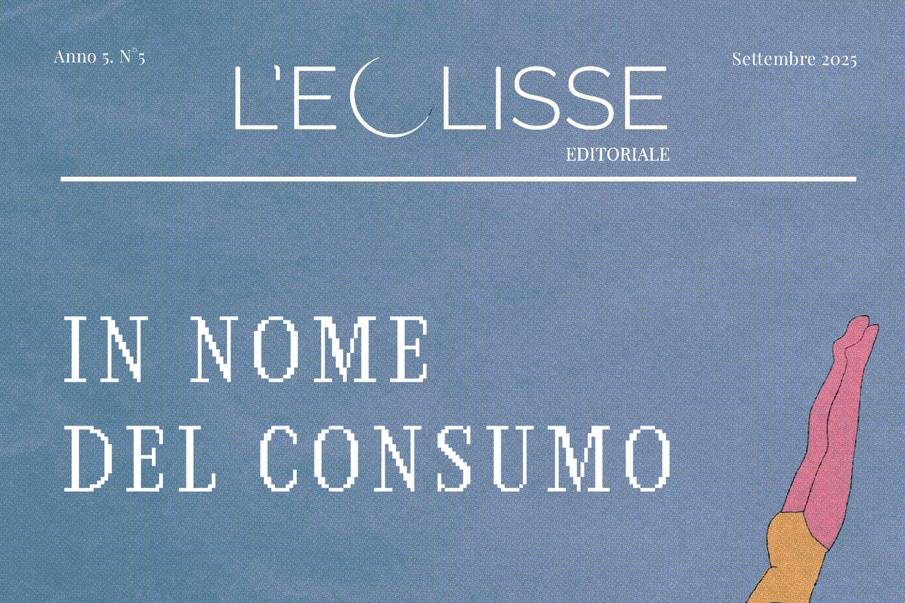Le pubblicità influenzano il nostro modo di pensare?
Come il consumismo ci condiziona senza accorgercene
Nella società odierna, siamo costantemente colpiti da stimoli visivi e uditivi legati a prodotti e servizi apparentemente indispensabili. Spesso cadiamo nelle trappole di offerte, sconti e occasioni, e ci rendiamo conto solo in seguito che ciò che abbiamo comprato non ci interessava davvero. La ragione di ciò, però, non è sempre legata ai soldi, ma a quanto siamo condizionati dalle pubblicità che ci circondano.
Pensiamo a tutti i luoghi e i contesti in cui siamo esposti alle pubblicità. Basti pensare a come queste siano presenti in televisione (negli spot, nei film, nelle televendite), in radio, sui manifesti in strada, addirittura su bus, auto, camion, sui social (post sponsorizzati, gifting, social advertising, annunci carosello). In sintesi, ogni cosa che ha uno spazio fisico e virtuale libero ed è esposto al pubblico può rappresentare una possibilità per le aziende di promuovere il proprio prodotto o servizio. Ovviamente le pubblicità non sono casuali, ma sono studiate attentamente per attrarre il consumatore attraverso i colori, il design, gli slogan. Ogni dettaglio è rilevante ed è studiato da un’apposita scienza: il neuromarketing. Essa si concentra su come sfruttare ogni meccanismo conscio e inconscio del cervello per portare il cliente a comprare il prodotto o il servizio, anche se non ha un effettivo bisogno di ciò che sta acquistando. Riguarda etichette, confezioni, annunci, immagini; non solo le pubblicità in televisione, ma ogni modo in cui le aziende possono comunicare indirettamente con le persone.
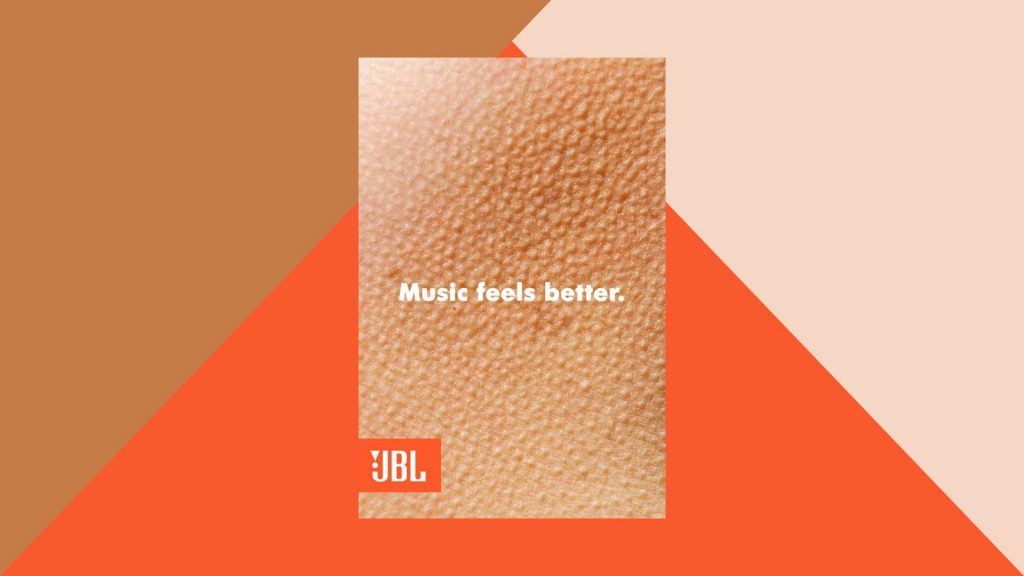
Quindi, che impatto ha l’insieme degli strumenti della società consumistica e capitalistica sul nostro cervello? Come sfrutta il nostro desiderio di ricompensa e gratificazione? Come ci porta a comprare anche ciò che, in fondo, troviamo inutile? Il nostro cervello decide per noi prima ancora di rendercene conto. Guardando una pubblicità, la vista è ovviamente il primo senso ad attivarsi. Le aree del cervello coinvolte, come la corteccia occipitale, decidono in pochi secondi se essere attratti da quello spot o meno. Infatti, essendo una reazione inconscia, è molto legata alla memoria e alle emozioni, molto di più di quanto pensiamo.
Subito dopo aver visto o sentito una pubblicità, la memoria (ippocampo e corteccia prefrontale) si attiva ed è attratta da ciò che in passato ha innescato un sentimento positivo: una scritta del nostro colore preferito, una canzone della nostra infanzia, un nuovo prodotto sponsorizzato dal nostro attore preferito. Tutto attiva delle sensazioni, positive o negative, che ci portano ad agire non secondo il nostro volere, ma secondo il nostro istinto, la parte più inconscia e remota del nostro cervello. Ma qual è il vero motore che ci porta dall’osservazione all’azione? Come è facilmente intuibile, l’emozione che regna sovrana sul nostro inconscio è il piacere, sensazione che parte dalla corteccia orbito-frontale. La gratificazione, la ricompensa e il piacere sono la vera ragione per la quale acquistiamo un prodotto o un servizio. Questo vale soprattutto per ciò che non ci serve: il superfluo.
Secondo uno studio di Brian Knutson, neuroscienziato della Stanford University, tra le aree cerebrali che influiscono sui nostri acquisti c’è il nucleus accumbens. Questa struttura cerebrale, centrale per la sensazione di ricompensa, motivazione e piacere, è responsabile del rilascio della dopamina ancora prima di aver comprato o posseduto un oggetto. La dopamina, infatti, è un neurotrasmettitore, un messaggero chimico nel cervello, che permette ai neuroni di comunicare. È fondamentale per funzioni come il movimento, la motivazione, la ricompensa, l’umore e l’apprendimento. Se ci pensiamo bene, siamo sempre attratti dall’euforia di avere qualcosa di nuovo tra le mani o dall’immergerci in nuove esperienze. Non è il possesso dell’oggetto a farci sentire felici, ma sono l’attesa e l’immaginazione della nostra felicità quando avremo quell’oggetto a farci provare entusiasmo.
Purtroppo, però questa sensazione si esaurisce nel momento in cui otteniamo l’oggetto o abbiamo usufruito di un servizio. Nasce, quindi, una sorta di circolo vizioso, in cui siamo costantemente alla ricerca di dopamina, cioè di qualcosa che possa suscitare in noi quell’euforia, anche quando l’abbiamo soddisfatta da poco. È proprio qui che si inserisce il meccanismo della pubblicità che ci invoglia a cercare quella soddisfazione comprando cibo, prodotti per la cura personale, quel nuovo paio di scarpe, facendo un giro in barca o un viaggio. Se anche solo una volta saremo soddisfatti dall’aver esperito o comprato, subito le pubblicità avranno un effetto maggiore. Richiamando la memoria e le emozioni, ci portano ancora di più a sentire il bisogno di quell’euforia. Quindi, accade di nuovo e quando finalmente abbiamo tra le mani una nuova borsa, una nuova macchina, un qualsiasi nuovo regalo per noi stessi in realtà non saremo mai felici quanto abbiamo immaginato.

Inoltre, le dinamiche sociali di oggi incrementano questo processo. Ad esempio, avere un determinato stile di vita in base alla propria situazione economica ci inserisce in modo più omogeneo all’interno della nostra comunità. Lasciandoci influenzare dagli altri, secondo la teoria del confronto sociale (formulata dallo psicologo e sociologo statunitense Leon Festinger nel 1954), il nostro successo è costantemente paragonato e valutato in base a quello degli altri. Per cui, più gli altri hanno e più noi dobbiamo stare al passo, conformandoci. Secondo Vincenzo Russo, professore di Psicologia dei Consumi e coordinatore del Centro di Ricerca di Neuromarketing alla IULM di Milano, questo meccanismo può mettere anche in pericolo la nostra stabilità finanziaria tramite acquisti impulsivi. Come spiega Russo: «Quando gli acquisti danno gratificazione immediata compromettono la pianificazione a lungo termine e la corrispondente attivazione del sistema dopaminergico nel cervello spinge a ripetere questi comportamenti, anche se portano a problemi economici».
Un’altra usanza comune è fare regali. Natale, compleanno, Pasqua, anniversari e San Valentino sono solo alcune delle numerose occasioni per mostrare il nostro affetto tramite un gesto materiale. È anche un’occasione per intensificare i meccanismi di desiderio e gratificazione. La sensazione della sorpresa ci porta inconsapevolmente ad avere un’emozione positiva maggiore, che rimarrà associata nel lungo termine alla persona da cui abbiamo ricevuto il regalo. Per cui, quando compriamo qualcosa pensiamo sempre di aver fatto una scelta ragionata e razionale, in base non solo ai nostri gusti e necessità, ma anche considerando soluzioni più salutari e più ecosostenibili. In realtà, però, è il cervello che nella maggior parte dei casi decide, prima ancora di mettere in atto il ragionamento.
Una possibile soluzione potrebbe essere una sorta di ritorno a uno stile di vita meno dipendente dai beni materiali e dallo status sociale. Tramite il minimalismo potremmo dare importanza a valori ormai dimenticati e cambiare il funzionamento della società. Esso è, infatti, una filosofia e uno stile di vita che predilige la semplicità, l’essenzialità e l’eliminazione del superfluo, per concentrarsi su ciò che porta reale valore, felicità e soddisfazione. Secondo alcuni studi1,2, abbracciare questo diverso e poco diffuso approccio potrebbe portare vari benefici e aiutare a contrastare gli effetti negativi che, sul lungo termine, possono diffondersi nella società. È ormai molto evidente come i valori del materialismo, del paragone sociale, del desiderio di status ottenuto tramite i beni materiali possano ridurre la qualità della nostra vita. Questi meccanismi e situazioni aumentano l’ansia e l’insoddisfazione, con conseguente depressione o alienazione.

Al contrario, il minimalismo riporterebbe il benessere emotivo tramite la riduzione dello stress e favorirebbe una maggiore soddisfazione. Meno spese, quindi un maggior benessere finanziario, che inevitabilmente si riflette sullo stato emotivo delle persone. Ci sarebbero anche maggiori benefici per la società, arricchita dai valori, dalle relazioni più umane e da una maggiore attenzione alla sostenibilità. Alcuni atteggiamenti che sarebbe meglio abbracciare sono, ad esempio, l’apprezzare le piccole esperienze della vita; la riparazione degli oggetti quando si rompono o rovinano; accettare di avere poche cose e utilizzarle realmente; avvicinarsi a passatempi sani come gli sport o la cultura personale; imparare a vedere le persone per ciò che sono, avendo la pazienza di conoscerle e senza giudicarle dalla prima impressione. Si otterrebbero altrettanti benefici anche a livello cerebrale, come meno stimoli superficiali e meno “rumore” sensoriale e visivo. Infatti, quando il nostro sistema nervoso è sovraesposto agli stimoli, è costretto a concentrarsi solo su alcuni, quelli ritenuti da noi più importanti, lasciando gli altri come un vero e proprio rumore di sottofondo. Meno stimoli incrementerebbero la concentrazione, diminuendo la fatica di decidere quale stimolo sia più importante.
Realisticamente questo sarebbe un obiettivo davvero difficile da raggiungere, proprio per il piacere insito in questo processo malsano, che tende così ad autoalimentarsi. Proprio come una sorta di virus da cui tutti siamo già stati contagiati senza nemmeno accorgercene. Forse ciò accadrà in futuro, quando l’umanità, ormai distrutta da sé stessa, da quello che noi abbiamo creato, troverà il coraggio per un drastico ma positivo cambiamento. Inutile dire che si modificherebbero radicalmente le dinamiche sociali e la struttura stessa dell’economia: forse un salto verso l’ignoto necessario per raggiungere una maggiore felicità collettiva.
Note
- J. Kang, C. M. Joyner Martinez e C. Johnson, Minimalism as a sustainable lifestyle: Its behavioral representations and contributions to emotional well-being, in “Sustainable Production and Consumption”, 2021, n. 27, pp. 802–815.
- F. Malik e M. I. Ishaq, Impact of minimalist practices on consumer happiness and financial well-being, in “Journal of Retailing and Consumer Services”, 2023, n. 73.
di Elena Floris