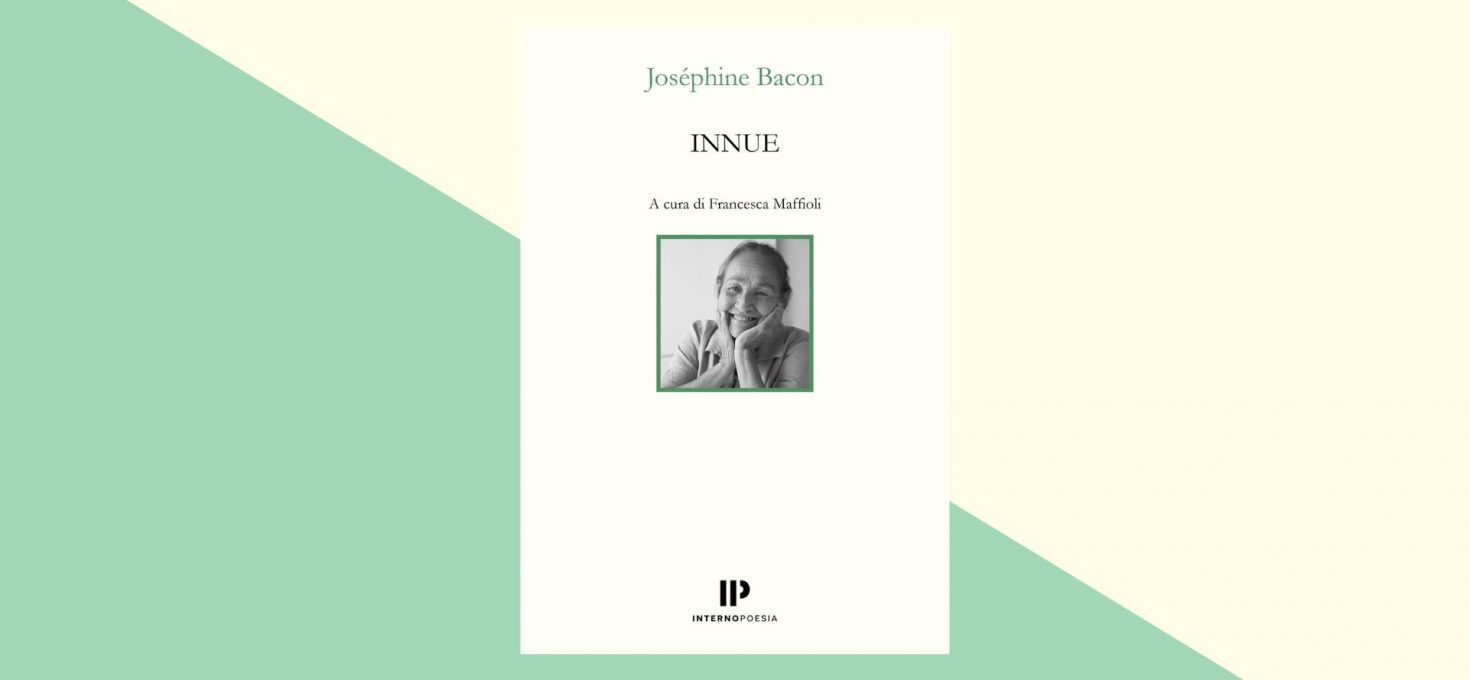Articolo di Elena Floris e Cecilia Giraldi.
Poeta e figura centrale della letteratura contemporanea delle Prime Nazioni1, originaria di Pessamit, in Quebec, l’opera di Joséphine Bacon nasce da una doppia appartenenza linguistica e culturale: da un lato l’innu-aimun, lingua della sua comunità d’origine che ha contribuito a trascrivere e preservare; dall’altro il francese quebecchese, lingua della traduzione e della città. Un dialogo costante fra memoria, territorio e modernità che attraversa tutta la sua produzione. Grazie al lavoro di Francesca Maffioli, che abbiamo intervistato qui, è finalmente possibile conoscere questa voce anche in Italia.
Come sei arrivata alla conoscenza di Josephine Bacon?
Come ho scritto anche nell’introduzione, quello con Josephine Bacon è stato un incontro fortuito. Collaboro con il Marché de la Poésie di Parigi e nel 2018 il paese ospite era il Québec. Conoscevo già qualcosa della poesia quebecchese, ma non in modo approfondito: come accade ogni anno, la programmazione diventa occasione di scoperta. Durante una delle letture, Bacon era l’ospite d’onore. Mi sono ritrovata lì, ad ascoltarla, e ne sono rimasta completamente folgorata. Ho pensato subito che dovevo parlarle, anche se immaginavo che fosse circondata da persone. Però mi sono detta: “Non posso non farlo”. Quando finalmente l’ho incontrata, si è rivelata straordinaria. Io sono giornalista, sono abituata a persone molto verbose, che parlano tanto e velocemente. Lei no. Parla come scrive: per sottrazione, quasi a versi; ne sono rimasta incantata. È stato un incontro per me fortissimo, che mi ha segnata profondamente, e proprio in quel momento ho capito che volevo portare la sua voce in Italia. All’epoca non era tradotta, e mi sono detta che sarebbe stato il mio obiettivo. È nato tutto così, in modo semplice e molto passionale.
Cosa ha rappresentato per te tradurre proprio Innue, un’opera così legata all’identità di un popolo e di una donna?
Quando ho voluto tradurre questo testo, quindi a partire dal 2018, l’ho fatto sicuramente con la consapevolezza della scuola di pensiero in cui mi posizionavo in quanto traduttrice. Io ho fatto degli studi, ho un dottorato in studi di genere, quindi la questione del genere, della razza, della classe era qualcosa che non potevo esimermi dal considerare nel mio atto di traduzione. Quindi l’ho voluto fare in quanto soggetto posizionato, e ho scelto lei perché è stato una sorta di innamoramento dei versi. Inoltre, io e l’editore Andrea abbiamo tenuto tanto al fatto di realizzare la traduzione dell’opera completa dell’autrice invece che dei singoli libri, che nella lingua originale sono piccolini. Abbiamo pensato che sarebbe stato bello poter dare ai lettori italiani uno sguardo completo su tutta la sua produzione fino ad allora, nonostante fosse rischioso, dato che il risultato è stato un libro di quasi 400 pagine.
La poesia di Joséphine Bacon è molto radicata nelle proprie radici e mira anche a riportare alla mente sensazioni corporee e immagini. Ti è mai capitato di tradurre altri autori o autrici che avessero l’intenzione di far emergere così tanto la propria cultura da metterla al centro della propria opera?
È sicuramente vero che la sua è una scrittura incarnata; cosa vuol dire incarnata? Vuol dire che c’è il suo corpo, in quanto essere umano, che osserva il paesaggio circostante. Questa è una differenza culturale rispetto a noi italiani o europei: gli Innu hanno una concezione del paesaggio molto diversa rispetto alla nostra, per loro il territorio che abitano innanzitutto è stato un territorio di caccia, un territorio di percorrenza (perché erano una tribù nomade) ed è un territorio che gli è stato strappato a causa della colonizzazione francese.
Tra gli autori che ho tradotto, lei è l’unica autrice non europea e quella che presenta la più significativa diversità culturale. Non mi è mai capitato di tradurre altri autori che ponessero la propria cultura così tanto in rilievo per la sua estraneità. È l’unica che esalta questo elemento legato a un territorio diverso rispetto a quello europeo. Mentre invece altre volte mi è capitato di tradurre altri testi che avevano complessità diverse dal punto di vista filosofico, magari per alcune parole intangibili o intraducibili.
Tutti abbiamo avuto esperienze di vita singolari e spesso incontriamo persone con un background completamente diverso dal nostro; tuttavia, a volte riusciamo ad empatizzare anche con chi sembra che sia molto diverso da noi. Ti sei sentita in qualche modo vicina all’autrice mentre cercavi di rendere le sue poesie in italiano? Hai trovato dei punti d’incontro tra le vostre storie?
Sicuramente traducendola ho rivisto il legame con il luogo in cui sono cresciuta. Io sono lombarda, più precisamente ho vissuto nella zona delle Prealpi. Per questo sono sicura che il mio affezionarmi alla poesia di Bacon e nello specifico al suo soffermarsi su alcuni dettagli naturali possa derivare dal legame con le mie radici e la mia relazione con la città, che è qualcosa di non ancora risolto.
C’è un tema che ti è piaciuto in modo particolare e che ritieni importante sottolineare?
Dato che le poesie sono tante è difficile riuscire a trovare qualcosa che le accomuni, perché ogni raccolta ha la propria specificità, insomma sono state scritte anche in periodi diversi. Credo che se dovessimo trovare qualcosa di comune in molte poesie sarebbe l’attenzione al vivente inteso in senso ampio: il vivente animale, il vivente umano, il vivente vegetale. Come secondo tema, la sua attenzione alla memoria degli antenati, che vivono anche nella sua terra.
Una volta mi è capitato di sentire dire a una traduttrice che stimo molto che un traduttore, a volte, conosce il testo più dell’autore stesso. Cosa ne pensi?
Quando si traduce un testo, la relazione con esso cambia radicalmente rispetto alla lettura: è una conoscenza diversa, più lenta, più immersiva, proprio per una questione di tempo dedicato a esso. Come lettori scorriamo le pagine, ogni tanto saltiamo parole, o ci distraiamo. Nella traduzione questo non accade. Servono letture ripetute, un’attenzione costante, una cura quasi ossessiva. Nel lavorare su Bacon, per esempio, mi è capitato di restare ore su poesie brevissime. Alcune traduzioni sono arrivate con naturalezza, ma poi rientravo nel testo, lo rileggevo, lo lasciavo sedimentare, e capivo che dovevo rimettere mano ai versi. La scelta lessicale, il ritmo, il respiro… tutto richiede tempo.
Non arriverei a dire che il traduttore conosce il testo più dell’autore. Direi piuttosto che lo conosce altrimenti, in modo diverso. La traduzione è una delle possibili letture profonde di un’opera, non la verità ultima su di essa. Io stessa mi colloco dentro questa idea: sono una traduttrice engagée, direbbero i francesi. Tradurre non è replicare, ma interpretare da una posizione precisa, con la propria storia personale, culturale, linguistica. La mia traduzione non è l’unica possibile, è una tra molte. Nasce dal mio sguardo, dal mio tempo, da chi sono. In questo senso, il testo tradotto diventa altro rispetto al testo originario. Non superiore, non più “conosciuto”, ma attraversato da un’altra voce.
Ho apprezzato molto le tue traduzioni avendo letto l’originale in francese, mi sembrano davvero ottime. Quello del traduttore è secondo me un lavoro complicatissimo, fra i più difficili possibili. Sempre restando sul tema della traduzione, su cui verterà la maggior parte delle mie domande, ti chiedo: dato che queste poesie sono scritte inizialmente in una lingua orale e poi tradotte, per così dire, in una lingua seconda, il francese, come sei riuscita a rendere questa complessa stratificazione linguistica in italiano?
È stato davvero molto difficile. Bacon parla innu-aimun, una lingua a tradizione orale, ma è anche una delle prime autrici della sua Prima Nazione a scrivere poesia sia in innu-aimun che in francese, e si autotraduce, senza specificare mai quale versione nasca prima dell’altra — francese o innu-aimun. Le due lingue convivono, dialogano, e non sempre coincidono.
Quando ho iniziato a lavorare su di lei nel 2018 non conoscevo l’innu-aimun, quindi la mia traduzione è partita naturalmente dal francese. Però, durante la traduzione, mi capitava di incontrare punti in cui qualcosa non funzionava: non riuscivo a trovare una soluzione convincente, sentivo che mancava un pezzo. Così, benché all’inizio avessi pensato di non considerare l’innu-aimun, ho iniziato, con molta cautela, ad avvicinarmi anche a questa lingua. Non per tradurlo direttamente, ma per capire il processo che compie lei. Ho scoperto che le sue autotraduzioni sono molto libere. Non c’è una corrispondenza piena tra innu-aimun e francese. A volte sembra davvero che scriva due testi diversi, che fanno parte della stessa opera ma non sono speculari. In questo è simile, per certi versi, a un’altra poetessa anch’essa quebecchese, Nicole Brossard, che si traduce tra francese e inglese e spesso parla proprio di “un altro testo” che nasce nel passaggio linguistico. Traducendo Bacon, prendere in considerazione l’innu-aimun ha certamente complicato le cose, ma è stata per me anche una ricchezza aggiunta che mi ha permesso di scoprire un altro mondo, un’altra cultura, esplicitato nella lingua che l’autrice usa.
In che misura ti sei mossa da un testo all’altro? Cioè tra l’innu-aimun e il francese?
Ho sempre iniziato dal francese. In molti casi la prima stesura nasceva da lì, soprattutto quando il testo scorreva e non incontravo ostacoli. Poi però tornavo sopra i versi, più volte, e quando sentivo che qualcosa non tornava, quando una parola o un’immagine sembravano non avere peso sufficiente o non posarsi bene sull’italiano, allora andavo a vedere il testo in innu-aimun. Non era un confronto sistematico, ma una ricerca mirata. L’autotraduzione di Bacon, come dicevo, ha complicato ulteriormente questo processo: non abbiamo un originale e una copia, ma due versioni che non sempre coincidono. E in alcuni casi è proprio l’innu-aimun a offrire una chiave che il francese non mostra.
Faccio un esempio concreto: la parola tundra. Significa “terra senza alberi”, ma in innu-aimun uno dei significati è “terra del grande orso”. Perché Bacon sceglie tundra nel senso francese, quindi con l’etimologia dal russo e non terra del grande orso quando si autotraduce in francese? È in queste intersezioni linguistiche che il lavoro diventa un laboratorio infinito. Proprio per questo dico che una traduzione non si “chiude” mai davvero. Si raggiunge un punto di equilibrio, certo, ma rimane un’approssimazione consapevole. Ad un certo momento bisogna lasciare andare il testo, sapendo che ci si è avvicinati a quanto più possibile, ma che il movimento tra le lingue continua a vibrare sotto la superficie.
La mia penultima domanda riguarda il suono. Nelle tradizioni poetiche che conosco meglio, quella russa e quella tedesca, il suono è qualcosa di centrale, direi che in alcuni casi costituisce almeno il sessanta per cento dell’efficacia poetica. Non so come funzioni nella tradizione innu-aimun, e mi incuriosiva capire, da un lato, che ruolo ha il suono nella poesia di Bacon e, dall’altro, come hai lavorato sul piano sonoro in italiano, considerando la doppia mediazione tra lingua orale e francese. Immagino sia preponderante nell’originale, trattandosi di una lingua orale.
Devo essere molto sincera: per la resa sonora mi sono appoggiata principalmente al francese. Come dicevi anche tu, il suono è una delle cose in assoluto più difficili da rendere e in traduzione bisogna scegliere: dare la priorità al significato del verso o al suono? È il grande dilemma dei traduttori di poesia, ed è un dilemma irrisolto. Non c’è una risposta stabile, è un equilibrio continuamente rimesso in discussione. A volte sono riuscita a conservare una certa musicalità, altre volte ho dovuto rinunciare, perché la densità francese si scioglie in più parole in italiano e l’eleganza del verso rischia di svanire.
L’innu-aimun lo comprendo in modo ancora limitato, direi quasi passivo, più simile al rapporto che si ha con una lingua antica studiata sui testi, ad esempio il greco. Ho ascoltato musica, letture, voci innu, ma non parlo la lingua. Perciò il lavoro sul suono, di fatto, è avvenuto soprattutto attraverso il filtro francofono.
Per fortuna Bacon non lavora con la rima, altrimenti il terreno sarebbe stato ancora più scivoloso. Ma il suono non è solo rima; è ritmo, è ripetizione, è respiro, ed è lì che entra in gioco la dimensione orale. Una componente importante, per me, è stata non levigare ciò che nel testo è ruvido. Molte lingue indigene funzionano anche per accumulo, reiterazione, immagini che ritornano: e io non ho voluto addomesticarle. Traducendo da una cultura minoritaria, sentivo la responsabilità di non renderla docile, né armoniosa secondo criteri italiani. Su questo punto mi ritrovo molto nella traduzione femminista e in certe posizioni di teoriche canadesi, penso ad esempio a Sherry Simon: lei dice che la traduzione è una sorta di contratto che tu fai con l’autore o autrice, che cambia continuamente, non c’è nulla di fisso e non c’è una resa definitiva. La fedeltà non è “abbellire” o far suonare bene; è mantenere l’integrità, nel senso di interezza, della voce dell’altra. È un lavoro che, proprio per questa complessità, risulta infinitamente più interessante e formativo. Non è semplicemente il confronto con un “mostro sacro” della nostra tradizione, come potrebbe essere Baudelaire, dove il campo è già arato e la traduzione italiana vive dentro un orizzonte consolidato. Qui c’era un altrove radicale, un terreno culturale diverso, e il mio compito non era addomesticarlo ma, al contrario, rispettarne la distanza.
Dal punto di vista teorico, mi riconosco in una pratica di traduzione femminista e impegnata, che rifiuta la tendenza a livellare, a rendere tutto armonioso e confortevole secondo i parametri della lingua di arrivo. Tradurre da una cultura minoritaria significa anche fare attenzione a non appiattirne le asperità, a non lucidare ciò che non nasce lucido. Questo vuol dire mantenere ripetizioni, accettare certi attriti della lingua orale, permettere che la specificità rimanga percepibile. Qualcuno potrebbe dire che si tratta di una postura di estrema fedeltà, rispetto a traduttori che preferiscono avvicinare il testo alla cultura ricevente. In realtà, anche qui si tratta di compromessi continui. Non c’è una fedeltà assoluta; non desidero rendere gradevole al pubblico italiano qualcosa che non nasce per il pubblico italiano. Desidero, piuttosto, che la voce che traduco continui a respirare nel suo ritmo, nella sua visione, nella sua differenza.
Cosa speri rimanga a un lettore italiano leggendo Joséphine Bacon? Te lo chiedo anche pensando alla mia esperienza: prima di lavorare a questo articolo non conoscevo il suo nome, né avevo mai sentito parlare di innu-aimun, e l’incontro con il suo mondo è stato davvero affascinante. Per chi ama le lingue e la traduzione, scoprire una voce così diversa apre una curiosità nuova, una voglia di approfondire. Io ne esco con un forte interesse e con il desiderio di esplorare di più questo universo.
Credo che quello che dici sia già molto bello ed è esattamente ciò che spero: che chi legge si incuriosisca, che desideri incontrare altre voci autoctone, che magari sogni di viaggiare in quei luoghi non con un’idea di turismo superficiale, ma per avvicinarsi davvero a quella cultura. Se nasce questo movimento interiore, per me è già tanto. Poi, un’altra cosa a cui tengo molto, e che forse esula un po’ dalla domanda, riguarda il ruolo del traduttore. Tu lo sai bene: i paratesti, le note, le introduzioni sono strumenti fondamentali per rendere visibile il nostro lavoro. L’idea che il traduttore debba essere invisibile, che debba semplicemente traghettare il testo, non mi appartiene. Siamo corpi e posizionamenti. La mia traduzione è diversa da quella di chiunque altro, perché sono una donna, perché sono bianca, eterosessuale. Tutto questo passa, inevitabilmente. E credo sia importante riconoscerlo e non cancellarlo.
Ti ringrazio tantissimo. L’ultima cosa che ti chiederei, che è una cosa che io nelle mie interviste di solito aggiungo dato che normalmente scrivo di letteratura per L’Eclisse, è se puoi consigliare ai nostri lettori qualche testo per avvicinarsi alla cultura delle Prime Nazioni.
– Jean Michel, Kukum, (traduzione di Sara Giuliani), marcos y marcos, 2024.
– Deni Ellis Béchard, Natasha Kanapé Fontaine, Kuei, je te salue: conversation sur le racisme, Ecosociété, Montréal, 2021.
Essendo, come dicevo, una lingua poetica con una forte dimensione orale, credo che vada anche ascoltata. Ecco allora una suggestione d’ascolto, tramite l’lbum di una poeta e cantautrice innu:
– Natasha Kanapé Fontaine, Nui Pimuten I (2021).
Ringraziamo ancora la traduttrice Francesca Maffioli e l’editore Andrea Cati per averci permesso di immergerci nella poesia potente ed evocativa di Josephine Bacon e nel complesso lavoro della traduzione. È grazie a loro che oggi possiamo apprezzare in italiano una poesia che ci fa viaggiare in un luogo lontano, spesso sconosciuto, ma ricco di natura incontaminata e casa di un popolo che rimane legato ai propri antenati, al proprio territorio e alla propria storia.
Note

di Elena Floris
Sono nata nel 2005 in Sardegna, ma la passione per l’arte mi ha portata fino a Ravenna per studiare Beni Culturali all’Università di Bologna. Mentre cerco di godermi a pieno la vita universitaria assieme ai miei amici, mi piace tenermi aggiornata sugli ultimi articoli delle grandi testate giornalistiche dedicate alla cultura, scrivere, visitare mostre e musei e immergermi nel mare che bagna la mia terra. Di tanto in tanto sogno e progetto il mio futuro, di cui l’unica cosa di cui sono certa è che l’arte ne farà parte.

Cecilia Giraldi
Cresciuta a Milano con una nonna convinta che I Promessi Sposi e la Commedia fossero ottime favole della buonanotte, sono sempre stata innamorata delle parole – e oggi studio linguistica per non smettere mai di rincorrerle. Amante della letteratura russa, racconto le mie letture su Leseratte, il mio angolo di bookstagram. Nel poco tempo libero, mi aggiro tra mostre, librerie ed enoteche, sempre alla ricerca di qualcuno disposto ad ascoltare una dissertazione non richiesta su qualche arcano problema linguistico o sconosciuto scrittore sovietico.