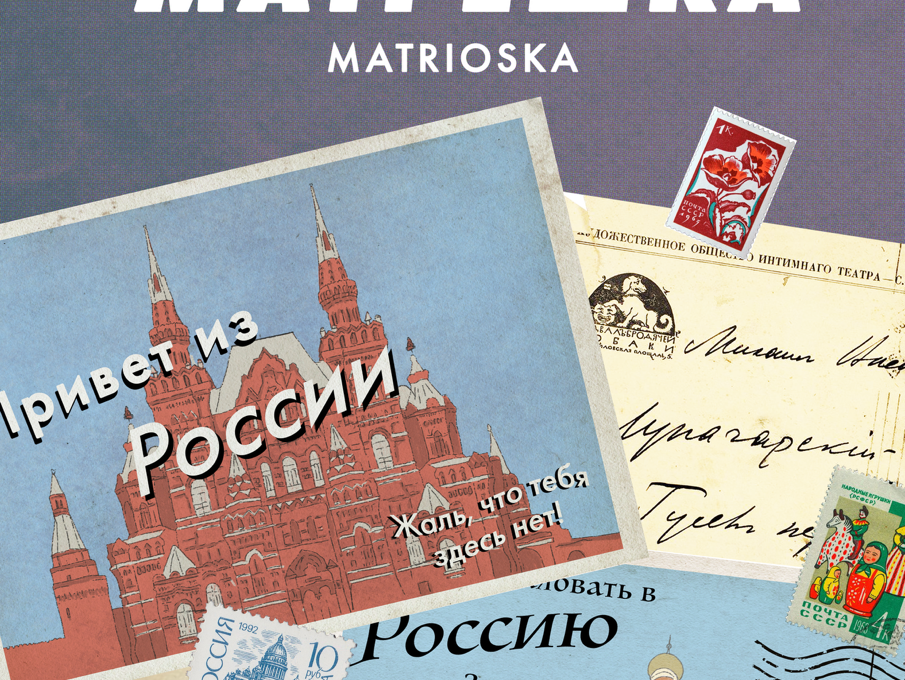Il ritorno dello zar
Che ne dicano gli anziani al bar, che parlano ancora di “Jugoslavia” in riferimento ai Balcani, l’Unione Sovietica (URSS) non esiste più da più di trent’anni, così come non ha più senso ragionare in termini di Guerra Fredda: fare ciò sarebbe solo anacronistico, fuorviante e ipersemplificativo. Fin dalla presidenza di Boris Yeltsin della Federazione Russa, costituita nel 1991 una volta dissolta l’Unione Sovietica e che noi oggi consideriamo semplicemente come “Russia”, il nuovo Stato ha dovuto necessariamente ritrovare il proprio posto nel mondo e nelle relazioni internazionali. Questo processo è stato molto altalenante e ha portato alla definizione della politica di Vladimir Putin, l’attuale presidente russo.

A partire dagli anni Novanta, si rivelò necessario per l’ex superpotenza attuare una serie di riforme economiche e politiche, per distaccarsi dal passato sovietico e avvicinarsi man mano alle istituzioni occidentali. Ciò non avvenne in modo pacato: spesso la popolazione reagì con proteste e mobilitazioni, accompagnate da un forte dibattito sull’identità nazionale che ha portato di riflesso a una graduale trasformazione della politica estera del Paese. Infatti, vista la necessità di integrazione nelle organizzazioni internazionali per riacquisire una posizione rilevante nel panorama globale, il presidente Yeltsin mostrò inizialmente una certa apertura alla collaborazione con l’Occidente, in quanto, in fin dei conti, era l’unica soluzione razionalmente perseguibile per risollevare il Paese. Per quanto la buona volontà ci fosse, viste le condizioni dell’industria e della società russa, si arrivò inevitabilmente a una situazione di crisi economica e instabilità politica, affossando ulteriormente la già vacillante reputazione internazionale della Federazione.
Fu proprio questa combinazione di fattori a portare al potere Putin, che fin da subito iniziò a consolidare la sua posizione politica all’interno del Cremlino, professando un’idea di Russia molto aggressiva e nascondendo dietro una pesante tenda propagandistica un intento di realpolitik mirato a riacquisire il potere perduto della “Grande Russia”. Il tutto con un nemico naturale: l’Occidente, e di conseguenza la NATO (Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord), accusati di “eccessivo espansionismo” nelle aree ad ex influenza sovietica. Dopotutto, questa volontà putiniana non è novità: nella storia russa si ritrova un costante desiderio di potere, influenza e espansione che, pur assumendo forme e strumenti diversi a seconda dei periodi, attraversa l’epoca zarista, l’Unione Sovietica e la Russia post-1991. I mezzi cambiano, ma resta la costante strategia di assicurare un “cuscinetto” di sicurezza e prestigio, insieme alla volontà di tornare protagonista nella competizione internazionale.

All’inizio del 2000, con il divenire della politica estera russa più assertiva e strategicamente autonoma a causa dell’ascesa al potere di Vladimir Putin, la trasformazione delle strutture di potere ha portato a una relativa stabilizzazione interna, spostando l’attenzione sulla riconquista della propria sovranità nazionale e sulla minaccia occidentale, la quale tentava – secondo la propaganda del Cremlino – di minare alla sicurezza e all’influenza geopolitica del Paese. Da qui, Mosca scelse di sfidare l’egemonia statunitense, sviluppando una strategia di partenariato con le potenze “orientali” (ad esempio, Cina e India), in modo da costituire un ordine internazionale multipolare che, dunque, avrebbe riconosciuto gli interessi russi accanto a quelli delle altre maggiori potenze.
A supporto di questo cambio di rotta, il governo russo ha iniziato a produrre una narrazione sempre più strumentalizzata, che mischiava un sentimento di orgoglio nazionale con discorsi ispirati dal patrimonio storico-culturale e dalle connessioni “spirituali” con le comunità russofone nel mondo. Il fine di tale sforzo era trovare la legittimazione per politiche mirate ad una maggiore coesione regionale e influenza globale, come si è visto chiaramente negli interventi pubblici di Putin sulle relazioni russo-ucraine, soprattutto in merito alle regioni del Donetsk e Luhansk. Queste narrazioni hanno quindi costituito in modo incrementale la base fondante per una politica estera bilanciata tra considerazioni pratiche e audacia strategica, manifestandosi in un tipo di discorso diplomatico sempre più reattivo accompagnato da azioni aggressive tangibili, tra cui i vari interventi militari dagli anni Novanta a oggi1
Soprattutto in merito all’Ucraina, lo scenario dipinto dal Cremlino evidenziava una crescente minaccia occidentale all’eredità comune russo-ucraina, per cui era necessario risvegliare nella popolazione il perduto sentimento nazionalista per giustificare le diverse misure aggressive. Inevitabilmente, in un mondo dominato da Internet e, dunque, dal potenziale accesso a qualsiasi tipo di narrazione, il meticoloso lavoro per plasmare le menti necessitava di un regime interno stabile, costruito e mantenuto attraverso la manipolazione dei media e un alto livello di censura2.

La retorica reattiva ha progressivamente sgretolato i rapporti con l’Occidente: se in un primo periodo – ossia durante la presidenza Yeltsin – vi era un cauto impegno diplomatico reciproco, lo scetticismo ha poi preso il posto di qualsiasi segno di collaborazione, accusando le potenze occidentali, e in particolar modo la NATO, di erodere la sicurezza russa3. La trasformazione ha raggiunto un punto di svolta con le operazioni militari in Georgia (2008), seguite dall’annessione della Crimea (2014) e l’intervento in Siria (2015). Specialmente in merito alla Crimea, la Russia ha avuto l’occasione di solidificare la forte opposizione alle strutture di sicurezza europee stabilite dopo la Guerra Fredda. Di conseguenza, le relazioni con le Nazioni occidentali sono crollate, vedendo apparire sempre più sanzioni economiche ai settori essenziali russi. Dal lato del Cremlino, questa reazione non ha fatto che confermare i sospetti reciproci e, soprattutto, ha rafforzato la narrazione di Mosca, che veniva dunque a costituire un movimento di resistenza contro le forze esterne che tentavano di minare al potere sovrano russo.
Contraltare di questa ostilità occidentale è stata la strategia di rafforzamento delle relazioni con le potenze “orientali”. Con le ex repubbliche sovietiche, ad esempio, la Federazione Russa ha istituito l’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, derivata dall’alleanza militare del 1992 (nonché tentativo di riportare in vigore una sorta di Patto di Varsavia, ossia un’alleanza militare del blocco socialista europeo, in vigore dal 1955 al 1991 e finalizzata alla mutua difesa e al controllo politico dell’Unione Sovietica sui paesi satelliti). Essa riunisce Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia e Tagikistan, ma il suo intento difensivo è stato messo più volte in discussione, soprattutto dopo l’aggressione all’Ucraina del 2022, quando l’Armenia si dichiarò estranea ad essa e preannunciando l’uscita entro il 2026.
Vacillando la collaborazione con gli ex “amici”, Putin si è spesso rivolto a Cina e India come partner alternativi con cui aggirare le sanzioni occidentali, facendo leva sulla comune appartenenza ai BRICS. Anche in questo caso, però, la collaborazione è puramente strumentale e calcolata, con la Russia costretta a giocare la parte del “secondo”, mentre i due colossi mondiali valutano di volta in volta la convenienza di un partenariato con la Federazione in base ai propri interessi nazionali. La ricerca di altri partner è diventata palese dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022, quando il tentativo di Mosca di ristabilire la propria dominanza nei territori di importanza strategica, opponendosi all’espansione a est della NATO, ha esacerbato il suo isolamento internazionale. Rispetto ai casi precedenti, l’aggressione ha segnato una risposta diplomatica molto più decisa rispetto al passato, con un altrettanto diffuso supporto all’Ucraina. In una guerra in cui la narrazione gioca un ruolo fondamentale da ogni lato, non suonano dunque insoliti i tentativi russi di screditare la NATO, testando la sua resistenza con azioni contenute e mirate, giustificate come risposta al costante timore di una minaccia occidentale.

In definitiva, la traiettoria politica della Russia post-1991 dimostra come, nonostante i tentativi di apertura, la ricerca di potere e sicurezza continui a permeare la sua politica estera, in una costante dialettica di rivalità con l’Occidente e di diffidenza reciproca. Oggi, nel nuovo ordine internazionale frammentato e instabile, il Cremlino si propone non come un semplice erede dell’Unione Sovietica, ma come un interprete rinnovato della tradizione imperiale russa. Immagine speculare degli zar che rivendicavano prestigio, sicurezza e influenza sull’Eurasia, Putin si presenta come il custode della continuità storica, deciso a difendere la “Grande Russia” in ogni arena possibile. Non più il presidente di una Federazione fragile e isolata, ma lo “zar del XXI secolo”: un sovrano tornato a cavalcare la scena mondiale, tra ombre di impero e riverberi di potenza.
Note
- Tra questi figurano gli interventi in Cecenia, Transnistria, Abcazia, Ossezia del Sud, e poi gli eventi più conosciuti in Georgia, Ucraina (prima nel 2014 con l’annessione della Crimea e poi l’aggressione nel 2022) e Siria.
- A. Gugushvili, Russian public perceptions of the war in Ukraine: a paradox of optimism amid crisis, ”Journal of Contemporary European Studies”, 2025, 33(3), pp. 950–974. https://doi.org/10.1080/14782804.2025.2472635
- Anche questo è un aspetto ricorrente nella storia russa, strettamente legato alla sua posizione geografica. Riprendendo le teorie geopolitiche di Halford Mackinder, geografo britannico, e Nicholas Spykman, politologo statunitense, la Russia costituisce l’Heartland, regione corrispondente all’Eurasia che per la sua posizione strategica permette di avere una posizione cruciale nelle relazioni internazionali. Viceversa, il Rimland corrisponde alle regioni che circondano l’Heartland: chi controlla questa porzione di mondo, è in grado di contenere l’Eurasia. La minaccia alla sicurezza russa è dunque causata dalla paura di una presenza occidentale in questa porzione di territorio circostante, che non le permetterebbe di espandersi fino a soddisfare i propri bisogni securitari e quindi di garantire la propria sovranità nazionale.