Voci dai musici ossessivi (o presunti tali)
Voci dai musici ossessivi (o presunti tali)
Tra le varie forme d’arte, la musica è tra le più comunicative. Le possibilità e le modalità per inviare messaggi – diretti, indiretti o metaforici – sono infatti molteplici. Non a caso, sia a livello professionale che a livello personale, è una consuetudine tutt’altro che remota che si usi la musica per esprimersi: che si parli di unə artista particolarmente conosciutɘ oppure della band che suona nel proprio garage, gli immancabili motori della produzione musicale sono la necessità e la volontà di esprimere dei concetti. Di pari passo, non è raro che lə autorɘ di queste opere musicali siano soggettɘ a turbamenti che, seppur partendo come emozioni negative, sono fonte di ispirazione per nuove creazioni. Nel corso del tempo, non sono mai mancati dischi e canzoni che riflettessero lo stato di malessere dellɘ autorɘ. Le ossessioni non sono particolarmente diverse, anzi: presentandosi come una sorta di pressione sulla sua mente, l’artista cerca di liberarsi da essa trasformandola in musica. La scena musicale internazionale ha sfornato tantissimi esempi tuttora fruibili che possono essere punto di riferimento e di partenza per la comprensione di talune di queste angosce.
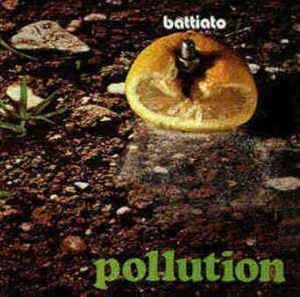
Le forme più complesse di traduzione dell’ossessione in musica sono i concept album, intere produzioni che hanno l’obiettivo di sviscerare un solo argomento fino a rivelare tutte le sue insidie. Nello scenario musicale italiano, alcune testimonianze rilevanti sono i primi due album di Franco Battiato: Fetus (1972) e Pollution (1973). In entrambi i dischi, si denota non solo l’ossessione, ma la vera e viva paura del cantautore siciliano sul futuro che, secondo lui, avrebbe atteso l’umanità. Guidato dall’ingombrante spettro de Il mondo nuovo (1932), romanzo fantascientifico dell’autore britannico Aldous Huxley, Battiato rimodula musicalmente nel primo album le tesi esposte nell’opera di cui sopra riguardo a un possibile sviluppo degenerativo, rappresentato dal rischio che la nascita dell’essere umano possa diventare un’azione artificiale. Nel secondo album, invece, queste tesi sono riprese parzialmente in un’ottica ambientalista e prevedono un esito infausto per la flora e la fauna terrestri. Questo approccio fortemente pessimista è rafforzato dalle melodie, ancorate alle prime tendenze elettronico-sperimentali di Battiato. Talvolta dissonanti e talvolta angosciose, non sono altro che la riflessione speculare di quanto espresso nei testi, sintomatiche di quell’inesorabile deriva dalla quale non ci si può sottrarre se non alla fine dei propri giorni.
Nello stesso periodo, il cantautorato italiano propone altri lavori del genere: un esempio celebre è indubbiamente Fabrizio De André con Tutti Morimmo A Stento (1968). Nelle tracce vengono raccontate le esperienze di tanti individui con la morte, che il cantautore genovese intendeva affrontare da una prospettiva “psicologica, morale, mentale”. Insomma, tutti quegli aspetti della società e quelle esperienze drammatiche spesso nascosti dall’immaginario collettivo. Con estrema crudezza, infatti, vengono messe in luce tutte le atrocità che spesso derivano dall’ossessione – a volte di chi agisce, altre di chi la subisce (es. la tossicodipendenza, la pedofilia, etc.). Non bastano gli intermezzi, prima apparentemente ottimisti e poi disillusi, a fornire quell’agognato barlume di speranza. La pomposità barocca del disco non è altro che un mezzo per veicolare meglio la solenne tragicità che pervade le vicende dei brani.
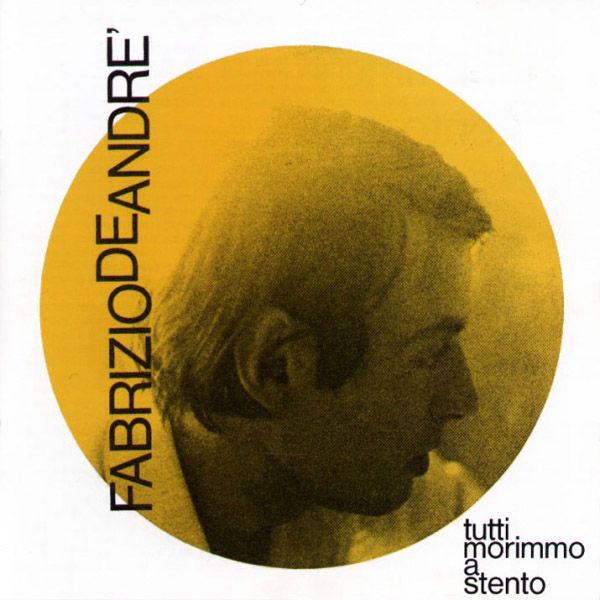
Parallelamente, altre pubblicazioni restarono più in sordina nel mercato discografico. Sempre nello stesso periodo (verso il 1968), nascono i Fabio Celi e Gli Infermieri. Band dal nome certamente particolare, oggi non particolarmente di successo, la quale ha dato alla luce un solo album: Follia. Rimasto oscuro sia in termini di visibilità che in termini di temi, è il racconto concettualmente organico del protagonista dell’album. Narrati interamente in prima persona, gli episodi sono controversi e mossi da una violenza non sempre repressa e, a volte, sfogata anche contro innocenti. Questo porta il protagonista-narratore ad assumere posizioni ideologiche e comportamentali discutibili e, alla fine di una delle canzoni, di essere persino trascinato via. Il macabro sarcasmo con cui si espone il tutto fa da perfetto contorno alla totale incoscienza – o, ancora peggio, alla totale coscienza – del personaggio principale.
Prima di “spostarsi” all’estero, ci sono due ulteriori ultime testimonianze che vanno menzionate e che brillano entrambe per essere quantomeno singolari. Il primo album è Trans Vita Express (1974) di Marcello Giombini, autore con ampia esperienza nell’ambito della musica religiosa. Ascrivibile al fenomeno musicale della messa beat e parzialmente al progressive rock religioso, questo disco deve molto alle sperimentazioni sonore che spaziano dall’elettronica alla musica concreta. La struttura fondamentale è composta dalle voci in (apparente) presa diretta dellə defuntə o delle loro anime, che si sono trovatə improvvisamente sul treno per l’Aldilà senza rendersene conto. Un concentrato di ansie sonore e vocali che, nel complesso, satura la mente dell’ascoltatorə con una visione violenta della transizione post mortem. L’incomprensione, e forse anche il rifiuto, della morte porta lə defuntə a cercare in modo disperato e ossessivo di tornare da dove erano venutə e dallə loro carə.
L’altro album in questione è La macarena su Roma (2010), esordio del cantautore Iosonouncane. Pur essendo pienamente inserito nella scena musicale contemporanea e nonostante sia stato autore di importanti colonne sonore negli ultimi tempi, resta meno conosciuto di quanto non meriti – anche a discapito del suo stile e delle sue sonorità peculiari. Nel suo disco di debutto, Iosonouncane esprime un’idea sarcasticamente critica del nostro mondo e dei nostri tempi attraverso un linguaggio forte, crudo, a tratti estremamente grottesco. Non solo le sperimentazioni musicali sono di per sé aspre, ma anche i vocalizzi hanno tonalità spettrali. In questo modo, le due componenti appaiono fortemente dissonanti tra loro, in un risultato che pare essere davvero voluto. I tormenti verso i difetti della nostra società e la nostra posizione all’interno di essa, nonché la sua enunciazione ancor più accentuata, impregnano di dubbi la mente di chi ascolta, al punto che certi passi possono suonare paradossalmente preoccupanti.

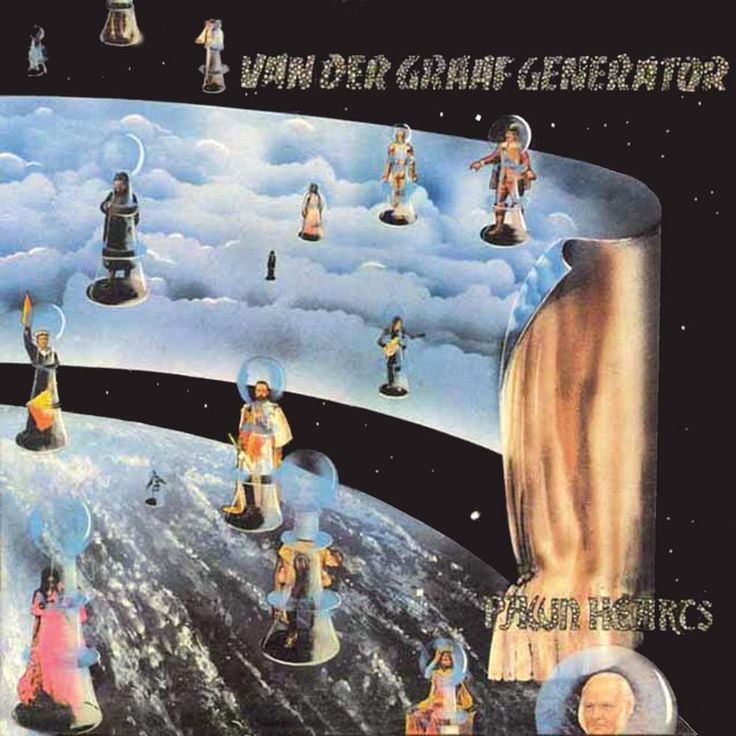
Nella musica internazionale, invece, ci sono stati artisti e gruppi che hanno lasciato il segno sotto questo punto di vista. Nel contesto inglese, possono essere annoverati due esempi di spicco. I Van Der Graaf Generator sono il primo esempio, inseriti a cavallo tra le ultime manifestazioni psichedeliche, il progressive (prog) e il proto-punk. Già dall’unione di questi generi si evince quanto questo gruppo possa essere controverso. Infatti, ha sempre rifuggito le tematiche fiabesche della corrente prog inglese, preferendo soggetti fortemente vicini allo psicodramma. Di pari passo, il loro stile musicale è sempre stato duro, crudo e rabbioso, il che ha portato la band ad essere riconosciuta tra lɘ precursorɘ del punk rock. Tutti i loro dischi sono caratterizzati da storie che narrano di personaggi tormentati, ma il picco è probabilmente il loro quarto album, Pawn Hearts (1971) per due ragioni: da un lato, la resa organica e concettuale del disco, in quanto tutte e tre le tracce mettono a fuoco temi legati allo psicodramma e alle molteplici accezioni degenerative della mente umana; dall’altro, per la presenza della suite A Plague of Lighthouse Keepers. Ventitré minuti in una pericolosa spirale nelle pieghe più bieche della psiche, in cui il guardiano di un faro, rifugiato nella sua solitudine in mezzo a una tempesta, percepisce lo scorrere del tempo e la morte delle persone a lui care – fino a sentirsi uccidere dalla tempesta stessa. Il finale, macabro dal punto di vista sonoro, è una deriva verso lo sconforto del guardiano, abbandonato a sé stesso e alla sua rovina emotiva.
Il secondo è Closer (1980) dei Joy Division. In questo caso, il contesto è totalmente diverso: si è all’inizio degli anni Ottanta, il punk ha avuto il suo effetto sul panorama musicale mondiale (soprattutto quello inglese), e ora sta evolvendo verso il post-punk, genere di cui la band di Manchester è tra lə principali esponenti. L’oscurità delle canzoni dei Joy Division è espressa magistralmente nei testi e nelle sonorità lugubri. Non a caso, questa band sarebbe stata poi citata come fonte di ispirazione primordiale per la nascita del rock gotico. Furono, in realtà, i problemi legati alla vita personale del leader Ian Curtis a causare quest’aura così cupa, per giunta quasi assente nel primo album Unknown Pleasures (1979). Proprio a causa dei suoi problemi personali, Curtis si tolse la vita a soli ventitré anni, due mesi prima della pubblicazione di Closer. Questo tragico avvenimento stimolò molto la fama della band e dell’album, ma la storia di Ian Curtis resta tra le più tristi della storia della musica.

Insomma, prendendo spunto da tutti questi contributi, si può notare come la presenza dell’ossessione nella musica sia frequente. Nel bene e nel male, non tutti gli autori qua presentati hanno vissuto situazioni del genere: da un lato, è opportuno riconoscere a questi ultimi il merito di aver costruito delle opere complete, spesso anche dai tratti drammaturgici; dall’altro, è naturale cercare di comprendere come ci si possa sentire tramite la viva esperienza di chi ha già attraversato momenti di difficoltà del genere – benché rimanga un’impressione di persone esterne alla dinamica. Certamente, l’analisi più approfondita di queste produzioni discografiche, e l’annessa comprensione degli sviluppi che hanno portato alle stesse, sono mezzi utili per la sensibilizzazione su temi spesso oscurati o lasciati in secondo piano – a volte per tabù, a volte per reticenza.
OSSESSIONE
Editoriale · L’Eclisse
Anno 4 · N° 11 · Marzo 2025
Copertina di Maria Traversa.
Hanno partecipato alla realizzazione di questo editoriale: Greta Beluffi, Bianca Beretta, Alice Borghi, Michele Carenini, Chiara Castano, Eugenia Gandini, Chiara Gianfreda, Cecilia Grandi, Rosamaria Losito, Alessandro Mazza, Marcello Monti, Valentina Oger, Erika Pagliarini, Carlotta Pedà, Rachele Pesce, Virginia Piazzese, Lorenzo Ramella, Francesca Sassano, Gioele Sotgiu, Vittoria Tosatto, Vittoriana Tricase, Marta Tucci, Maria Traversa.


