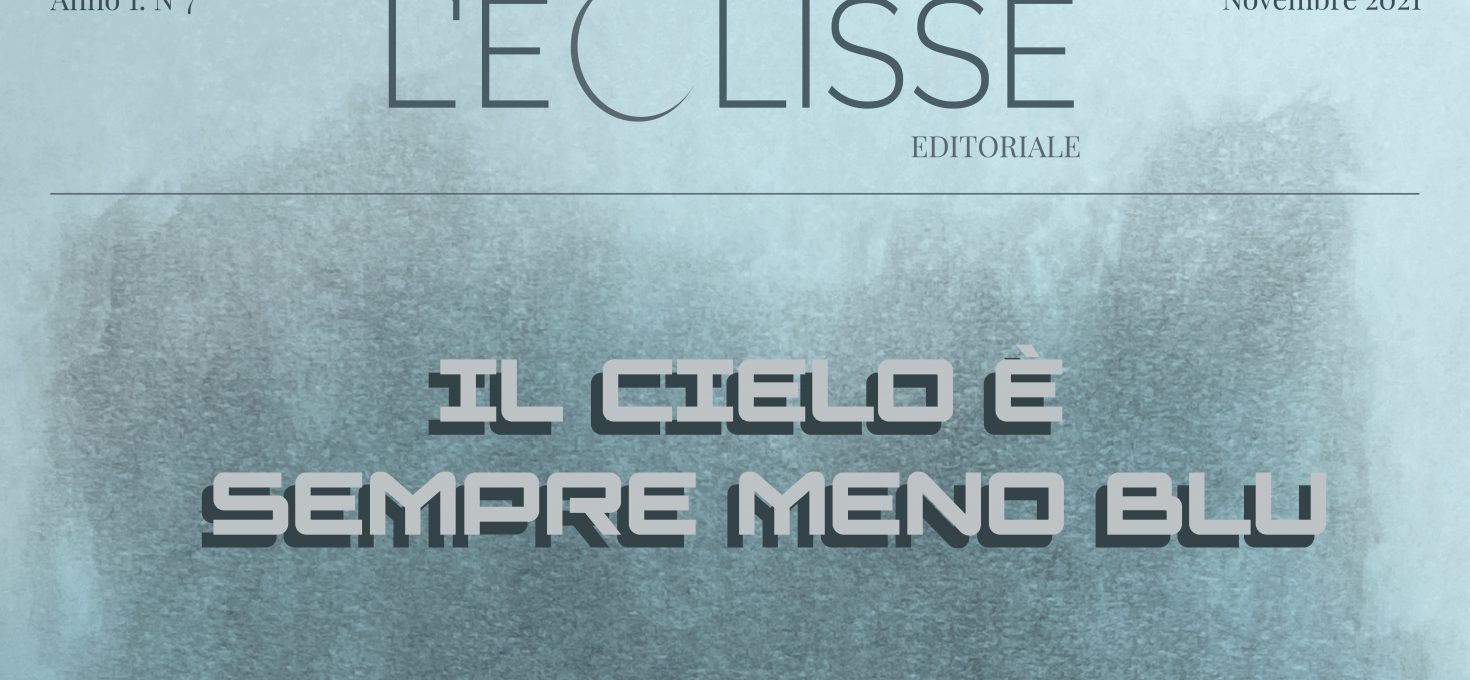Il problema energetico

“Lo scorso trimestre la bolletta elettrica è aumentata del 20%, il prossimo trimestre aumenterà del 40%. Queste cose vanno dette. Abbiamo il dovere di affrontarle.”
Così ci siamo accorti della crisi energetica. Con queste pesanti parole del Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, il 13 settembre 2021, ci accorgiamo di vivere una crisi energetica mai vista prima, inaudita per cause ed endemicità, anche se non ancora per conseguenze dirette. Sono e, probabilmente, resteranno solo un ricordo i provvedimenti di austerity del 1973, l’altra grande crisi energetica, pilotata dal cartello dell’OPEC, l’associazione dei paesi esportatori di petrolio che, all’interno del più ampio contesto della guerra arabo-israeliana, tagliarono le forniture ai paesi occidentali e aumentarono i prezzi del greggio.
L’attuale crisi, silente negli effetti se confrontata alla precedente, invece, è figlia di più genitori: si riconoscono cause non strettamente proprie del mercato dell’energia, come quelle sanitarie, geopolitiche ed economiche, e una causa strettamente propria: il cambiamento climatico e le politiche messe in atto per il suo contenimento. Ed è soprattutto questa a renderla endemica: se mai ne usciremo sarà quando, e perché, saremo riusciti a cambiare nel profondo il mercato energetico.
La situazione pregressa
Un’altra data rappresenta l’eccezionalità del periodo: il 20 aprile 2020. Nel pieno della prima crisi sanitaria da Covid-19, quando nessuno comprava petrolio, il prezzo del greggio crolla a -37,63$ al barile. Le compagnie petrolifere temono che l’elevata quantità di greggio già stoccata non consentirà già per il mese di maggio di immagazzinare il nuovo petrolio estratto. Idealmente, se quel lunedì avessi bussato alla porta di una di loro, oltre a darmi 160 litri di petrolio, m’avrebbero dato anche 37,63$ per il disturbo.
Com’è possibile esser passati in un anno e mezzo dalla nausea energetica a una straordinaria fame?
Il quadro sanitario ha giocato e gioca un ruolo di primo attore. La buona copertura vaccinale nel primo mondo ha consentito il furibondo rimbalzo economico a seguito della ritrovata piena capacità industriale: in Italia, l’aumento del PIL è atteso intorno al 5,7% per la fine di quest’anno, e, entro la metà del prossimo, avremo recuperato il tonfo del 20201, quando registrammo una contrazione del 8,9%2. Questi dati economici sono l’innesco dell’incendio che si sta propagando sul letto di sterpaglie secche dei cambiamenti climatici, alimentato dai venti caldi di una nuova guerra fredda, commercialmente già molto calda, tra Stati Uniti e Cina, e di un’altra, di dimensioni più regionali, tra gli ex di Varsavia dell’est Europa e la Russia.
Nel 2019, ultimo anno pre-pandemia con dati consolidati, il fabbisogno energetico italiano si attestava a 318,6 TWh, di cui 38,2 TWh importati dall’estero e 299,4 TWh generati internamente, di cui, a loro volta, il 60%, pari a 175,1 TWh provengono da combustibili fossili 9. Combustibili fossili che al momento in Europa non ci sono, o non possono essere usati. A fine settembre il consigliere per l’energia del dipartimento di stato americano, Amos Hochstein, dichiara:
“If we have a colder-than-average winter, my concern is that we will not be able to have enough gas to use for heating in parts of Europe.”3
(“Se avremo un inverno più freddo della media, temo che non saremo in grado di assicurare abbastanza gas per il riscaldamento in alcune zone d’Europa.”)
Non vi sono alternative
Al netto dei toni un po’ sensazionalistici, giustificabili dai giochi diplomatici tra le parti, è vero che l’Europa rischia di rimanere senza gas: con una bassa produzione interna e stoccaggi ai minimi storici, il taglio di forniture da parte della Russia in favore del mercato asiatico è dirompente. Il carbone, possibile veloce soluzione di ripiego per superare l’imminente stagione fredda, non è economicamente sostenibile all’interno dell’Unione per via delle politiche comunitarie di tassazione dell’emissione di CO2. Ciò è sicuramente un fatto positivo a livello ambientale (mettere fuori mercato pesanti fonti di gas serra è doveroso) ma, in questo frangente, ha come principale effetto collaterale quello di distorcere il mercato energetico. Quei 318,6 TWh di cui l’Italia ha bisogno, volenti o nolenti, devono essere prodotti. Con il carbone fuori mercato, per svincolarsi dal gas l’unica via d’uscita sono le rinnovabili, eolico e fotovoltaico principalmente, ma è assolutamente impossibile pensare di raddoppiarne o più la produzione in pochi mesi. Anche la sempreverde via dell’importazione dal mercato estero sembra poco percorribile, sia perché nel continente, per così dire, siamo tutti sulla stessa barca, sia perché anche le fonti energetiche estranee al panorama italiano sono sulla via del declino. I costi dell’energia fotovoltaica ed eolica sono ai minimi storici al punto che la California, stato con un portafoglio di circa 66 TWh annuali 4, ha in programma di chiudere la sua unica centrale nucleare ancora attiva entro il 2025 perché antieconomica, sostituendola con solare, eolico e accumulatori al litio 5. Inoltre, a questi tassi di estrazione, l’uranio di conveniente accesso terminerà entro un paio di secoli: un altro fatto che rende la fissione nucleare una tecnologia destinata ad essere presto abbandonata 6. Senza contare gli insoluti problemi di gestione e di non-smaltimento della scoria radioattiva. Difatti, anche la Germania ha recentemente chiuso tre sue centrali nucleari in favore di più economici metodi di produzione come rinnovabili e gas naturale.
I cambiamenti climatici, nel biennio 2020-2021, hanno avuto un ruolo centrale nel creare le condizioni affinché questa crisi energetica assumesse tali proporzioni: un inverno insolitamente freddo in Asia; in Europa, una primavera sotto le medie stagionali; l’ondata di freddo polare in Texas; estati insolitamente calde e in Nord America e in Europa, a cui, per quest’ultima, si aggiunge una riduzione del potenziale eolico espresso; calo della produzione idroelettrica in Cina e Sud America. Sono questi i principali eventi endemici al mercato energetico delle fonti fossili che hanno gravato sulla richiesta energetica mondiale già in piena ripresa consumistica post Coronavirus, portando come conseguenza il mancato ripristino delle riserve di gas che solitamente avviene nella stagione estiva. Il mondo, e l’Europa su tutti, ha fame di energia a un punto tale che gli Stati Uniti hanno, dopo anni, dato l’avallo al Nord Stream 2: il raddoppio dell’esistente gasdotto che dalla Russia arriva direttamente in Germania. Secondo Washington, un’opera geopoliticamente pericolosissima, in quanto lega, letteralmente, a doppio filo il cuore economico d’Europa allo storico nemico. Sicuramente l’attivazione della nuova infrastruttura allevierà il problema di approvvigionamento energetico per l’inverno incombente sul Vecchio Continente. Sbaglieremmo però se pensassimo di far affidamento a lungo termine sul gas russo. Entreremmo infatti in un circolo vizioso energetico-ambientale: più energia da fonti fossili implica più emissioni, quindi più fenomeni meteorologici estremi che richiederanno più energia per essere contrastati. La soluzione per uscire realmente e a lungo termine dalla crisi energetica è puntare ad un’indipendenza energetica continentale basata su fonti di cui l’Europa è certa di potersi avvalere: i venti del nord, il sole del sud, le correnti marine atlantiche e la geotermia. La transizione ecologica non è più solo una necessità di sopravvivenza per la specie umana e il mondo in generale, ora è anche una necessità economica.
Il modello energetico
L’obbligatoria transizione ecologica, realisticamente, non vedrà la luce prima di qualche decennio. Una rivoluzione ecologica non è fisicamente attuabile: non si tratta solamente di installare pannelli fotovoltaici o turbine eoliche, e ridurre il problema al mero aumento della potenza installata è una fallace banalizzazione. Collegando ogni sera il caricabatterie del cellulare, non preleviamo semplicemente dell’energia, siamo fisicamente connessi a quella che può essere considerata la più grande macchina industriale del mondo, ovvero la rete elettrica europea. La stabilità della rete è un elemento chiave della sicurezza nazionale e uno squilibrio potrebbe portare letteralmente a centinaia o migliaia di morti in poco tempo: si veda, ad esempio, il recente collasso, lo scorso febbraio, della rete del Texas, con più di 700 decessi stimati in due settimane, su una popolazione pari alla metà di quella italiana 7. Sebbene in quel caso l’innesco della crisi fosse di natura meteorologica, una gestione di rete errata potrebbe provocare gli stessi effetti: infatti, la corrente generata in una rete deve, istante per istante, collimare con la domanda, e squilibri all’interno della stessa condurrebbero a sofferenze più o meno generalizzate che, non adeguatamente gestite, sarebbero deleterie. Collegando un caricabatterie a parete, stiamo chiedendo alla rete 15W erogati in sicurezza. Nell’attuale mercato energetico fossile, col tempo, sono stati studiati e introdotti modelli produttivi tali da assicurarne la stabilità, per fornire quei 15W sia alle 04:00, quando la domanda elettrica è al minimo, così come alle 19:00, quando vi è il picco. Regolare un simile sistema energetico, dove nelle fasi di picco rispetto ai minimi è richiesta il doppio dell’energia, è molto impegnativo.
Gli impianti fossili sono, in linea generale, ragionevolmente regolabili: è possibile decidere, entro certi limiti e in certi tempi, quanta potenza immettere in rete, in funzione della richiesta. Sarà la sala di controllo a decidere le portate di combustibile e vapore elaborate. Diventa però compito improvvisamente facile se confrontato con le sfide che attenderanno i gestori di rete, in Italia TERNA, con un passaggio massiccio alle fonti rinnovabili 16. Con un modello a rinnovabili molto spinto, non sarà possibile, ad esempio, aumentare l’irraggiamento solare, in caso di necessità. I vecchi modelli, sviluppati sulle 24h per approvvigionamenti fossili certi, saranno obsoleti, in quanto vi sarà la necessità di includervi, oltre alle variazioni giornaliere, anche la forte stagionalità che contraddistingue fonti come eolico e solare, nonché la loro naturale incertezza intrinseca ai fenomeni metereologici. Per garantire la stabilità della rete nazionale, sarà fondamentale avere adeguate riserve energetiche a rapido innesco e una migliore interconnessione delle singole reti nazionali nella già ben sviluppata rete elettrica europea. L’idea alla base è semplice: un paese che, in un determinato istante, produce più energia del necessario, essendo nella stessa rete elettrica, verrà in soccorso di un secondo in momentaneo deficit. Qualora la mutua assistenza non risultasse sufficiente, si farebbe ricorso a riserve energetiche di rapida attivazione, come le batterie. Già allo stato fossile attuale, esistono riserve energetiche chiamate a subentrare nei momenti di picco: la centrale idroelettrica di Edolo, ad esempio, uno dei maggiori impianti idroelettrici d’Europa, è in realtà una “batteria ad acqua”, per circa 1000 MW di picco 8. Nei momenti d’eccesso di produzione, l’acqua è pompata da valle a monte, così da poter poi essere rilasciata nuovamente a valle quando giunge un picco da coprire. Aumentare le capacità del sistema nazionale di accumulo idrico, definito con il tecnicismo pompaggio idroelettrico, in vista di un impiego di fonti ad alta volatilità, non è attuabile, dato che qualunque bacino con caratteristiche geografiche compatibili è già impiegato; inoltre, la costruzione di bacini artificiali ex-novo avrebbe impatti ambientali enormi. Anche se spesso ventilata, l’ipotesi di utilizzare un pompaggio idroelettrico sfruttando il mare come bacino di valle non ha, al momento, avuto alcun seguito pratico. La semplice idea di un sistema fortemente interconnesso, e con un’ampia capacità di riserva energetica, trova i suoi limiti nelle realtà con cui si scontra, tecnica e politica.
Un nuovo modello energetico
Una realtà tecnica, innanzitutto. Attualmente, in Italia, l’apporto di stabilità della rete fornito da sistemi di accumulo è pari, annualmente, a 2,28 TWh, provenienti dalla componente di pompaggio idroelettrico 9, e di 253 MWh (pari a 0,000253 TWh) di accumulo da batterie, questa seconda componente, assolutamente risibile e ancora allo stadio sperimentale 10. Guardando alla California, dove i pacchi batterie per immagazzinare l’elevata produzione fotovoltaica dello Stato sono ben più diffusi, risulta chiaro come la tecnologia al litio, attualmente in uso, semplicemente non sia adatta. Pensata negli anni ’90 da Sony per avere elevate densità energetica, e sviluppate negli anni per avere pacchi batterie sempre più leggeri con cui alimentare i veicoli elettrici, le applicazioni per accumulo di energia a terra sono assolutamente fuori fuoco: lo sviluppo di queste ultime deve essere guidato da un fattore economico e non dalla leggerezza, trattandosi di applicazioni statiche. Al momento, però, quella delle batterie al litio è l’unica filiera industriale di settore a poter garantire i volumi produttivi necessari all’evasione della domanda. Filiere per batterie al calcio-antimonio, Ca-Sb, pensate appositamente per questo scopo, sono ancora in uno stadio sperimentale. Il costo di una batteria al litio al kWh si aggira sui 60$, mentre l’equivalente per una Ca-Sb è di 17$. L’ultima tecnologia di Tesla per batterie, la LFP, ha un tasso di usura ai cicli di ricarica del 15% dopo 3000 cicli: con un ciclo al giorno, dopo 8 anni, la batteria perde il 15%; la Ca-Sb invece perde il 5% dopo 5000 cicli. Ciò consente di immaginare una vita operativa di circa 20 anni e un significativo miglioramento, in termini di impatto ambientale, nella fase di produzione e smaltimento 11-12. Il green deal europeo, che prevede l’azzeramento delle emissioni entro il 2050, per essere rispettato, visti i tempi decisamente ristretti, dovrà necessariamente avvalersi del litio per la realizzazione del proprio serbatoio energetico, non avendo tempo per attendere la fioritura delle filiere industriali di tecnologie sviluppate ad hoc. Allo stato attuale, la produzione mondiale di celle al litio è al 77% in mano cinese. Entro il 2025, e ancor di più entro il 2050, la quota parte di batterie assemblate fuori dalla Repubblica Popolare andrà crescendo; celebre il caso italiano della cosiddetta gigafactory di Ivrea, ma l’approvvigionamento della materia prima sarà sempre controllato dalla potenza asiatica: il litio in Europa non c’è, e nemmeno negli Stati Uniti 13-14.
Per dare il via libera, alla Germania, all’attivazione del Nord Stream 2, gli Stati Uniti hanno chiesto in cambio un forte piano di investimenti da circa 3 miliardi di euro nel settore energetico ucraino, che inevitabilmente sarà tagliato fuori dal grosso della catena di approvvigionamenti, e, soprattutto, un appoggio tedesco al contenimento navale della Cina nel pacifico. Con Stati Uniti, Regno Unito e Australia firmatari dell’AUKUS; con la Francia che già compie operazioni navali nel mar cinese e con Germania e Italia che, più prima che poi, si uniranno; quanta voglia avrà la Cina di venderci un asset così importante come il litio? E a che prezzo? La maratona della transizione ecologica si scontra con considerazioni geopolitiche non secondarie, anche senza scomodare lontani continenti. Infatti, sebbene l’Unione Europea abbia approvato un piano da 180 miliardi di euro di infrastrutture per portare al 10% la potenza generata scambiabile tra i singoli stati entro il 2030, l’Unione come soggetto pienamente sovrano, de facto, non esiste. Le intrinseche differenze tra le nazioni che attraversano il continente da ovest a est si manterranno silenti o finiranno per minare anche la coesione energetica e di bilancio, fondamentale per finanziare la transizione? 15
Uscire dalla crisi energetica odierna significa risolvere il problema energetico, che è uno dei maggiori problemi dell’umanità. Energia pulita, a basso costo e ampiamente disponibile, sarebbe il volano per una fioritura economica anche del terzo mondo, paesi fornitori di terre rare esclusi ovviamente, liberati dal giogo coloniale del petrolio. Risolvere il problema energetico significa trovare la quadra politica e sviluppare un nuovo settore industriale per compiere la tanto discussa transizione ecologica. Significa capire come vivere in un nuovo mondo dove i problemi causati dal vecchio modello fossile si manifesteranno appieno: fenomeni meteorologici estremi sono già in atto, il pareggio di emissioni nel 2050 non ci salverà da loro. La soluzione al problema energetico è la soluzione della civiltà ed è per questo che moriremo tutti, ma in infradito e bermuda, dai ci sta, citando i The Zen Circus.
Fonti:
Dove non già espressamente indicate nel corpo.
- Dati Fitch Ratings
- Dati Istat
- “U.S. Is Concerned About Russia Limiting Nat Gas Exports”, Bloomberg, 20/09/2021
- Dati California Energy Commission
- Diablo Canyon Power Plant
- Scientific American
- 2021 Texas power crisis
- Collegio degli Ingegneri di Venezia
- Dati Ministero dello Sviluppo Economico, Situazione Energetica nazionale del 2019
- Dati Terna
- Dati Degradation of Commercial Lithium-Ion Cells as a Function of Chemistry and Cycling Conditions
- Dati Ambri
- Dati Statista
- Dati BloombergNEF
- Dati Commissione Europea
- Dati Terna
p. 3 →
← p. 2