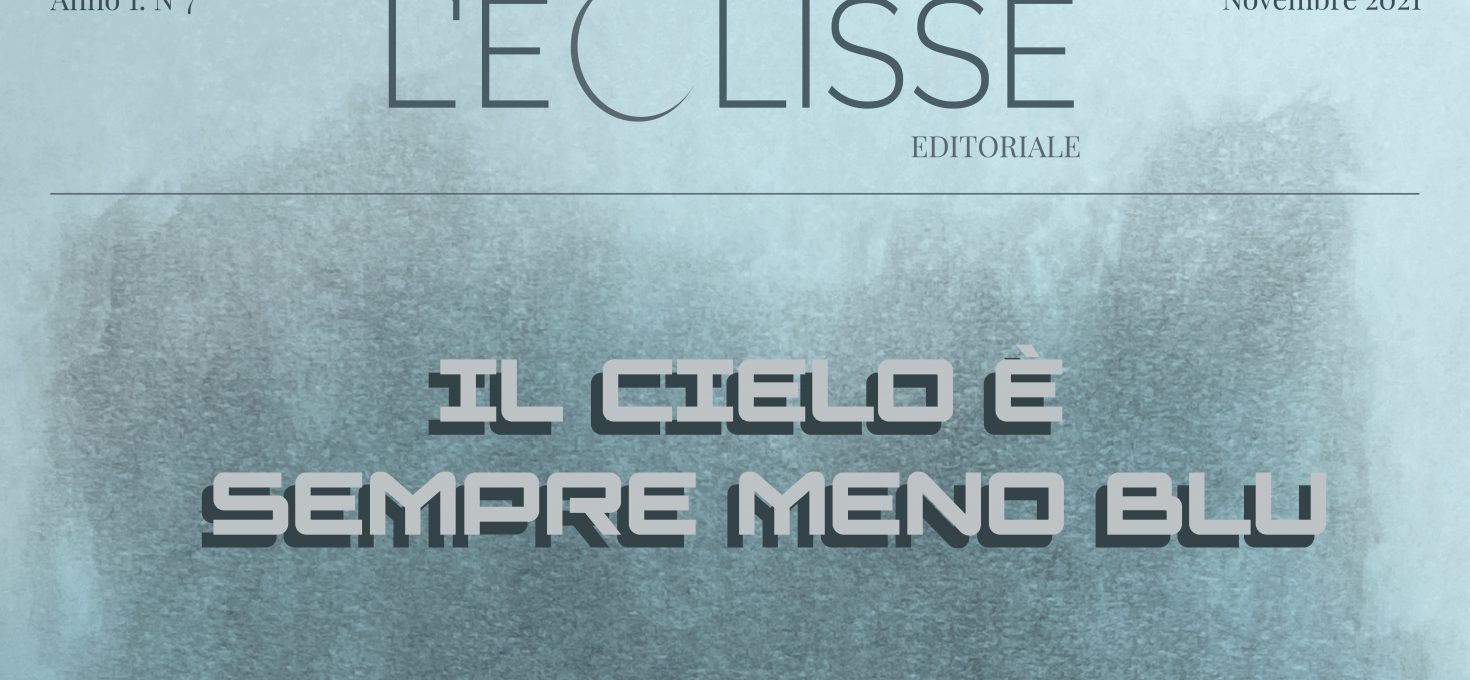Dalla Land art al fast-fashion
Qualche anno fa, mi trovavo in piazza del Duomo a Milano ad aspettare degli amici per un caffè e mi ero appoggiata alla balaustra della fermata della metro, dove, nell’attesa, mi ero persa nei miei pensieri osservando il Duomo. Ad un certo punto, mi si era avvicinato un ragazzo, che aveva esordito chiedendomi: “Ma tu ammiri spesso monumenti?”. Un approccio che mi aveva fatto sorridere e, nonostante il povero Giovanni non fosse riuscito ad ottenere il mio numero, quella semplice domanda mi aveva fatto pensare: è così strano prendersi un momento per guardare quello che ci circonda? Non siamo davvero più in grado di apprezzare l’ambiente attorno a noi, in quanto non semplice spazio in cui muoversi, ma come realtà in cui vivere a pieno?
Abbiamo perso l’abitudine di guardarci attorno, perché ormai diamo per scontato quello che ci circonda. Forse a causa dei mille impegni da cui sembra non riusciamo mai a liberarci, forse per il nostro rivolgere continuamente lo sguardo verso uno schermo o, forse, per puro disinteresse, ci dimentichiamo di apprezzare il mondo che ci circonda. Eppure, saper guardare l’ambiente ci aiuta a comprenderlo, a percepire materialmente il rapporto che instauriamo con esso e ad apprezzare le relazioni che ogni giorno stabiliamo con persone e cose. Risvegliamo il nostro sguardo dal dormiveglia in cui è quotidianamente costretto solo quando interviene un elemento di disturbo, che metta in discussione il nostro modo abituale di osservare.
Un esempio? Il 18 settembre 2021, 25 mila metri quadrati di polipropilene argentato e 3 mila metri di corde riciclabili rosse hanno avvolto l’Arco di Trionfo a Parigi, che ha dominato, con il suo tanto nuovo quanto effimero aspetto, gli Champs Elysées fino al 3 ottobre.

Il progetto dell’opera era stato pensato dalla coppia di artisti Christo Vladimirov Javacheff e Jeanne Claude Denat (in arte, semplicemente Christo e Jeanne-Claude), tra il 1967 e il 1968, ma mai realizzato fino a quest’anno. I due, entrambi defunti, sono tra i massimi esponenti della Land Art, corrente artistica nata tra gli anni ’60 e ‘70 del secolo scorso, che vede nell’ambiente e nella natura il massimo mezzo attraverso cui l’artista può esprimersi. Gli interventi in questo campo sono spesso di dimensioni grandiose e tendono a sparire nel tempo, dal momento che seguono il corso della vita della natura che li ospita. Queste opere intervengono sul paesaggio, e, nel modificarlo, trasformano anche la nostra normale percezione. Gli “impacchettamenti” di Christo e Jeanne-Claude ne sono un caso emblematico: poiché nel sottrarre l’oggetto alla vista intendono dar vita a una nuova visione. Christo stesso li aveva definiti “gentili disturbi temporanei fra terra e cielo fatti per riequilibrare le nostre impressioni”.
Questa operazione ossimorica di “mostrare nascondendo” è stata ripresa dall’artista Ibrahim Gahana, che, nel 2019, ha ricoperto i bastioni di Porta Venezia a Milano con enormi sacchi di juta. L’opera, dal titolo A Friend, intende riflettere sul consumismo imperante della società attuale e sul nostro modo di intendere la parola “confine”, in quanto limite oltre cui spingersi o entro cui barricarsi. Gahana realizza la sua opera attraverso il cortocircuito provocato dal materiale della barriera, che ci impedisce di guardare i bastioni come faremmo abitualmente (sempre se ci fermassimo a osservare). La juta, infatti, rappresenterebbe l’identità delle milioni di persone che ogni giorno lavorano in condizioni disagiate le merci destinate all’Occidente, destinate a divenire rifiuti.

L’opera si carica del significato storico legato al luogo in cui è collocato: la porta ci invita a pensare all’idea di confine, di passaggio e di connessione tra l’interno della città e l’esterno.
Inoltre, intorno agli anni ’70, nella medesima città milanese, aveva operato Christo con il suo “impacchettamento” dei monumenti di Leonardo in Piazza della Scala e di Vittorio Emanuele in Piazza Duomo.

Tuttavia, rivedere queste opere mi ha portata a pensare ad un altro tipo di impacchettamento, se così si può chiamare, sicuramente meno artistico e molto più preoccupante.
È quello che ho ritrovato nelle immagini del deserto di Atacama, in Cile: le dune di sabbia sono interamente ricoperte da tonnellate di vestiti invenduti o gettati, ovvero i prodotti del fast-fashion, di un consumismo ipertrofico in quella che, purtroppo, è una realtà tangibile e non un’opera effimera.
Quante tonnellate di vestiti dovranno arrivare ad impacchettare questo ambiente, prima che noi riusciamo a sollevare il nostro sguardo e impariamo a guardarci attorno?
Nel mio mondo utopico, l’arte, attraverso la bellezza, la provocazione e la destabilizzazione, ci permette di riflettere davvero, riequilibrando le nostre impressioni. Perciò, nel momento in cui mi fermo ad ammirare il Duomo qualche minuto in più rispetto al solito, ringrazio per il privilegio della meraviglia che ho di fronte. Ma mi chiedo anche quanto ancora possa durare, se dall’altra parte del mondo qualcuno sta contemplando opere ben diverse, non dovute al genio di un artista, ma alla nostra indifferenza verso ciò che ci circonda.
p. 5 →
← p. 4