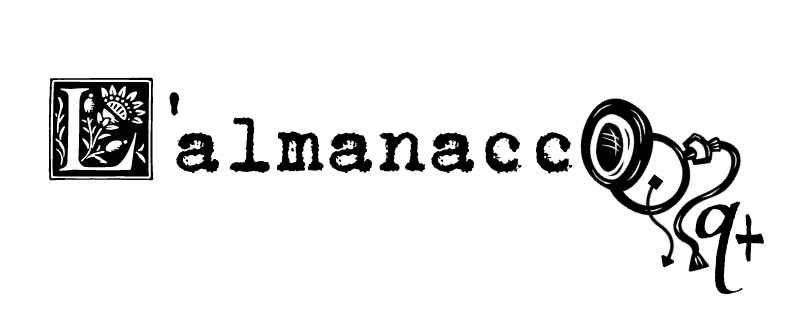Ho visto quatto quatto Cupido farsi strada
tra i fiori canterini del palco di Sanremo:
mi sa che quasi quasi lo minaccio con la spada…
«Viene febbraio, e il mondo è a capo chino, ma nei convitti e in piazza»1. Caro Guccini, mi sento di dire che in questo momento le persone sono col capo chino per Sanremo e San Valentino, più che per il credo religioso e i cortei in strada. Questo mese, l’Almanacco capita proprio nel mezzo delle fiere, ma non quelle divertenti di paese, bensì delle banalità. Non ho mai amato febbraio, se non per quel vecchio proverbio che recitava «Quando vien la Candelòra dell’inverno semo fora, ma se piove o tira vento, dell’inverno siamo dentro».
Sono anni ormai che febbraio si apre con la nota kermesse musicale nazionale e ogni anno che passa non fa che deludermi sempre di più. Non sono una critica musicale, ma la musica la ascolto e anche molto, tuttavia ritengo che anche quest’anno non ci siano state canzoni degne di nota o così innovative da rivoluzionare il desolante panorama musicale contemporaneo. Concordo con Bennato: sono solo canzonette. Come sempre, qualche canzone che si salva c’è, passando da quella di Elisa a quella di Fabrizio Moro, o anche quella di Michele Bravi… ma rimangono comunque delle eccezioni. Secondo le statistiche di italiani.coop, per quanto quest’anno la parola “amore” non risulti la parola più usata nelle canzoni di Sanremo (conteggio a suo modo falsato dalle quarantotto presenze dalla parola “chimica” nell’omonima canzone di Rettore e Ditonellapiaga, parola che compare quasi prettamente lì), rimane a prescindere la parola chiave delle canzoni di Sanremo, come è ovvio che sia.
Amore, amore ovunque e costantemente: Sanremo presenta, ancora una volta, l’amore più retorico e banale di cui l’essere umano possa essere in grado. Se per Sangiovanni l’amore è «un elastico tra i capelli» che tiene legati, per Noemi «è un proiettile» di parole che divide; e ancora, Mahmood e Blanco portano uno dei motivi più in voga di Sanremo, ovvero l’incapacità di esprimere il proprio sentimento: «ti vorrei amare ma sbaglio sempre», dicono, così come per Michele Bravi c’è la costante paura, per questa incapacità, «di perderti da un momento all’altro»; per non parlare di quella ragazza, Ana Mena, di cui non sapevo nemmeno l’esistenza, che ci ricorda che l’amore deve fare male. Potrei andare avanti, ma credo che sia abbastanza chiaro dove io voglia andare a parare. Queste canzoni, anzi, questo insieme di parole ammassate, sono animate tutte da quell’idea di amore vissuto con estrema sofferenza o perché non corrisposto o perché minacciato da qualche avversità. Per la serie: se l’amore non è sofferto non è amore? Purtroppo, mi tocca constatare che Sanremo sia solo uno specchio di quella che è la scena musicale contemporanea e che, quindi, porti semplicemente alla luce questa desolazione e questa povertà di contenuti.
Sicuramente, Sanremo contribuisce a fornire colonne sonore per il 14 febbraio, ovvero San Valentino, e tutte queste “canzoni” verranno in soccorso di tutti gli innamorati intrisi di sottocultura adolescenziale in preda ai loro primi tormenti d’amore e all’eccessivo glucosio nel sangue da endovena di cioccolatini. Ironia a parte, è davvero questo lo scenario a cui stiamo assistendo? È davvero questo il nuovo volto del romanticismo? A quanto pare, sì.
Eppure non è sempre stato così. Qualche giorno fa, mentre camminavo per strada col mio solito paio di cuffie, con attiva la riproduzione casuale di Spotify, mi è ricapitata sottomano, anzi, sott’orecchio, una canzone che, nel suo ritornello, pronunciato quasi con un filo di voce e dove è la chitarra a parlare, dice ripetutamente: «Forse non lo sai, ma pure questo è amore». Sto parlando di Stranamore (1978) del prof. Vecchioni. Si tratta di una canzone complessa, ma che, come nelle migliori delle sue storie e nel suo stile, a mio parere, inimitabile, ci presenta una carrellata di modi diversi di amare. Sofferti alcuni, sì, ma non necessariamente romantici. Anzi, di romantico questa canzone ha ben poco. Tornata a casa, mi si è accesa la lampadina e ho pensato: “Allora, forse, un altro modo di amare e di amore c’è: siamo noi a non vederlo”. Penso proprio che sia giunto il momento di disintossicarci da questa “overdose d’amore” sanremese e di boicottare l’insignificante San Valentino: cercherò di farvi fare un viaggio tra le note dell’amore “altro”, ma a modo mio, con il mio solito quid in più.
- Quello che io ero tu sei, quello che io sono tu sarai (Nonno Libero)
Ci sono dei momenti nei quali vorremmo avere le parole giuste per dire “ti voglio bene”. Credo che più sia sentito, più sia difficile da dire, soprattutto guardando negli occhi quella persona, forse perché ci sentiamo ridicolǝ e messǝ a nudo. Non sono ancora madre, ma sono figlia: sono due mestieri difficilissimi, che, messi insieme, fanno una grande squadra. Non starò qui a dirvi quante canzoni siano state scritte in occasione della nascita, da Avrai (1982) di Baglioni, a Fiore di Maggio (1984) di Concato, a A modo tuo (2013) scritta da Ligabue e cantata anche da Elisa, fino a tutte le canzoni che dei figli portano i nomi. Vi parlerò, invece, della forma di amore che conosco, quello che provo da figlia. Nella frenesia del quotidiano, spesso, ci dimentichiamo che quella che chiamiamo mamma è, prima di tutto, una persona con un suo nome, una sua identità, che va oltre quel ruolo. Si diventa madre e figlia nello stesso momento, iniziandosi a considerare tali da quel momento e lo si resta per tutta la vita, ma c’è un punto in cui si prende coscienza reciproca di essere individui, prima che ruoli. Mi piace ascoltare mia madre raccontarmi della sua infanzia e della sua adolescenza, perché, dai suoi racconti, così come accadeva quando ascoltavo i racconti dei miei nonni, ho imparato molto del delicato «mestiere di vivere». Quando non lo fa lei, le chiedo io di farlo, proprio come Barbarossa faceva con la sua di madre, in quella bellissima poesia che è Portami a ballare (1992):
Parlami di te di quello che facevi se era proprio questa la vita che volevi di come ti vestivi di come ti pettinavi se avevo un posto già in fondo ai tuoi pensieri.
Con l’avanzare dell’età adulta, quello con i genitori diventa un rapporto su cui si può contare quasi alla pari, come un’amicizia, una complicità nella quale poter dire all’altra persona, “come io ho potuto contare su di te, ora potrai contare anche tu su di me e su quello che da te ho imparato”. Infatti, Ermal Meta, che meglio di chiunque altro sa cosa significhi amore, ma anche e soprattutto paura, si è sentito di dire proprio questo a sua madre in Vietato morire (2017), trasformando il dolore della donna in qualcosa che ripagasse il dolore stesso e la sua resilienza:
E la fatica che hai dovuto fare
Da un libro di odio ad insegnarmi l'amore
Hai smesso di sognare per farmi sognare
Le tue parole sono adesso una canzone.
Con questa canzone, Meta ha anche partecipato a Sanremo di quell’anno. Arrivò terzo. Non vinse, ma, per quanto mi riguarda, ha vinto la gara più importante: il riscatto dal dolore.
- È il desiderio di non si sa cosa (Antoine de Saint-Exupéry)
Nostalgia è l’unione dei termini greci nòstos, ritorno, e àlgos, dolore: “dolore del ritorno”. Il mese scorso, De Andrè è stato protagonista del mio filosofeggiamento in quel suo verso, “la memoria è già dolore”, in quanto penso proprio che la nostalgia, più che il dolore per il ritorno, sia il ritorno del dolore dato dalla memoria dei ricordi. Quando si ha un dolore dentro, temo che non ci abbandoni mai. L’anima lo mette in disparte, ma, in qualche suo anfratto, rimane sempre lì rintanato ed esce quando la nostalgia si fa più densa. Se potessi dirle qualcosa, alla nostalgia, chiederei in prestito le parole a Cocciante, che le scriveva:
Cara celeste nostalgia
Un'ora, un giorno, una vita
Che cosa vuoi che sia, resti mia.
Chi conosce Cocciante sa che è un sentimento che aleggia costantemente nelle sue poesie in musica. In Celeste nostalgia (1982), appunto, quella malinconia è legata al ricordo di un amore che non si è compiuto e che sarebbe potuto essere:
Vederti un istante sopra un treno
Partire su un auto e andar lontano
Quel lampo negli occhi, ciao
D'accordo fa male, ciao, ma tu
Dentro di me non muori più.
Nella mia vita, questa canzone è sempre stata un po’ come l’eco che rimbomba, ma nel mio stomaco. Spesso, la nostalgia passa anche per i ricordi che gli oggetti ci riportano alla mente, infatti Carillon (1975) di Baglioni ce lo racconta bene in quel lungo elenco, dal sapore crepuscolare, degli oggetti di un vecchio salotto e di quella fotografia, ciò che rimane all’anziana protagonista lasciata sola con le note di quel carillon scordato:
adesso ti han lasciato sola
adesso son fuggiti via
e forse un poco ti consola
la tua fotografia...
La nostalgia negli oggetti richiama anche quella dei tempi andati, magari quelli dove Diamante e Delmo, i nonni di Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, uscivano dalla guerra insieme e costruivano il futuro dalle macerie, facendo «fiorire i nevai»2. Sentire Diamante mi riporta sempre con la mente alla mia infanzia: la ricordo come la canzone dei miei sonni di bambina. E di qualche carezza.
- O patria mia, vedo le mura e gli archi […] ma la gloria non vedo (Leopardi, All’Italia)
Il 2021 lo ricorderemo com l’anno dell’Italia, un anno nel quale, come popolo, abbiamo vinto tutto quello che potevamo vincere: Europei di calcio, Eurovision, Olimpiadi, Paralimpiadi, persino i campionati di pasticceria. Abbiamo esultato, pianto e gridato di gioia, come è giusto che sia. Abbiamo sentito vivo l’orgoglio di essere italiani, di mostrare al mondo, sempre con orgoglio, la nostra bandiera. Le Olimpiadi invernali sono iniziate ormai da qualche giorno e abbiamo già vinto alcune medaglie… peccato che non ci abbiamo fatto caso un granché: eravamo troppo presi a cantare “viva l’amore”. Siamo patriottici solo quando ci fa comodo. Nella già citata Stranamore, c’è un uomo che, per difendere il suo grido, “viva la libertà”, è stato picchiato per questa scelta, tanto da pensare:
ora gli dico “Sono anch’io fascista”
Ma ad ogni pugno che arrivava dritto sulla testa
La mia paura non bastava a farmi dire basta.
Credere nei propri ideali è una scelta politica, proprio come ha fatto Giovanni Truppi in questo Sanremo appena conclusosi, decidendo di indossare sempre e solo canotte e di omaggiare, nella serata delle cover, il Faber Nazionale con la sua Nella mia ora di libertà. Per ideali si muore ingiustamente. Ce lo ricorda bene Guccini con la storia di Jàn Pàlach, lo studente protagonista della sua Primavera di Praga (1970) che, come Jan Hus, si bruciò vivo nel 1969 in Piazza San Venceslao, come gesto di protesta per la situazione del paese durante la Guerra Fredda. Le parole del cantautore credo parlino da sè:
Ma poi la piazza fermò la sua vita e breve ebbe un grido la folla smarrita quando la fiamma violenta ed atroce spezzò gridando ogni suono di voce. […] quando ciascuno ebbe tinta la mano, quando quel fumo si sparse lontano Jan Hus di nuovo sul rogo bruciava all'orizzonte del cielo di Praga.
De Gregori diceva che siamo noi a fare la Storia, «siamo noi che scriviamo le lettere, che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere»3. Lo sapeva bene anche Peppino Impastato: «la voglia di Giustizia che lo portò a lottare»4 costò la vita anche a lui, che morì per mano della criminalità organizzata lo stesso giorno in cui Aldo Moro fu ucciso in via Caetani a Roma, nel 1978.
C’è «l’Italia che si innamora», certo, quella di Sanremo e quella dell’orgoglio di convenienza, ma c’è anche quella «che si dispera», ma quella stessa Italia è quella per cui diciamo e ci fa dire «Viva l’Italia, l’Italia che resiste»5, soprattutto dopo questi due anni.
- Forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo… (G. Gaber)
«…Son fiero e me ne vanto, gli sbatto sulla faccia cos’è il Rinascimento»: Io non mi sento italiano (2002) di Gaber è un pezzo eclettico ed ossimorico, esattamente come lo era Gaber stesso: da un lato, c’è l’amarezza dell’«Italia da dimenticare»6, dall’altra traspare l’amore per il nostro Belpaese.
Il nostro è un paese dalle mille anime per la sua varietà dialettale, con una cultura artistica, letteraria, culinaria, geografica, lirica e musicale invidiata dall’Europa e dal mondo. Vi farò fare un veloce viaggio per alcuni luoghi del nostro Paese (cercherò di rendere giustizia ai luoghi che non conosco o che conosco poco), attraverso le note di chi quelle strade le ha respirate di persona, trasmettendocene luci e ombre. Entriamo da ovest e ci troviamo in Liguria, patria che ha dato i natali alla scuola genovese: Paolo Conte, Bruno Lauzi e De Andrè. Ricordiamo bene Genova per noi (1975) di Paolo Conte, ma quando sento Crêuza de mä (1984) di Faber, complice quelle note ispide del genovese (nella storia della musica italiana, è stato, in effetti, la prima volta che un cantante di una certa fama consegnasse al mercato un album completamente in dialetto), chiudo gli occhi e sento il ricordo del vento del porto di Genova e l’odore dei suoi carrugi. Infatti, la canzone descrive una scena di vita quotidiana, ovvero il ritorno dei marinai dalla pesca e un pasto a base di «paciûgu in aegruduse de lévre de cuppi» (“pasticcio in agrodolce di lepre di tegole”, che è una pietanza che, in effetti, non esiste).
Poi voliamo a Milano, terra del varietà di Gaber, di Dario Fo e Jannacci, ma anche e soprattutto quella delle «Luci a San Siro di quella sera», dove «ricordi il gioco dentro la nebbia»7, ma anche quella «che quando piange, piange davvero» e «perduta dal cielo, tra la vita e la morte[…]»8.
Da Milano iniziamo a scendere e sbarchiamo in Emilia, «sognante fra l’oggi e il domani, di cibo e motori, di lusso e balere»9, andiamo a Bologna, che tutti ricordano come «una vecchia signora dai fianchi un po’ molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli»10. Dall’Emilia alla Toscana, il salto è breve in quella Firenze dove «gli occhi di marmo del Colosso Toscano guardano troppo lontano»11. E finalmente Roma, la mia amata: c’è Roma vissuta come un sentimento, dove «la luna se specchia dentro ar fontanone» e «le finestre so’ tanti occhi», con «la maestà der Colosseo» e «la santità der Cuppolone»12, e c’è Roma con la propria anima, fatta di strade, come via Margutta, la via degli artisti, «dei giovani poeti e dei loro amori consumati di nascosto in un caffè»13, dove
Ci sono facce nuove
E lingue da imparare
Vino da bere subito
E pane da non buttare
E musica che arriva da chissà dove.
Roma è tutto questo e uno spirito simile, ma ancora più caloroso, si respira anche a Napoli, per la quale Bennato, ne La mia città (2012), riesce a trovare ben cinquantasei aggettivi, alcuni più lieti, altri meno: è rassegnata, ma anche innocente, è appariscente, invadente, ma anche invidiata, dolce, ammaliante e scanzonata. Nel bene e nel male, come ci dice il cantante alla fine di ogni strofa, «è la mia città». Poi, c’è Caparezza e la sua Puglia, sua croce e delizia: in Vieni a ballare in Puglia (2008), canzone apparentemente ironica, dopo aver costruito una satira pungente che mette in luce i crimini commessi dai poteri forti nei confronti dell’ambiente, dal Gargano che brucia, dall’inquinamento intensivo alla criminalità organizzata, nell’ultimissima strofa, al ritmo di una taranta, canta:
O Puglia Puglia mia tu Puglia mia Ti porto sempre nel cuore quando vado via E subito penso che potrei morire senza te E subito penso che potrei morire anche con te.14
Perché Caparezza la sua terra, «amara e bella», come avrebbe detto Modugno, la ama e anche molto (chissà, magari un giorno vi parlerò del mio amore segreto per questo genio assoluto…).
Concludo come ho iniziato, con Gaber: «Io non mi sento italiana, ma per fortuna o purtroppo… per fortuna lo sono».
Non ho ancora finito: ma pure questo è amore?
Se avete resistito fino a qui, vi ringrazio per aver dato fiducia alle mie parole e spero di essere riuscita nel mio intento. Amo la musica e sono cresciuta anche e soprattutto ascoltando questa musica, quella dei grandi della nostra tradizione musicale. Una musica nella quale, questi artisti, non vedevano solo una passione, ma anche un’esigenza, un mezzo per dire davvero qualcosa e non solo per parlare di amore fine a sé stesso. Potrebbe sembrare fermo il mio orologio, ma, come dicevo già all’inizio del discorso, mi risulta difficile trovare quelle ragioni nelle canzoni di oggi, così vuote e prive, più che di senso, di impegno. Questo significa che la musica ha senso solo se impegnata? Assolutamente no: è bello sentire Guccini, Dalla, Caparezza, così come Mengoni, Francesca Michielin o Gabbani, che sono comunque cantanti che fanno un certo tipo di musica, con una precisa impronta e con un messaggio chiaro ed inequivocabile. È difficile ritrovarsi se il mercato discografico, da molti anni a questa parte, propone la trap da un lato e l’indie dall’altro, due generi che, come diceva Motta in un video delle Coliche, “sono la stessa cosa”.
Una volta, qualcuno disse che la musica, per definirsi tale, deve parlare dell’individo, per l’individo e all’individuo. Di certo, in una musica che propone una certa immagine di donna, vista come un oggetto da possedere sessualmente o da definire come essere perfetto o che parla solo ed esclusivamente per metafore senza alcun logico senso linguistico, mi riesce difficile riconoscersi e sentirsi rappresentati. Non è una musica che parla al cuore… non è proprio una musica che parla e se la musica, che è il veicolo più forte di messaggi, parla male, chi ascolta recepisce male: è un sillogismo logico. Molte delle canzoni di questo “festivàl” non hanno fatto altro che portare avanti, seppur indirettamente, una cultura sessista, fatta di stereotipi anche quando apparentemente sembrano non esserci. Per farvi un esempio, vi propongo solo queste tre frasi:
Stavi cercando un tipo, qualcosa che non ho/ Un altro un po’ più freddo ma io no, io c’ho trentotto gradi in corpo: Tananai.
Frasi scritte per metà, se vere non lo so/ Anche tra i grattacieli volerò/ E lasciati andare/ Che il cuore ti cade giù/E l’amore riappare: Matteo Romano.
E sorridi/Perché quando lo fai tu mi uccidi/ I tuoi occhi il tuo corpo i vestiti/ Quelli miei che indossavi/ Così con te avevi una parte di me: Aka 7even.
Pure questo è amore? No che non lo è: è banalità.
…parlo tanto, non mi dire,
tra versi e canzoni,
tra emozioni e riflessioni;
al prossimo mese, tutto da sentire.
- Canzone dei dodici mesi, 1972, Guccini.
- Diamante, 1991, Zucchero
- La Storia (siamo noi), 1985, F. De Gregori.
- I cento passi, 2004, Modena City Ramblers.
- Viva l’Italia, 1979, F. De Gregori.
- Viva l’Italia, 1979, F. De Gregori.
- Luci a San Siro, 1971,Vecchioni.
- Milano, 1979, Dalla.
- Æmilia, 1990, Guccini.
- Bologna, 1981, Guccini.
- Firenze canzone triste, 1980, Ivan Graziani.
- Roma Capoccia, 1972, A. Venditti.
- Via Margutta, 1987, L. Barbarossa.
- Per le strade di Roma, 2006, De Gregori.

di Marta Urriani
Mi chiamo Marta Urriani, classe ’98, e studio Lettere Moderne all’Università La Sapienza di Roma. Ho una folta chioma di capelli ricci, tanto che tutti mi chiamano Mafalda, come la bambina dei fumetti di Quino, con la quale ho molto in comune (e non solo i capelli). Cercando di sopravvivere alla vita universitaria, con il caffè di giorno e la camomilla di sera, leggo e scrivo. Mi interesso soprattutto di letteratura italiana e temi femministi.