Che cosa significa essere donna?
No, non sono impazzita né tantomeno pretendo di rispondere a questa domanda, dal momento che ho solo ventitré anni e della vita ne so ancora troppo poco. Eppure, quel poco mi è bastato per rendermi conto di quanto l’appartenere a questo sesso sia quasi un mestiere. Fin da piccole, infatti, ci accorgiamo subito quanto l’educazione da noi ricevuta sia diversa da quella dei maschi e di come ci risuonino nella testa una lista di comportamenti stereotipati, imposti come qualcosa di “naturale” e “convenzionale”, per il semplice fatto di appartenere ad un genere preciso: “comportati da signorina”, “stai dritta con la schiena”, “non urlare”, “non correre”, “stai buona”, “stai composta”, “col caratteraccio che hai non lo troverai mai un fidanzatino” e così via.
Ho capito come questi stereotipi siano la variabile che condiziona ogni aspetto della vita adulta, soprattutto quella sociale. Così, dal “comportati da signorina” dell’infanzia il passaggio è breve, ad esempio, all’avere il timore, anche vago – costantemente represso –, di camminare per un viale, la sera, tornando a casa dopo l’ultima lezione della giornata universitaria. Oppure la mattina dell’esame, nonostante tu ti senta forte della tua preparazione teorica, guardando l’armadio – e lo specchio –, porti l’annosa questione di cosa indossare per presentarti davanti al docente ed evitare che la tua valutazione possa essere condizionata da un certo abbigliamento, consapevole che il tuo collega maschio questo problema non lo ha, semplicemente perché è un uomo e la sua valutazione finale dipenderà solo ed esclusivamente dalla sua preparazione.
Altri casi sono il vedere la spartizione delle mansioni domestiche non rispettata da un compagno o, ancora peggio, avere il vago pensiero, di tanto in tanto, che quella persona al tuo fianco, un giorno, possa diventare il tuo carnefice senza un perché.
Posta così, l’essere donna sembrerebbe quasi un inferno fatto di continui ostacoli ed ingiustizie, eppure io sono felice di essere una donna. Anni di letture, soprattutto delle scrittrici, mi hanno dimostrato come essere donna faccia la differenza soprattutto nella scrittura e soprattutto perché sono riuscite a liberarmi da quel senso di colpa, spesso indotto, dell’essere donna. Proprio in una scrittrice a me molto cara, Chimamanda Ngozi Adichie, nel suo breve saggio Dovremmo essere tutti femministi (2014), ho trovato una voce amica che mi ha detto:
Ho deciso di non scusarmi più per la mia femminilità. E voglio essere rispettata con tutte le mie peculiarità di donna. Perché me lo merito. Amo la politica, la storia e le belle discussioni. Ho gusti femminili. E sono felice di averli. Mi piacciono i tacchi alti e mi piace provare rossetti nuovi. Mi piace ricevere complimenti da uomini e donne (anche se, a essere sincera, preferisco quelli fatti da donne eleganti), ma spesso indosso abiti che gli uomini non apprezzano o non «capiscono». Li indosso perché mi piacciono e perché mi fanno sentire bene. Lo «sguardo maschile» influenza solo marginalmente le mie scelte di vita.
Adichie, C. N., Dovremmo essere tutti femministi, Einaudi, Torino, 2014, pp.22-23
«Voglio essere rispettata con tutte le mie peculiarità di donna. Perché me lo merito». Forse, è proprio questa affermazione che mi ha liberata e che mi risuona sempre forte nella mente l’8 marzo, Giornata internazionale della donna. Certo, come sempre affermerò (come già avevo fatto presente lo scorso 25 novembre), l’idea che esista una giornata apposita per ribadire l’affermazione del mio sesso mi fa sempre pensare come di strada ce ne sia ancora tanta da fare perché si smetta di avere bisogno di una giornata apposita, in quanto, fino ad allora, vuol dire che sessismo, discriminazione, subordinazione e disparità sono variabili ancora radicate e che il divario di genere è ancora una lacuna incolmata.
Per sdrammatizzare un po’ il tono fin troppo sacrale della mia trattazione, voglio proporvi un testo a me molto caro e che, seppur scritto da un uomo, a mio parere racconta il mondo delle donne in una chiave umana, realistica, con ironia e, soprattutto, non con quell’occhio scientifico maschile tanto criticato da Virginia Woolf su Una stanza tutta per sé, con cui spesso gli scrittori raccontano la donna e le donne, senza conoscere il mondo delle donne e arrogandosi il diritto di parlarne solo per il semplice fatto di essere uomini.
Chi ha sentito parlare di Stefano Benni lo conosce soprattutto per il mondo che racconta in Bar Sport. Tra tutte le sue opere, soprattutto quelle scritte per il teatro, c’è un piccolo testo che, sul retro di copertina, porta una semplice dicitura senza alcun orpello narrativo: «Otto monologhi per voce femminile». Sto parlando de Le Beatrici (2011). Proprio perché nasce come insieme di monologhi, quindi non come un romanzo o come qualsiasi genere inscrivibile nel fictional, l’intera opera arriva in modo più immediato, rivolgendosi sì a tuttǝ, ma arrivando soprattutto alle donne, anche e soprattutto perché Benni, nella stesura dei singoli monologhi, probabilmente aveva già davanti ai propri occhi l’attrice che avrebbe interpretato quella specifica personaggia. Con le donne portate in scena, ognuna di noi può sentirsi realmente rappresentata nella personaggia stessa o in alcune delle sfumature o delle tematiche narrate.
Veniamo introdotte nel mondo delle Beatrici con la Beatrice di Dante, appunto, che, però, con la Beatrice del Sommo ha ben poco a che fare. Infatti, non ci troviamo davanti la donna-angelo cantata dal poeta, ma una ragazza giovane, sagace e sarcastica, che, per diletto, canta in rima e legge i tarocchi non solo per avvertirci di stare lontane da certi uomini di potere dediti a certe “attività ricreative”, ma anche e soprattutto per trovare un destino diverso da quello che, in quanto donna del suo tempo, le sarebbe spettato: un matrimonio combinato e una possibile morte per parto. Beatrice, qui, critica aspramente il motivo della donna-angelo molto caro al Sommo,
«Io sono una donna, mica una serenata… mica posso aspettare che abbia finito il capolavoro e che mi abbia angelicato e intanto io buona e zitta»
Benni, S., Le Beatrici, Feltrinelli, Milano, 2011, p. 9; tutte le citazioni sono tratte dalla seguente edizione.
e, giustamente, rivendica il diritto di vivere la propria giovinezza, di innamorarsi e, perché no, di corteggiare un aitante giocatore di calcio fiorentino, il Battistone. Ed è proprio sulle ultime battute, a tu per tu con il pubblico e rompendo la quarta parete, che Beatrice esprime la propria dichiarazione d’intenti:
Non sono angelicata? Non sono seria? E chi l’ha detto che devono scegliere loro? Basta col poeta che si sceglie la donna ispiratrice, d’ora in avanti i poeti ce li scegliamo noi.
Ivi, p. 13.
Forte della sua nuova intenzionalità, Beatrice lascia la scena canticchiando versi di speranza, lasciando spazio alla nuova beatrice, ovvero una ragazzina di nome Angie, definita da Benni stesso, «la mocciosa». Come tutte le adolescenti, è al telefono con la sua amica del cuore, Deborah, per spettegolare di un’amica comune, una certa Federica. Tutto sarebbe nella norma, se Federica non fosse una matricida: la ragazza, infatti, aveva ucciso, il giorno precedente, la propria madre, donna con lavoro precario e sotto psicofarmaci, in quanto non le aveva dato dei soldi per poter andare dal parrucchiere per farsi realizzare un taglio di capelli per compiacere il mitico fidanzato Kefin, «che poi sarebbe Kevin, quello che si è depilato le sopracciglia alla Fiorello, quello che si mette il gel sui peli del petto»1.
Tra il linguaggio politicamente scorretto e una satira pungente su romanzi di successo del decennio scorso, come Tre metri sopra il cielo (1992) – l’antesignano di tutti gli young adult e l’inizio della rovina della letteratura – questo risulta forse uno dei monologhi più spietati di tutta l’opera o, perlomeno, quello dallo stile più tagliente e tragicomico: porta sul palcoscenico, oltre che il dramma quotidiano – che si esplica non solo nel finale, assolutamente antiretorico, dissacrante, ma anche nel racconto di fenomeni sociali attuali come il revenge porn messo in atto da Kevin verso Federica – non solo le difficoltà incontrate dalle adolescenti contemporanee, soprattutto quell’assenza costante di valori ed equilibrio, ma anche le contraddizioni di una generazione che gioca a fare gli adulti:
[…] E insomma, Fede salta addosso alla mamma e cerca di strapparle i capelli per farsi la coda, e la mamma egoista sai cosa le dice? “Ahio, sono i miei”, capisci? Ci tiene più ai suoi capelli che alla figlia, allora lei prende un coltello […] le dà zac zac zac ottantasei coltellate… […] insomma la vita è un cielo azzurro ma spesso si riempie di nuvole rosso sangue.
Ivi, p. 21
Spietata è anche la figura della Presidentessa, ovvero una manager in carriera che si è costruita da sola e con la passione per la cucina, che risolve il problema degli esuberi della propria azienda in un modo decisamente “alternativo:
[…] Io unisco all’antica arte femminile di utilizzare gli avanzi il nuovo variopinto illusionismo e la creatività di grandi chef maschi […] Il risultato eccolo qui [mostra un piatto fumante], questo lavoratore che era cattivo e rivendicativo adesso è buono. Una volta si chiamava sfruttamento, adesso “ottimizzazione delle risorse”. Volete… assaggiarvi?
Ivi, pp. 31-2.
Alla Presidentessa segue sulla scena Suor Filomena, una suora molto particolare: altamente bipolare, in suor Filomena, nel corso del suo flusso di coscienza, di tanto in tanto e a suon di rime, esce fuori la sua alter ego indemoniata e molto combat girl che, tra il crudo ma ironico realismo e improvvisate mosse di karate, ci racconta della sua vocazione non per l’Altissimo, bensì per san Giorgio Clooney. Suor Filomena, infatti, di pietas e devozione peculiari dell’avere il velo ha ben poco: ci racconta, infatti, di essere stata costretta a prendere forzatamente i voti dal padre, essendoci in famiglia troppe bocche da sfamare – e lei stessa dice di essere stata fortunata rispetto ad alcune delle sue sorelle, avviate alla strada della prostituzione. E, proprio sul finale, nella modalità ormai consolidata di tutti i monologhi qui presenti, si lascia ad una confessione umana, a modo suo intrisa di dolcezza, ma al contempo amara ironia:
Sono qui per sfortuna, io volevo fare la ballerina, [si toglie il velo, sparge i lunghi capelli] ho ventotto anni, sono ancora giovane. Ma se esco dove vado in questo mondo crudele e laido? Però non ho voglia di stare da sola, allora va bene anche un diavolo che ti tiene un po’ compagnia, amore mio, così mi piaci, voglio solo te, vaffanculo Belzebù, lo so che entri dentro tutte…
Ivi, p. 46.
Se Suor Filomena di pazienza ne ha poca – e niente –, di pazienza ne ha tanta, invece, la donna dell’Attesa, l’unica donna dell’opera che non ha particolari connotazioni di genere, che ci racconta di quel senso di morsa allo stomaco che ci prende, soprattutto a noi donne, quando, per qualche ragione, piacevole o non, aspettiamo. Ma cosa aspettiamo?
«Che importanza ha? Un amante, un marito, un figlio, una figlia o… un medico con un verdetto, un assassino col coltello, forse uno sconosciuto. L’importante è che io ora vivo in questa parte dell’universo, nel pianeta dell’attesa, separato e diverso dal pianeta di chi non aspetta nulla e nessuno».
Ivi, p. 49.
Nel monologo, la donna critica aspramente, ma sempre con poesia, come chi aspettiamo, spesso, non si preoccupi minimamente della premura di chi l’attende, situazione che si ribalta quando siamo noi ad essere nei panni di chi si fa attendere, facendo provare quella stessa angoscia, fatta di sussulti, all’altra persona.
Se fino a questo punto dell’opera Benni ha cercato di usare sempre lo strumento dell’ironia, negli ultimi tre monologhi sembra metterla momentaneamente da parte. Quelle della Vecchiaccia e di Volano sono due storie a sé, due voci crude che sembrano l’una il naturale completamento dell’altra. Vecchiaccia è una donna indurita dalla vita, una vita non semplice, fatta di una guerra che le ha strappato via l’uomo che amava, di violenza domestica, di un corpo che, nell’ormai tramonto della vita, non le risponde più, quando in giovinezza era invece un corpo bello e desiderato da uomini e da donne. Un monologo che riflette su una vecchiaia sempre più dimenticata, sempre più svalutata e considerata un peso sociale, non come una risorsa e un arricchimento, destinata, ormai, ad una casa di riposo. In un flusso di coscienza lungo, confuso e apparentemente delirante, Vecchiaccia ci porta attraverso i suoi ricordi e le sensazioni amare provate nel presente dove, a farsi strada, è la consapevolezza di un futuro fatto di rabbia, solitudine e di abbandono, un destino segnato quasi quanto quello di suor Filomena:
Tutta la mia vita in una valigia piccola così avevamo messo, e abbiamo percorso in macchina questo bel viale di platani e in fondo c’era la casa di riposo moderna coi vetri illuminati dal sole sembrava una fabbrica ricicla-vecchiacce un vecchiodromo ecco […]
Ivi, p. 70.
Stessa è la linea di Volano, dove torna l’ironia, seppur amara, ma soprattutto la poesia di un bambino che, come in un sogno, assiste ad un volo collettivo, fuori dalle finestre di un palazzo, di questa schiera di anziani, lasciati soli da figli e nipoti – troppo focalizzati sulla frenetica quotidianità:
E il bambino va alla finestra e vede tutti quei vecchi alla finestra e la luna e tutti si guardano e nessuno dice niente, bisognerebbe urlare da finestra a finestra ma non sta bene […] Quelli che forse non salteranno mai giù da un ultimo piano. Ma se lo faranno… nessuno volerà a salvarli.
Ivi, pp. 74-76.
A chiudere l’opera troviamo un’ultima donna, Mademoiselle Lycanthrope, una lupa mannara squisitamente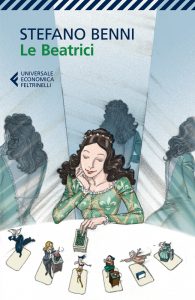 decadente sia nell’abbigliamento sia nell’atteggiamento. Illuminata da un raggio di luna, la licantropa ci racconta i limiti di un corpo che cambia di continuo, con cui ha imparato a convivere – dal pelo ispido di lupo ai vestiti lacerati a seguito della trasformazione – e di una bestialità con cui ha imparato a fare i conti. Ella, infatti, non la gestisce né tantomeno la rinnega, ma, per quanto sia e riconosca di essere un mostro, in realtà non lo è e lo dimostra a più riprese nella sua umanità se non con quegli uomini che si approfittano di lei nella sua forma umana:
decadente sia nell’abbigliamento sia nell’atteggiamento. Illuminata da un raggio di luna, la licantropa ci racconta i limiti di un corpo che cambia di continuo, con cui ha imparato a convivere – dal pelo ispido di lupo ai vestiti lacerati a seguito della trasformazione – e di una bestialità con cui ha imparato a fare i conti. Ella, infatti, non la gestisce né tantomeno la rinnega, ma, per quanto sia e riconosca di essere un mostro, in realtà non lo è e lo dimostra a più riprese nella sua umanità se non con quegli uomini che si approfittano di lei nella sua forma umana:
Lo so cosa pensate: adesso ci rifila la storia della licantropa buona che non uccide nessuno. No… non nego la mia natura. Ma ho delle mie regole. Come voi umani mi mangio la parte del mondo che mi spetta […] Io non sbrano bambini […] le donne no, solidarietà femminile […] Io mangio manager sui quarant’anni, preferibilmente filogovernativi.
Ivi, pp. 80-1.
Ho sempre trovato – e ancora trovo – questo testo valevole, soprattutto perché, oltre all’ironia, presenta otto donne che, in comune, hanno una peculiarità: il coraggio. E forse, nei loro modi di essere, ci danno una propria risposta alla nostra domanda iniziale su cosa significhi essere donna soprattutto oggi.
Essere donna significa avere il coraggio di essere se stesse, di non cambiare e di lottare per se stesse, perché come ci insegnano i tanti motti femministi, è proprio lottando per se stesse che si lotta per tutte.
Bibliografia
- Benni, S., Le Beatrici, Feltrinelli, Milano, 2011, p. 13.

di Marta Urriani
Mi chiamo Marta Urriani, classe ’98, e studio Lettere Moderne all’Università La Sapienza di Roma. Ho una folta chioma di capelli ricci, tanto che tutti mi chiamano Mafalda, come la bambina dei fumetti di Quino, con la quale ho molto in comune (e non solo i capelli). Cercando di sopravvivere alla vita universitaria, con il caffè di giorno e la camomilla di sera, leggo e scrivo. Mi interesso soprattutto di letteratura italiana e temi femministi.


[…] domanda, importante e complessa, ovvero cosa significhi essere donna, e provai a rispondere con le Beatrici di Stefano Benni. A distanza di un anno non lo riscriverei, o perlomeno non lo riscriverei così. Piuttosto, mi […]