di Bianca Beretta e Gioele Sotgiu
Negli ultimi dieci anni, a stare al centro dei riflettori è stata la “Nuova Via della Seta”1 (Belt and Road Initiative, BRI), un controverso progetto economico, infrastrutturale e strategico volto a potenziare gli scambi economici tra la Repubblica Popolare Cinese e gli Stati aderenti in Europa, in America Latina e in Africa. Alla luce di ciò, è possibile osservare come, dal punto di vista della narrazione mediatica, venga messa maggiormente in risalto la presenza cinese in Africa, arrivando a dipingere la Cina come il principale – se non unico – attore geopolitico con interessi economici e strategici nel continente.
In realtà, dal punto di vista economico, è il Giappone l’attore geopolitico più importante in Africa, soprattutto per quanto concerne la cooperazione allo sviluppo. Spesso si ignora questo fatto perché, a differenza di Pechino, Tokyo ha adottato per la promozione delle proprie politiche un approccio mediatico più discreto. Effettivamente, negli ultimi anni il Giappone ha dedicato molto impegno alla riprogettazione della propria strategia per inserirsi nel tessuto economico di vari Paesi africani2 (soprattutto per assicurarsi risorse utili alla filiera produttiva interna), senza però tralasciare la cooperazione allo sviluppo.
È doveroso precisare che la politica estera giapponese nei confronti del continente non nasce come reazione alla “Nuova Via della Seta”, bensì affonda le sue radici negli anni Sessanta e Settanta, ossia durante il processo di decolonizzazione. All’epoca, l’esecutivo nipponico riconobbe l’indipendenza della maggior parte dei nuovi Stati africani e fornì loro assistenza finanziaria e tecnica per progetti di sviluppo infrastrutturale, agricolo e sanitario. Attraverso tali misure, il Paese del Sol Levante emerse come leader negli aiuti allo sviluppo a livello globale: in termini di Official Development Assistance (ODA; in italiano, “Aiuto pubblico allo sviluppo”), risultava il primo donatore in Africa all’inizio degli anni Novanta3.

Assieme alla aid o donor fatigue (in italiano, “affaticamento dell’assistenza” o “affaticamento dei donatori”, ossia il calo degli aiuti allo sviluppo da parte dei Paesi ad alto reddito) verso la fine della Guerra fredda, questo primato giapponese rappresenta un’essenziale premessa all’istituzione della Tokyo International Conference on African Development (TICAD; in italiano, “Conferenza internazionale di Tokyo sullo sviluppo africano”), un forum internazionale a cadenza regolare il cui obiettivo è la promozione della cooperazione multilaterale economica e dello sviluppo sostenibile tra il Giappone e i Paesi africani. Già dalla prima conferenza (TICAD I) a Tokyo nel 1993, la quale vide la partecipazione di governi, imprenditori e attori della società civile, il governo giapponese era affiancato in tale contesto da varie istituzioni internazionali, quali le Nazioni Unite (ONU), il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (United Nations Development Programme, UNDP), la Commissione dell’Unione africana4 e la Banca mondiale.
La TICAD I fu cruciale per la definizione del paradigma a cui si sarebbe attenuto il governo giapponese per la cooperazione allo sviluppo in Africa:
«Noi [partecipanti al TICAD] adottiamo solennemente la presente Dichiarazione, credendo fermamente che servirà a rafforzare un nuovo partenariato emergente per lo sviluppo sostenibile dell’Africa basato sull’autosufficienza dei Paesi africani e sull’appoggio da parte dei partner per lo sviluppo [del continente africano]»5.
Dall’appena citato preambolo della Tokyo Declaration on African Development (in italiano, “Dichiarazione di Tokyo sullo sviluppo africano”), si evince l’approccio innovativo del Giappone nel campo degli aiuti internazionali verso l’Africa, basato sui concetti di partenariato (partnership, che implica un’interazione tra attori sullo stesso piano), ownership (ossia la responsabilizzazione dei Paesi partner attraverso una piena leadership sulle loro politiche e strategie di sviluppo endogeno, coordinando le singole misure in modo che i donatori vi si possano allineare di conseguenza, per rafforzare i sistemi interni e slegarsi progressivamente dagli aiuti stessi) e sul modello di sviluppo asiatico, il quale ha le sue fondamenta in politiche economiche orientate a esportazione, rapida industrializzazione, formazione e innovazione6. Questa visione degli aiuti allo sviluppo è decisamente diversa dal paradigma neoliberista del Washington Consensus (dunque di istituzioni quali la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale), che considera la stabilizzazione macroeconomica, la liberalizzazione e la privatizzazione strumenti efficaci per garantire crescita economica ai Paesi in via di sviluppo.
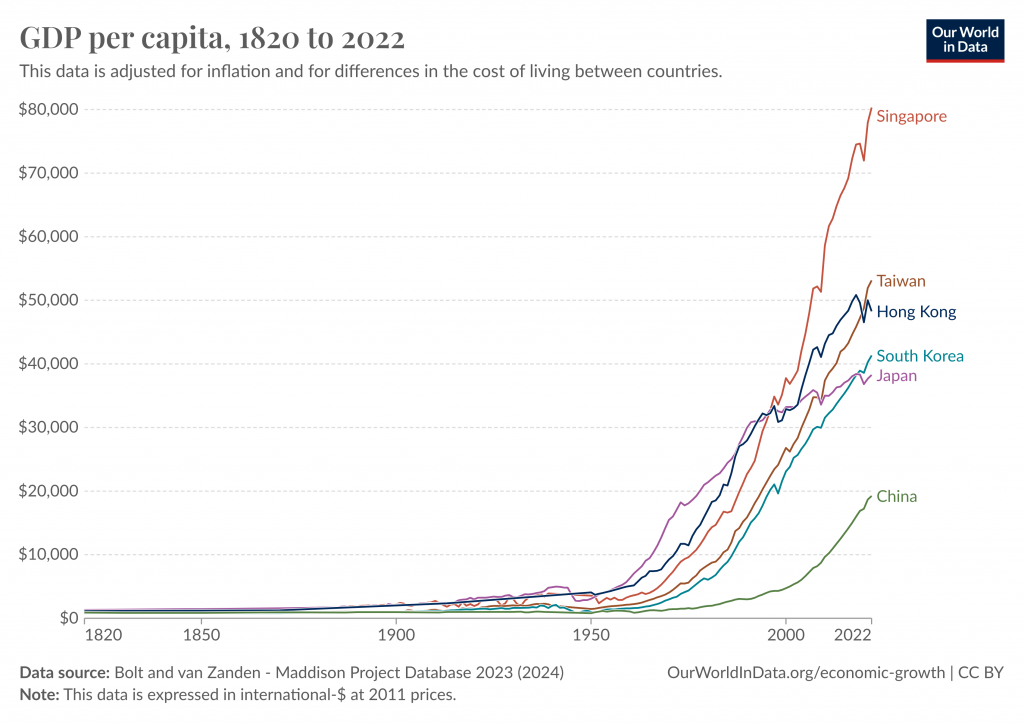
Negli ultimi tempi, la TICAD 8, svoltasi a Tunisi il 27 e il 28 agosto 2022, ha assunto un peso rilevante nel panorama internazionale. In tale occasione, il governo giapponese ha infatti annunciato l’investimento di 30 miliardi di dollari per lo sviluppo economico dell’Africa, di cui 4 miliardi dedicati alla Green Growth Initiative with Africa (GGA; in italiano, “Iniziativa di crescita verde con l’Africa”), un piano di investimenti pubblici e privati volti a stimolare lo sviluppo sostenibile del continente. Inoltre, durante le tre sessioni plenarie della conferenza, il primo ministro nipponico Fumio Kishida ha sottolineato che le iniziative di Tokyo hanno come scopo una maggiore resilienza dell’economia africana, un maggiore accesso all’istruzione e all’assistenza sanitaria e la promozione dello Stato di diritto (rule of law).
Gli aiuti al continente africano sono strettamente legati agli interessi economici giapponesi: diversi Paesi africani sono infatti importanti partner commerciali per il Giappone, soprattutto per quanto riguarda il commercio di merci e tecnologie, tra cui spicca il settore automotive. Alla luce di ciò, il continente africano è di significativa importanza e attrattività per le grandi multinazionali giapponesi rispetto alla possibilità di portare avanti pratiche di offshoring (in italiano, “delocalizzazione”) nell’industria automobilistica. Per esempio, il Sudafrica, uno dei Paesi con il PIL più alto in Africa7, è tra i maggiori fornitori del Giappone e, contemporaneamente, tra i principali importatori di prodotti giapponesi, soprattutto nell’ambito della componentistica per la produzione di automobili. La Liberia, invece, si attesta al secondo posto tra gli Stati africani partner del Paese del Sol Levante: nel 2022 infatti la quota di interscambio commerciale (ossia la somma di import ed export) con il Giappone ha superato il 10%, mentre le esportazioni giapponesi verso il Paese africano, la maggior parte delle quali riguardanti il settore nautico, hanno ammontato a più di due miliardi di dollari. Inoltre, Paesi come Nigeria e Algeria sono partner commerciali di Tokyo per quanto riguarda gli idrocarburi.
Dalle decisioni annunciate in seno alla TICAD 8, in effetti, traspare un interesse vitale per il Giappone in Africa: garantire alla propria filiera produttiva risorse energetiche e materie prime critiche8. Effettivamente, oltre al viaggio ufficiale a maggio 2023 in Mozambico e Mauritius del ministro degli Esteri Yamada Kenji per la promozione del commercio e degli investimenti giapponesi in Africa, assume un significato cruciale la missione del ministro dell’Economia, del Commercio e dell’Industria Yasutoshi Nishimura ad agosto 2023 in vari Paesi subsahariani. Durante queste visite, la Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC; in italiano, “Organizzazione del Giappone per i metalli e la sicurezza energetica”), un ente governativo nipponico, ha firmato degli accordi con Zambia, Namibia e Repubblica Democratica del Congo per garantire al Giappone la fornitura di minerali critici dai quali dipende fortemente la propria industria, specialmente quella dell’high-tech9.

Un ulteriore esempio pratico dell’interesse giapponese verso i Paesi africani è il caso del Kenya e del Mombasa Gate Bridge. Il progetto è stato avviato all’inizio di quest’anno con l’obiettivo di «fornire un collegamento stradale che sia funzionale tra l’isola di Mombasa e la costa meridionale di Mombasa»10. Il Giappone sta contribuendo alla realizzazione dell’infrastruttura con un investimento pari a quarantasette miliardi di scellini kenioti (poco più di 330 milioni di euro11); il progetto prevede di avvalersi della manodopera di ottantamila kenioti e di generare introiti pari a ottanta milioni di scellini kenioti all’anno12. La collaborazione di Tokyo con il Paese africano non si limita alla costruzione di infrastrutture pubbliche: a febbraio 2024, infatti, è stato siglato un Memorandum of Understanding (MoU), ossia un documento giuridico che sancisce un accordo bilaterale. Tale documento è stato firmato tra la Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), una compagnia assicurativa giapponese di proprietà del governo, e la National Treasury del Kenya, ossia la Tesoreria dello Stato13. L’accordo verte principalmente sul campo tecnologico (ICT), sull’emissione di Samurai bond, ovvero obbligazioni in yen emesse a Tokyo da società straniere ma soggette a legislazione giapponese, e sul rafforzamento del Kenya Medical Research Institute nella gestione delle emergenze sanitarie. NEXI ha sottolineato come «in occasione del sessantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi nel 2023, il Kenya ha accresciuto ulteriormente l’interesse per il Giappone in termini di rafforzamento dei legami con il Sud globale»14, dimostrando l’importanza di Nairobi per Tokyo.
Naturalmente, la corsa di Tokyo verso l’Africa rientra nei tentativi di contenere la Cina e la sua influenza nella regione. Come riporta Maria Siow per il “South China Morning Post”, nonostante le minori disponibilità economiche rispetto al suo rivale, Tokyo è in grado di offrire un modello di sviluppo basato su trasparenza dei finanziamenti e valori democratici15. Tale modello rappresenterebbe una valida alternativa a quello di Pechino, accusata dai Paesi occidentali di pratiche aggressive e opache soprattutto per la cosiddetta “trappola del debito”, ossia l’utilizzo predatorio di prestiti per estorcere da uno Stato mutuatario concessioni economiche e politiche, nonché dell’assoluta noncuranza in materia di principi democratici e diritti umani (vedasi i casi dello Xinjiang e di Hong Kong).
Possiamo constatare quindi che il Giappone è il vero gigante asiatico in Africa per le radici storiche delle relazioni nipponico-africane, il suo approccio innovativo all’assistenza allo sviluppo (attraverso la TICAD) basato sui concetti di partenariato e ownership e la promozione di misure trasparenti e democratiche. Allo stesso tempo, la rilevanza mediatica e il potere economico di Pechino nella regione, così come la dipendenza nipponica dall’importazione di risorse energetiche, minerali e terre rare dalla Cina e dall’Africa, costituiscono un rischio per la sicurezza energetica e manifatturiera di Tokyo. A questo quadro, si aggiungono le pretese di ulteriori attori globali per l’esercizio della propria influenza sul territorio africano e per l’accesso alle risorse tanto bramate: un esempio è l’Unione europea, che, in diretta risposta alla BRI cinese, ha previsto 300 milioni di euro di investimenti verso Paesi in via di sviluppo e mercati emergenti attraverso la strategia “Global Gateway”. Solo il tempo e la competizione geoeconomica potranno svelare se le solide basi nipponiche nel continente riusciranno a tener testa agli avversari nello scenario internazionale.
Note
- Il 27 febbraio 2024 abbiamo tenuto una diretta sulla Cina nel sistema internazionale con la Dr.ssa Giulia Sciorati (London School of Economics), con la quale abbiamo discusso anche della Belt and Road Initiative o “Nuova Via della Seta”. La registrazione è fruibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=Ymv4QaCcfr8&ab_channel=L%27Eclisse.
- M. Frenza Maxia e A. Pigoli, I Piani africani di Tokyo, in “ISPI”, 2023. https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/i-piani-africani-di-tokyo-147642. Consultato in data 26 aprile 2024.
- D. Seddon e M. Sato, Japanese Aid and Africa, in “Review of African Political Economy”, XXIV (1997), n. 71, pp. 153-156.
- L’Unione africana è un’organizzazione internazionale istituita nel 1999 allo scopo di accelerare il processo di integrazione dell’Africa, sostenere gli Stati africani nel contesto dell’economia globale e affrontare i problemi sociali, economici e politici del continente.
- AA.VV., Tokyo Declaration On African Development “Towards The 21st Century”, in “Ministry of Foreign Affairs of Japan”, 1993. https://www.mofa.go.jp/region/africa/ticad2/ticad22.html. Consultato in data 26 aprile 2024. [traduzione nostra, NdA]
- Per un approfondimento sui concetti alla base dell’approccio nipponico agli aiuti allo sviluppo, vedasi H. P. Lehman, Japan’s national economic identity and African development: An analysis of the Tokyo International Conference on African Development, in “WIDER Research Paper”, n. 2007/61, pp. 4-6. https://hdl.handle.net/10419/63364.
- International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook – GDP current prices, aprile 2024. https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/DZA/ZAF/MAR/NGA/EGY. Consultato in data 19 aprile 2024.
- M. Frenza Maxia e A. Pigoli, I Piani africani di Tokyo, in “ISPI”, 2023. https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/i-piani-africani-di-tokyo-147642. Consultato in data 26 aprile 2024.
- J. Ryall, Japan’s tech industry needs Africa’s critical minerals, in “Deutsche Welle”, 2023. https://www.dw.com/en/japans-tech-industry-needs-africas-critical-minerals/a-66558917. Consultato in data 28 aprile 2024.
- Ministry of Roads and Transport, Mombasa Gate Bridge, 2024. https://www.transport.go.ke/mombasa-gate-bridge. Consultato il 29 aprile 2024. [traduzione nostra, NdA]
- Il cambio scellino keniota – euro al 30 aprile 2024 è di 1 scellino = 0,0071 euro.
- Ministry of Roads and Transport, Mombasa Gate Bridge, 2024. https://www.transport.go.ke/mombasa-gate-bridge. Consultato il 30 aprile 2024.
- C. Volpi, Kenya e Giappone: una nuova alleanza per crescita e investimenti, “Africa24.it”, 2024. https://africa24.it/2024/03/25/kenya-e-giappone-una-nuova-alleanza-per-crescita-e-investimenti/. Consultato il 30 aprile 2024.
- NEXI, NEXI signs MOU with the National Treasury of Kenya, 2024. https://www.nexi.go.jp/en/topics/newsrelease/202402070233.html. [traduzione nostra, NdA]
- M. Siow, Japan’s Africa aid rivals China in terms of ‘quality over quantity’: analysts, in “South China Morning Post”, 2022. https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3194364/japans-africa-aid-rivals-china-terms-quality-over-quantity. Consultato in data 28 aprile 2024.

Bianca Beretta
Nata a Milano nella torrida estate del 2003 e cresciuta a cubotti della Stockmar e bilinguismo. Ora studio International Politics, Law and Economics all’Università degli Studi di Milano. Ho iniziato a scrivere sul diario segreto alle elementari e ora mi occupo di attualità e (geo)politica. Tra un articolo e l’altro scatto foto e ogni tanto mi ricordo di andare a canottaggio.

Gioele Sotgiu
Sangue sardo e cuore meneghino-teutonico, dopo la laurea in Lingue e Relazioni Internazionali all’Università Cattolica sono passato a Politiche Europee e Internazionali per non piangere davanti al lessico per gli esami di tedesco, la lingua del mio cuore (davvero). Mi piacciono la musica pop, la politica internazionale, la sociolinguistica, la comicità sagace e la cucina di mio padre. Se non sono tra le righe de L’Eclisse, potete trovarmi a cena fuori, in macchina con le mie amiche cantando Mai Più di Elodie o su un volo per Alghero.

