5 luglio 2018. Mentre la sottoscritta era impegnata nella prima grande prova della sua vita, l’orale della maturità, una scrittrice italo-tedesca, Helena Janeczek, sbaragliava con 196 voti la concorrenza e si guadagnava il podio nella cinquina del Premio Strega di quell’anno, con un libro atipico nel suo genere, nettamente diverso dalle prospettive dell’attuale scrittura italiana.
Un’opera non semplice, La ragazza con la Leica, complessa già nella sua stessa identificazione narratologica. La casa editrice stessa, Guanda, lo definisce un romanzo. In effetti nasce come romanzo, approdando poi ad una biografia romanzata con altre derive, dal flusso di coscienza a quella del romanzo storico. Un’opera che ha segnato le scelte dello Strega anche negli anni successivi, come nel caso di M, l’opera di Antonio Scurati parte di una ormai nota trilogia su Mussolini. Opere complesse che si pongono come lavori di ricerca e ricostruzione delle vite di personaggi realmente esistiti, più o meno noti, come nel caso di Gerda Taro nell’opera di Janeczek.
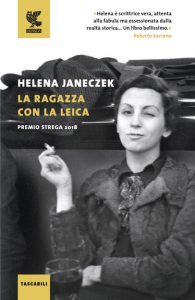 Ho conosciuto Gerta per caso, probabilmente durante una delle tante divagazioni intellettuali su arte e fotografia del mio bravissimo professore di Storia dell’Arte del liceo. Ad avermi avvicinata a lei è stata più che altro la fama di Robert Capa, suo compagno e amante considerato uno dei fotografi di guerra più capaci e famosi di sempre, fama che effettivamente si merita. Ricordo ancora quando vidi questo libro per la prima volta sugli scaffali della libreria: un libro semplice, di quelli che si raccontano già solo nel titolo e nella foto sulla copertina. La troviamo lì, Gerta, a copertina intera, piccola e minuta nella sua figura, una ragazza alla moda dal look sbarazzino e lo sguardo vispo, sveglio, ironico e sagace. Qualche benpensante la direbbe persino spregiudicata, complice l’occhiolino e la sigaretta da femme fatale che «accendeva […] con nonchalanche molto parigina»1. Nel momento in cui lo vidi promisi a me stessa di acquistarlo alla prima occasione utile, ma, per diverse vicissitudini, quel libro non varcò mai la soglia di casa mia.
Ho conosciuto Gerta per caso, probabilmente durante una delle tante divagazioni intellettuali su arte e fotografia del mio bravissimo professore di Storia dell’Arte del liceo. Ad avermi avvicinata a lei è stata più che altro la fama di Robert Capa, suo compagno e amante considerato uno dei fotografi di guerra più capaci e famosi di sempre, fama che effettivamente si merita. Ricordo ancora quando vidi questo libro per la prima volta sugli scaffali della libreria: un libro semplice, di quelli che si raccontano già solo nel titolo e nella foto sulla copertina. La troviamo lì, Gerta, a copertina intera, piccola e minuta nella sua figura, una ragazza alla moda dal look sbarazzino e lo sguardo vispo, sveglio, ironico e sagace. Qualche benpensante la direbbe persino spregiudicata, complice l’occhiolino e la sigaretta da femme fatale che «accendeva […] con nonchalanche molto parigina»1. Nel momento in cui lo vidi promisi a me stessa di acquistarlo alla prima occasione utile, ma, per diverse vicissitudini, quel libro non varcò mai la soglia di casa mia.
Tre anni dopo il caso mi offre una seconda occasione. Un corso universitario sulla letteratura della resistenza e dell’antieroismo, una pandemia, una canzone capitata per caso su Spotify a lei dedicata, Taro degli Alt-J(Δ). Tre situazioni che apparentemente sembrano non avere nulla in comune, eppure legate tra loro più di quanto sembri. Perché Gerta è stata una combattente e resistente. I più la definivano un’eroina, ma lei “eroina” non si è mai definita. Ha semplicemente fatto quello che sapeva fare meglio: documentare il presente, la guerra e la resistenza dei combattenti e delle combattenti della guerra civile spagnola, con gli occhi della fotografia, e alla sua morte è stata omaggiata dai tanti compagni con le note dei canti di lotta. Vi ricorda qualcosa? A me sì. Situazioni che abbiamo vissuto in questi due anni: in fondo questa pandemia in cui ci troviamo coinvolti e avvolti, ancora avvolti, è stata segnata soprattutto dalle foto, dalla dottoressa immortalata nel suo momento più duro, il crollo per la stanchezza, alla sfilata lugubre dei carri militari nei giorni più cupi dell’epidemia, a quella foto di speranza del neonato con il pannolino decorato con quel mantra, “andrà tutto bene”, che tanto abbiamo urlato dai balconi, anch’essi protagonisti di foto e reportage.
Le foto, quelle fatte bene, ma anche quelle scattate per caso, lasciano sempre il segno. Me lo ha insegnato proprio questo libro e Gerta in persona, che per trecentotrenta pagine non ha fatto altro che mostrarmi foto reali – la particolarità di questo libro sta anche in questo, un’edizione economica che presenta foto, foto di istanti e paragoni tra foto. La fotografia non solo consegna un soggetto alla Storia, ma anche un’idea e il vissuto e del soggetto ritratto e della persona che sta scattando. La ragazza con la Leica si apre proprio così: stesso soggetto, due foto diverse, quella scattata da Gerda e quella scattata da Capa. Si capisce al volo chi abbia scattato cosa e perché lo abbia scattato proprio in quel modo. Non si tratta di prospettiva o tecnica. Si tratta di sensibilità istantanea. E tutto il racconto, fino alla fine, cerca di rispondere proprio a quella domanda: perché molte delle foto presenti siano e possano essere solo e soltanto di Gerda. E questo attraverso tre fotografi di vita reale, le tre voci narranti di questa intensa biografia, due suoi amanti e un’amica, che a trent’anni di distanza dall’accaduto, un giorno, si ritrovano a ripensare a quel passato difficile. Tre modi diversi di vedere la stessa donna, due sguardi maschili e uno femminile, e le differenze di narrazione si vedono (la bravura della scrittrice si mostra anche nell’avere reso stilisticamente bene, nella narrazione dal punto di vista maschile, il sessismo diffuso tra gli uomini degli anni Trenta del secolo scorso). Tre diverse Gerta che ci danno certamente l’idea di Gerta, ma non della vera Gerta. Ma chi è questa Gerta?
Non starò qui ad elencarvi per filo e per segno i dettagli biografici della sua vita tanto intensa, per essere stata così breve. Breve perché morì il 26 luglio del ’37, ma i suoi funerali si tennero il giorno del suo compleanno, il 1 agosto, quello che sarebbe stato il suo ventisettesimo: potremmo inserirla di diritto nel Club 27, anche se non è stata una cantante e il suo nome non inizia per J. Nata Gerta Poryolle, tedesca di famiglia ebrea, nel ’33 viene arrestata a Lipsia per volantinaggio antiregime a seguito della nomina di Hitler come cancelliere. Un gesto, il suo, che fu appoggiato da tanti altri studenti che come lei aborrivano gli ideali nazionalisti e razzisti promossi dal Fuhrer. Nello stesso anno, dopo la scarcerazione, scappa a Parigi e inizia una nuova vita. Per mantenersi gli studi inizia a lavorare come dattilografa presso i coniugi Stein, divenendo spesso il soggetto preferito di Fred Stein, di cui abbiamo molte fotografie. A Parigi Gerta conosce una nuova sé, o forse si convince di quello che è – una donna capace e risoluta. Ce lo racconta bene Willy Chardack, “il Bassotto”, il primo ragazzo di Gerta, di cui non fu mai innamorata:
Era fatta così, era volubile e volitiva, un metro e mezzo di orgoglio e ambizione, senza i tacchi. Bisognava prenderla com’era: sincera sino a far male, affezionata a modo suo, sulla lunga durata.
Janeczek, H., La ragazza con la Leica, Milano, Guanda, 2017, p. 58
Affezionata fu al suo giro di conoscenze così come alla sua macchina fotografica, la Leica, da cui non si separò mai a partire dal momento in cui un carismatico ragazzo ungherese, Endre Friedman, francesizzato in Andrè, di due anni più giovane, gliela mise in mano e le insegnò tutto quello che il mondo della fotografia poteva offrirle. Gerta e Andrè, Andrè e Gerta. Divennero Gerda e Robert. Gerta era consapevole dell’enorme talento di entrambi: sapeva che le loro foto sarebbero finite su riviste importanti come Life, e voleva creare delle nuove identità per loro due. Fu lei a inventare nuovi nomi per entrambi, nomi che non fossero in alcun modo storpiabili in nessuna lingua. Gerda Taro per lei, che per assonanza si riconduceva alla famosa attrice Greta Garbo, Robert Capa per lui, che richiamava alla memoria il regista statunitense Frank Capra. Era tutto perfetto. Una coppia nel lavoro e nella vita, tanto da mettere su un marchio fotografico condiviso, “Capa-Taro”. Invidiati da tutti, anche e soprattutto dagli amici. Da Willy, che era stato stregato dal fascino della ragazza, ma anche dall’amica, Ruth Cerf, che visse sempre all’ombra di un probabile amore nascosto per Capa (per il quale aveva fatto da modella) e del fascino seduttivo di Gerda, a suo parere «conscia di suscitare quell’effetto […] ma in un modo insolito. Palese, senza malizia, quasi candido»2. Così come Georg Kuritzkes, il soldato delle Brigate Internazionali impegnato al fronte, che più di tutti invidiò Capa per essere stato l’uomo che aveva acceso in Gerta la passione, tanto amorosa quanto professionale, e che è anche il narratore che più di tutti dialoga con il ricordo di Gerta, guardando il cielo o le strade di Roma dall’ufficio della FAO. Tutto il racconto è velato da innumerevoli sottotesti, messaggi che la scrittrice ci manda affinché noi lettori possiamo immaginare i reali rapporti e le passioni che ci furono tra i cinque attori in scena, domande, rimpianti, monologhi e riflessioni sempre sottotono, sempre disilluse e disincantate. Per quanto Gerta non parli mai, risulta sempre il centro di ogni situazione, anche di quelle in cui apparentemente non è stata protagonista. Bella, carismatica, capace, seducente ma non svampita, sagace, sveglia e appassionata in ogni cosa che faceva, con Capa, certamente, ma anche e soprattutto da sola, perché «lei aveva ambizione e convinzione per entrambi, e per difendere la Spagna libera, rossa e repubblicana»3, mentre lui non era altro che «Il più grande fotografo di guerra senza una macchina fotografica»4. Per questo ho tenuto a sottolineare che Gerta non si separò mai dalla sua macchina fotografica, perché Capa non fu mai affidabile. Rimase incinta di lui e, nello sconcerto della sua amica Ruth, abortì di nascosto. A modo suo Capa si approfittò della bravura di Gerta, tanto da impossessarsi, dopo la morte di lei, dei diritti di una foto scattata da Gerta «[…]sul fronte di Segovia, vicino al passo di Navacerrada, quando lei lavorava con la Leica, lui con la Eymo fornita da Time-Life per realizzare un servizio che avrebbe inaugurato la grande svolta»5. E forse fu proprio questo furto a mettere in secondo piano la fama di Gerta, che morì sul fronte di Brunete sotto i cingoli di un carrarmato. Tanto la scrittrice quanto le fonti raccontano che, sul lettino dell’ospedale, tanto era la sua passione e la sua tenacia, Gerta ebbe come ultima preoccupazione che la sua macchina fotografica non fosse andata distrutta, così che l’impresa potesse essere comunque documentata. La morte di Capa ce la raccontano gli Alt-J nel loro pezzo, Taro: morì a 44 anni in Indocina, dove si recò per l’ennesimo fotoreportage, ma anche e soprattutto per cercare una risposta alla morte di Gerta, invocata nel brano più e più volte con quel grido proveniente dal profondo dello stomaco. I funerali di Gerta si tennero a Parigi: accorse davvero tutta la città e anche gente da ogni parte d’Europa, soprattutto compagni rossi, per dare l’ultimo saluto alla pequena rubia (la piccola bionda), prima donna fotoreporter di guerra. Persino due poeti insospettabili come Louis Aragon e Pablo Neruda, che le dedicarono questo elogio funebre: «Tutti i fiori del mondo si sono incontrati a Parigi».
macchina fotografica, perché Capa non fu mai affidabile. Rimase incinta di lui e, nello sconcerto della sua amica Ruth, abortì di nascosto. A modo suo Capa si approfittò della bravura di Gerta, tanto da impossessarsi, dopo la morte di lei, dei diritti di una foto scattata da Gerta «[…]sul fronte di Segovia, vicino al passo di Navacerrada, quando lei lavorava con la Leica, lui con la Eymo fornita da Time-Life per realizzare un servizio che avrebbe inaugurato la grande svolta»5. E forse fu proprio questo furto a mettere in secondo piano la fama di Gerta, che morì sul fronte di Brunete sotto i cingoli di un carrarmato. Tanto la scrittrice quanto le fonti raccontano che, sul lettino dell’ospedale, tanto era la sua passione e la sua tenacia, Gerta ebbe come ultima preoccupazione che la sua macchina fotografica non fosse andata distrutta, così che l’impresa potesse essere comunque documentata. La morte di Capa ce la raccontano gli Alt-J nel loro pezzo, Taro: morì a 44 anni in Indocina, dove si recò per l’ennesimo fotoreportage, ma anche e soprattutto per cercare una risposta alla morte di Gerta, invocata nel brano più e più volte con quel grido proveniente dal profondo dello stomaco. I funerali di Gerta si tennero a Parigi: accorse davvero tutta la città e anche gente da ogni parte d’Europa, soprattutto compagni rossi, per dare l’ultimo saluto alla pequena rubia (la piccola bionda), prima donna fotoreporter di guerra. Persino due poeti insospettabili come Louis Aragon e Pablo Neruda, che le dedicarono questo elogio funebre: «Tutti i fiori del mondo si sono incontrati a Parigi».

di Marta Urriani
Mi chiamo Marta Urriani, classe ’98, e studio Lettere Moderne all’Università La Sapienza di Roma. Ho una folta chioma di capelli ricci, tanto che tutti mi chiamano Mafalda, come la bambina dei fumetti di Quino, con la quale ho molto in comune (e non solo i capelli). Cercando di sopravvivere alla vita universitaria, con il caffè di giorno e la camomilla di sera, leggo e scrivo. Mi interesso soprattutto di letteratura italiana e temi femministi.
Bibliografia
- Janeczek, H., La ragazza con la Leica, Milano, Guanda, 2017, p. 58.
- Ivi, pp. 112-3.
- Ivi, p. 132.
- Ivi, p. 152.
- Ivi, p. 151.

