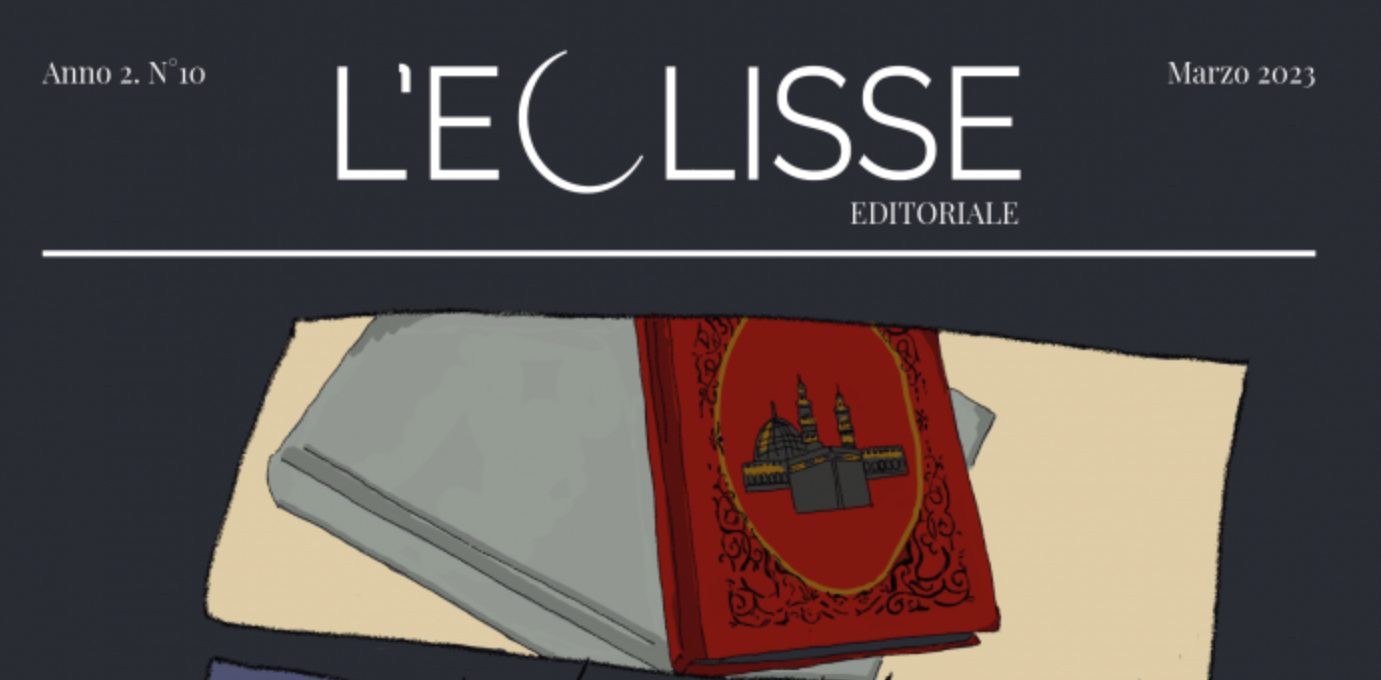Il cielo stellato sopra di me, la legge del Buddha in me
La Corea del Sud è nota ai più per la guerra tiepida che da settant’anni la divide dalla parte settentrionale, mentre i più giovani saranno sicuramente entrati in contatto con almeno uno dei prodotti della cosiddetta hallyu, “l’ondata coreana” che ha invaso la cultura pop dell’ultimo decennio. Dai prodotti di bellezza alla musica, dalle serie TV ai premi letterari più importanti, dal cibo ai film da Oscar: quello che poco tempo fa era un piccolo Paese dell’Estremo Oriente, strizzato tra Cina e Giappone, i titani culturali, economici e politici dell’Asia, oggi affascina e attira sempre più persone e si pone come gioiello ipertecnologico del balzo in avanti fatto da tutta l’area dagli anni ’80 in poi.
Le luci al neon dei quartieri di Seoul, ora, fanno sognare molti: tuttavia, quando a sedici anni decisi di trascorrere il mio quarto anno di liceo all’estero nella patria della Samsung e del kimchi, tutti mi guardarono stralunati. Correva l’anno 2018, Bong Joon-Ho avrebbe vinto il suo Academy Award solo l’anno successivo e dei BTS ancora non si parlava al telegiornale: “Ma che diavolo ci vai a fare, in Corea?” mi veniva chiesto, generalmente aggiungendo l’immancabile “Corea del Sud, vero?”.
Che cosa ci sono andata a fare, in Corea? Bella domanda, in fondo non lo so neanche io. Non voglio avere la presunzione di aver fiutato leggermente prima degli altri l’arrivo della “grande onda” (per dirla con Piotta) coreana anche in Italia. Sicuramente volevo mettermi alla prova, sperimentare una cultura completamente diversa dalla mia, e il coreano è una lingua decisamente più facile di cinese e giapponese. Anche il fatto di avere un parente trasferitosi nella capitale in tempi non sospetti, ovviamente, ha influito sulla mia decisione.
In ogni caso, io stessa non avevo bene idea di che cosa aspettarmi, una volta arrivata a novemila chilometri da casa mia. Ingenuamente sognavo la grande metropoli – piccola chicca per tutti gli aspiranti exchange students: qualsiasi destinazione scegliate, non sarete mai, e dico mai, mandati nella capitale, molto raramente in una città definibile “grande”. Anche per me, niente Seoul, niente Busan, né vita notturna, clacson incessanti e alti livelli di criminalità: andai a Pohang, città costiera dell’est della Corea, a circa trenta minuti di treno (superveloce, ça va sans dire) da Daegu.
Pohang è una città molto tranquilla, prettamente residenziale, motivo per cui la me sedicenne accolse con immensa gioia l’offerta di Antonia, una ragazza tedesca che avevo conosciuto tramite l’agenzia. La proposta in questione prevedeva andare insieme al delizioso tempio buddista di Jikjisa (-sa è la desinenza coreana che indica un tempio), non lontano da Daegu, per passarvi tre giorni e due notti seguendo lo stile di vita dei monaci residenti.
Prima di spiegare che cosa sia esattamente un Temple Stay, vorrei spendere due parole per spiegare il rapporto con la religione (in particolare col buddismo) del popolo coreano. Metà della popolazione si dichiara atea, mentre circa il 31% è cristiano e il 17% buddista. Il cristianesimo è arrivato in Corea a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, trovando terreno fertile soprattutto nella parte settentrionale del Paese. Con la creazione della Repubblica Popolare Democratica di Corea, comunista e perciò atea, i cristiani presenti sul territorio furono perseguitati e costretti a fuggire al Sud. Oggi, la Corea del Sud professa numerose correnti del protestantesimo e, in misura minore, anche il cattolicesimo e il cristianesimo ortodosso.
Per quanto riguarda il buddismo, la situazione è ancora più variegata. Arrivato in forma rudimentale dalla Cina tra il I e il II secolo d.C., il culto ha avuto sorti alterne (dall’essere religione ufficiale del periodo Goryeo, 918-1392, all’essere bandito in favore del confucianesimo di Stato nel periodo Joseon, 1392-1910) e ha dato origine a una variante regionale del buddismo, che gradualmente è diventata una delle correnti principali: il buddismo coreano, per l’appunto. Fatte salve le resistenze aristocratiche, il buddismo in Corea è stato accolto immediatamente dal popolo, anche per i numerosi punti in comune con la religione autoctona, lo sciamanesimo animista coreano. Quest’ultimo, che dall’inizio degli anni 2000 ha visto rinascere l’interesse nella sua forma più pura, ha in realtà influenzato non poco tutte le religioni importate dall’estero. Uno degli esempi più lampanti riguarda proprio il buddismo coreano, che dello sciamanesimo conserva il culto dei tre spiriti Sanshin (lo Spirito della Montagna), Toksong (il Recluso) e Chilsong (lo Spirito delle Sette Stelle, il Grande Carro), le cui statue possono trovarsi facilmente all’entrata di diversi templi buddisti.
Secondo lo sciamanesimo, gli spiriti risiedono nelle montagne. Perciò, i templi coreani vennero costruiti sulle loro pendici, sempre al di là di un fiume o un ruscello, che rappresenta il passaggio dal mondo mortale al mondo dell’anima del Buddha. Il visitatore attraverserà in seguito tre porte: iljumun, “la porta del solo pilastro”, sorretta da due colonne di legno poste su una sola linea, rappresenta l’abbandono della propria dualità e l’unione del proprio corpo con il proprio spirito; cheonghwamun, “la porta dei quattro prìncipi (o re) del cielo”, in cui si possono ammirare le imponenti e inquietanti statue dei quattro spiriti, eredità induista, che hanno il compito di guardiani delle direzioni (Nord-Sud-Est-Ovest) e servono a spaventare gli spiriti maligni; e infine burimun, che rafforza ancora l’idea della dualità, della completa uguaglianza tra tutti gli abitanti della Terra, e spesso presenta scene dalla vita del Buddha o dei suoi seguaci più illustri.
Il monastero si compone ulteriormente di vari edifici, ognuno con un compito particolare, come ad esempio il jonggak, che ospita i quattro strumenti suonati alla mattina e alla sera dai monaci (il gong, la campana, il tamburo e il pesce di legno, ognuno con un significato ben preciso) o il daeungjeon, ovvero l’edificio principale, dove si entra solo per pregare e in cui sono conservate o le reliquie del Buddha, o una sua statua.
Il Buddha cosiddetto storico, o principale, Sakyamuni, è di solito rappresentato seduto a gambe incrociate, in piedi con una mano alzata e il palmo rivolto verso lo spettatore, o, più raramente, sdraiato (e in base alla posizione assume nomi diversi). Troviamo nei templi anche rappresentazioni del bodhisattva della compassione, che impugna un fiore di loto, e quello della conoscenza, che stringe una bottiglia riempita di una medicina.
I colori rosso, blu, verde e giallo che adornano non solo i monasteri buddhisti, ma anche palazzi reali e altri edifici in Corea, hanno sia il valore simbolico di rappresentare il cielo, la terra e l’uomo, sia la funzione molto pratica di proteggere il legno dalle intemperie e dal marcire.
Nonostante il buddismo non sia più la religione predominante in Corea, il suo impatto è ancora tangibile in diversi usi e superstizioni. Ad esempio, è abitudine dei coreani inaugurare i fine settimana con una passeggiata di salute in montagna. Generalmente si parte in mattinata, così da raggiungere i templi buddisti verso l’ora di pranzo e riposare lì, magari partecipando alle preghiere o alla cerimonia del tè. Un’altra usanza è quella di appendere, nel daeungjeon, dei colorati bigliettini, adornati da fiori di loto fatti all’uncinetto, su cui scrivere un desiderio che si spera il Buddha possa avverare. Il numero di questi bigliettini moltiplica esponenzialmente nel periodo degli esami scolastici, evento molto sentito tra i giovani coreani, che presentano, purtroppo, un tasso di depressione e suicidio spaventosamente alto.

Non a caso, l’esperienza Temple Stay è spesso sfruttata dai ragazzi per rilassarsi e abbandonare lo stress scolastico per qualche giorno. Nel tempio di Jikji, uno dei più antichi del Paese, il programma prevedeva – almeno nel lontano 2018 – delle discussioni intorno al tema della depressione. Il primo precetto del buddismo dice di trattenersi dalla distruzione della vita, compresa la propria: tuttavia, il buddhismo non condanna il suicidio a priori (poiché, in casi estremi, può essere compiuto come atto d’onore), ma è interessato a discuterne le cause.
Vivere la vita monacale buddista, anche solo per poco tempo, è un’esperienza pivotale. Si viene catapultati in un mondo totalmente altro: a ognuno sono assegnati vestiti uguali a quelli degli altri e vengono ritirati i cellulari. Il tempio vive secondo i suoi ritmi e le sue regole: silenzio, riservatezza, pudore, rispetto. Nel refettorio sono vietati sprechi ed è pertanto tassativo servirsi solo di quello che si sa di poter mangiare. Per rispetto verso tutte le forme di vita senzienti della Terra, viene servito unicamente cibo vegetariano.
Il Temple Stay permette di osservare alcuni momenti tipici della vita buddista, dalla preghiera a momenti di “fai-da-te” di gruppo, che stimolano il dibattito e generano amicizia. Nel nostro caso, abbiamo assemblato delle candele e dei mala, collane simili a rosari che solitamente vengono composte durante la preghiera dei 108 inchini. Ogni volta che si fa un inchino, si infila una perlina di legno nel filo. Ogni perlina rappresenta una sofferenza umana e ogni inchino ha la funzione di relegarle nel passato e di fare ammenda.
L’inchino da fare è il seguente: congiungere i palmi delle mani e mettersi in ginocchio su un apposito materassino. Mettersi carponi, appoggiando anche i palmi sul materassino. Poi, allungare le braccia e cercare di stendere la schiena, sempre tenendo le ginocchia piegate e appoggiando i glutei sui talloni. Infine, si devono risollevare gli avambracci, rivolgendo i palmi delle mani al soffitto, in modo che alla fine solo cinque punti tocchino il pavimento: le ginocchia, i gomiti e la fronte. Provate a farlo alle cinque del mattino per 108 volte e potrete dire addio alla palestra.
Le notti sulle montagne coreane sono pungenti. Il fiume vicino a Jikjisa gelava ogni sera, ma la totale assenza di dispositivi elettronici o altre forme di inquinamento luminoso permetteva la visione di un meraviglioso cielo stellato. Forse uno dei miei ricordi della Corea preferiti: il silenzio, l’altezza, la fredda aria della sera, e quel cielo traforato di puntini luminosi che avrebbe fatto ingelosire persino Kant.
Nei templi, naturalmente, si dorme sugli ibul, la versione coreana dei futon: una manna per chi soffre di problemi di schiena. La sveglia è tra le quattro e mezza e le cinque; la colazione alle sei, a seguito della preghiera del mattino. Dopo due ore per le attività personali, il resto della giornata è dedicato a esercizi di meditazione, piccole chicche sulla storia del buddismo in Corea e lunghe passeggiate nei giardinetti del tempio.

La seconda e ultima cena a Jikjisa, per noi, non si è svolta nel solito refettorio, ma l’abbiamo consumata (in silenzio, come da tradizione), insieme ai monaci, in una stanza con la statua del Buddha e secondo un rito lungo e complesso che purtroppo la memoria non è riuscita a trattenere. Non mi è chiaro se questa opportunità venga sempre concessa ai visitatori: se fosse possibile, tuttavia, consiglio di coglierla al volo (soprattutto se, come la sottoscritta, avete origini liguri).
L’esperienza del Temple Stay è un toccasana per lo spirito, che consiglio infinitamente agli ansiosi del mondo, ma non è solo questo. La cosa che più mi ha affascinata della Corea, durante il mio soggiorno, è la commistione tra l’ultra-nuovo e il millenario, tra l’innovazione e la tradizione, la velocità e la quiete. Per questo penso che si possa capire la cultura di questo affascinante Paese immergendosi nelle sue tradizioni (anche) religiose, tanto quanto – e forse un po’ di più – andando al concerto del vostro idolpreferito. Fidatevi, ve lo dice un’atea.