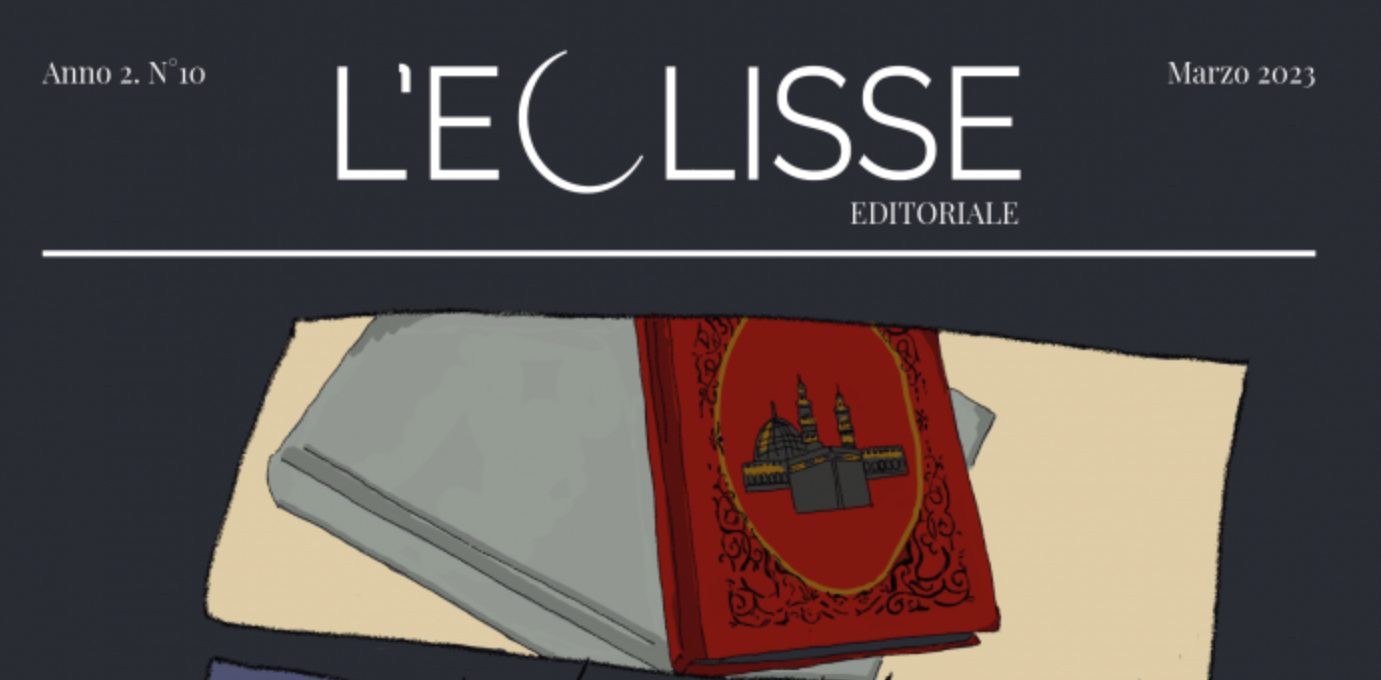Il Palazzo del Potere e la Chiesa del Signore
Rapporti tra Stato e Chiesa dall’Era Fascista agli albori della Prima Repubblica
Fin dalla nascita del Regno d’Italia, la città di Roma venne universalmente indicata come “necessaria capitale d’Italia” (discorso al parlamento di Cavour, 25 marzo 1861), ma il grande inconveniente storico che impediva la transizione nella giurisdizione d’Italia è sempre stato lo Stato della Chiesa, espressione fin troppo concreta del potere temporale papale; il non expedit del 1868 (“non è conveniente”, il monito degli organi clericali riguardo la partecipazione elettorale dei cattolici Italiani alle elezioni) non aiutò sicuramente la distensione dei rapporti tra Stato della Chiesa e Regno d’Italia, che lentamente si riallacciarono solo grazie all’azione di laici ed ecclesiastici volenterosi di contribuire alla casa comune italiana, a partire da figure più note come Don Luigi Sturzo fino a importanti mentori politici e spirituali come Monsignor Celestino Endrici.
Il Palazzo ha sempre percepito l’ingombrante presenza della Chiesa al centro del suo Stato, e si è posto, nel tempo, in maniera diversa nei suoi confronti; le principali tendenze sono incarnate dai poli opposti della politica italiana della prima metà del ‘900, Benito Mussolini e Alcide De Gasperi, e da una figura divisiva, filosofica e politica, Antonio Gramsci.
Benito Mussolini: l’opportunismo del dittatore
Benito Mussolini non fu mai un cattolico profondamente credente o praticante, anzi, secondo la testimonianza del giurista e senatore napoletano Amedeo Giannini, suo confidente, “egli sentiva intensamente la forza morale del cattolicesimo «e la impossibilità di mettersi contro corrente, ma, per suo conto, non era mai andato al di là di un vago teismo, come negazione di ateismo, più che forza viva e operante di fede»” .
Fondamentalmente, il suo maggiore interesse fu quello di mantenere un rapporto di reciproca collaborazione con la casta della Chiesa Cattolica, dal momento che era già inviso a Papa Pio XI; nella sua ventennale reggenza, il Duce perfezionò una serie di artifici retorici e pratici per mostrarsi sempre, al popolo, come protettore della Chiesa Cattolica e del suo prestigio internazionale, rispettoso dei diritti della Chiesa e della tradizione cattolica, ma senza risultare, alla compagine anticlericale del suo partito, un leader arrendevole nei suoi confronti.
La doppia prospettiva nel suo comportamento – che avrebbe avuto differente significato-, si vede bene in differenti luoghi: il 19 settembre 1938, a Trieste, Mussolini visitò la Basilica di San Giusto al fianco del vescovo monsignor Antonio Santin, che comunicò così alla Segreteria di Stato Vaticana le sue azioni: “Ritengo mio dovere comunicare a Vostra Eminenza quanto segue. S. E. il capo del Governo venne a visitare la basilica di San Giusto, dove lo attesi assieme al Capitolo. Lo condussi col suo seguito all’Altare maggiore, dov’era custodito il Santissimo Sacramento e dov’era preparato un inginocchiatoio per lui. Si inginocchiò, si fece il segno della croce e pregò a lungo con profonda edificazione di tutti. Poi gli offrii una statuina di San Giusto, che egli gradì, e lo condussi ad una navata bisognosa di restauro. Saputo che con 100.000 lire si potevano compiere le opere principali, elargì generosamente su due piedi tale somma”
Una simile “sottomissione” a Roma, nella città in cui doveva mostrarsi vero forgiatore del potere e capopopolo, era assolutamente da evitare, pena la percezione, da parte di un popolo in realtà molto meno unito di come lo Stato fascista volesse farlo percepire, che fosse un uomo “di parte”: un esempio di queste precauzioni fu la sua unica visita ufficiale in Vaticano, l’11 febbraio 1932, nella quale commentò così le indiscrezioni giornalistiche sul suo baciamano prostrato al Papa: “In genere seguo le regole di un Paese quando sono ivi ospite. Qui mi sono fatto dispensare prima, espressamente, dal dovere di inginocchiarmi e dal bacio della mano”.
Tornando a qua lche anno prima, Mussolini riuscì nell’intento di istituzionalizzare questo legame così proclamato con la Chiesa, con i Patti Lateranensi dell’11 febbraio 1929. Il documento, composto di due parti (il Trattato, con allegata la Convenzione Finanziaria, e il Concordato), in sintesi regolava ufficialmente la situazione statale del Vaticano, indipendente e sovrano (“libera Chiesa in libero Stato”), esente da imposte e dazi e ufficialmente “maestro morale” d’Italia, con il cattolicesimo come religione di Stato e l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole del Regno.
lche anno prima, Mussolini riuscì nell’intento di istituzionalizzare questo legame così proclamato con la Chiesa, con i Patti Lateranensi dell’11 febbraio 1929. Il documento, composto di due parti (il Trattato, con allegata la Convenzione Finanziaria, e il Concordato), in sintesi regolava ufficialmente la situazione statale del Vaticano, indipendente e sovrano (“libera Chiesa in libero Stato”), esente da imposte e dazi e ufficialmente “maestro morale” d’Italia, con il cattolicesimo come religione di Stato e l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole del Regno.
Alcide De Gasperi: cristiano, democratico, europeo
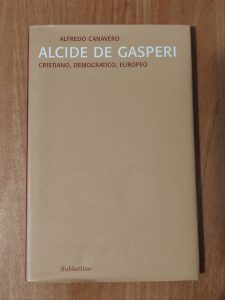 Citando l’opera di Alfredo Canavero, biografo ufficiale del fondatore della Democrazia Cristiana, possiamo dire che lo statista trentino, a differenza del dittatore romagnolo, fu un cristiano vero e saldo nella propria fede. De Gasperi, nato e svezzato alla politica nel Trentino austroungarico, fu universitario a Vienna ed ebbe la possibilità, nel 1902, di andare a Roma al seguito del suo professore di teologia Ernest Commer e incontrare don Romolo Murri, fondatore della Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI) nel 1896, vicino a don Luigi Sturzo ed esponente di punta del movimento democratico cristiano italiano. “Di Murri De Gasperi apprezzò la battaglia per l’ideale democratico-cristiano e il riformismo sociale, ma non ne poteva accettare il riformismo religioso. La pubblicazione dell’enciclica Pascendi Dominici Gregis (Pio X, 1907), che condannava il modernismo, fu poi l’occasione per prendere nettamente le distanze da lui.”
Citando l’opera di Alfredo Canavero, biografo ufficiale del fondatore della Democrazia Cristiana, possiamo dire che lo statista trentino, a differenza del dittatore romagnolo, fu un cristiano vero e saldo nella propria fede. De Gasperi, nato e svezzato alla politica nel Trentino austroungarico, fu universitario a Vienna ed ebbe la possibilità, nel 1902, di andare a Roma al seguito del suo professore di teologia Ernest Commer e incontrare don Romolo Murri, fondatore della Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI) nel 1896, vicino a don Luigi Sturzo ed esponente di punta del movimento democratico cristiano italiano. “Di Murri De Gasperi apprezzò la battaglia per l’ideale democratico-cristiano e il riformismo sociale, ma non ne poteva accettare il riformismo religioso. La pubblicazione dell’enciclica Pascendi Dominici Gregis (Pio X, 1907), che condannava il modernismo, fu poi l’occasione per prendere nettamente le distanze da lui.”
De Gasperi, in parte, antepose la cristianità della compagine popolare del territorio alla questione nazionale trentina, fin dal periodo come segretario e poi presidente dell’Associazione Universitaria Cattolica Trentina (AUCT): “Il partito si chiama democratico cristiano, e le due linee fondamentali e programmatiche rispondono al nome democratico: un partito che si propone la organizzazione del popolo perché il popolo si aiuti da sé con le sue forze e colle sue risorse. Cristiano perché si mette a base di ogni diritto, a guida di tutto il movimento e a termine di ogni benessere civile, economico e politico la religione di G.C.”
Queste sue posizioni lo misero in contrasto con i socialisti, per il primato di partito del popolo, e con i liberali, per sentimento nazionale e impostazione economica: i detrattori lo dipinsero come filoaustriaco, ma in realtà lui antepose l’essere cattolici all’essere italiani per i lavoratori del Trentino, al fine di tutelare le tante minoranze del territorio.
Nel settembre 1905 fu nominato direttore del giornale “La voce cattolica”, rinominato poi “Il Trentino”, dal vescovo di Trento Celestino Endrici, sostenitore dell’idea di De Gasperi di un grande partito democristiano che riunisse tutte le correnti cattoliche, nonché fondatore del Partito Popolare Trentino, importante esperienza politica anche per De Gasperi: dalle colonne de Il Trentino sostenne una serie di battaglie, continuò la sua carriera politica nell’Impero e, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, cercò garanzie dal ministro degli esteri italiano Sonnino in periodo di neutralità dell’autonomia trentina. Dopo l’annessione italiana, rimase saldo nelle sue richieste, – che vennero viste con sospetto- e fu cardine nel Partito Popolare di don Sturzo fino all’avvento del fascismo, in cui, dopo la secessione dell’Aventino, lo scioglimento del PPI e l’incarcerazione a Trento, rimase anonimo. Dopo aver criticato la parte del Concordato dei Patti Lateranensi, rea di mostrare ai cattolici una confusa commistione tra stato fascista e chiesa cattolica.
Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, De Gasperi, continuando l’opposizione al regime, dal novembre 1941 organizzò una serie di colloqui con ex esponenti del PPI e nuovi moderati cattolici e laici per la costituzione della futura Democrazia Cristiana, fondamenta del successivo Comitato di Liberazione Nazionale. Il programma partitico, Le idee ricostruttive della Democrazia Cristiana, venne diffuso capillarmente nel 1943 e, dopo la nascita della Repubblica, portarono il costituente De Gasperi al governo, prima come ministro degli Esteri ed interlocutore privilegiato degli USA, poi come presidente del consiglio.
Dopo le elezioni del 1948, De Gasperi s’impegnò nel progetto europeo con Spinelli, Schuman, Monnet e Adenauer, istituzionalizzando la CECA e risollevando le sorti del continente, in nome dell’Europa unita e con radici comuni.

Antonio Gramsci: l’estinzione della Chiesa

Gramsci, giornalista, filosofo e politico fondatore del Partito Comunista Italiano con Togliatti, era il più negativo nei confronti della Chiesa Cattolica; egli aveva una prospettiva ben delineata nei Quaderni dal carcere, opera fondamentale scritta negli anni della sua prigionia voluta dal regime fascista, nella quale dipingeva la casta clericale come nemica della rivoluzione proletaria: citando il comunista francese Portelli, “Una lettura approfondita dai Quaderni dal carcere mostra che la Chiesa vi appare come l’antagonista principale del partito rivoluzionario”, poiché la Chiesa è principale custode della storia, del passato e delle tradizioni, e di conseguenza delle continue ingiustizie della società civile borghese nei confronti dei proletari.
Per capire meglio la sua prospettiva, bisogna capire come “la religione interessa a Gramsci in quanto è connessa all’azione, all’agire umano. È un esito, non una causa. È un fatto, non un’idea”.
Per Gramsci, “il cristianesimo delle origini, sino all’editto di Milano, ha valore di spinta e rivoluzione, è religione positiva. E ogni volta che nella Chiesa ci si richiama al cristianesimo delle origini, per lui, è segno di rinascita e rivoluzione.”
Ma nei secoli a seguire, la religione cristiana, letta per questa via fattuale e pratica, per Gramsci non ha realizzato le sue premesse e le sue aspettative. Valutandola come “fatto”, come un “pensiero agito”, Gramsci giunge alla sua celebre analisi secondo la quale, dopo la Controriforma e la Rivoluzione francese, la religione (cristiana) non conduca più al minimo atteggiamento pratico.
Dunque, oggi, per Gramsci, la religione è “oppio dei popoli”, cioè un’ideologia inutile. E aggiungerà: “La più gigantesca utopia metafisica apparsa nella storia, perché è il tentativo più grandioso di conciliare in forma mitologica le contraddizioni reali della vita storica”. 8
Per la sua filosofia della prassi, la forte carica pratica che porta immediatamente il pensiero in azione, non importano i contenuti e le dottrine della Chiesa, o il cristianesimo in sé, ma le azioni della Chiesa, che valuta negativamente per il loro fine negativo.
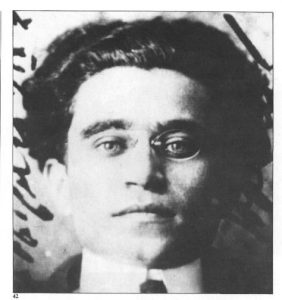 “La religione, come fatto immanente, come simbolo che produce una moralità, è una grande opportunità per Gramsci, è un evento estremamente positivo, se agisce bene, se agisce verso il bene. Ugualmente, se il cristianesimo agisce per il bene, verso il bene, esso è una grande opportunità, di cui magari un giorno non vi sarà più bisogno (parliamo di una “escatologia marxista”, tema che sia Marx che Gramsci pongono abbastanza chiaramente), ma per intanto, se fa così, è un fatto positivo”. 8
“La religione, come fatto immanente, come simbolo che produce una moralità, è una grande opportunità per Gramsci, è un evento estremamente positivo, se agisce bene, se agisce verso il bene. Ugualmente, se il cristianesimo agisce per il bene, verso il bene, esso è una grande opportunità, di cui magari un giorno non vi sarà più bisogno (parliamo di una “escatologia marxista”, tema che sia Marx che Gramsci pongono abbastanza chiaramente), ma per intanto, se fa così, è un fatto positivo”. 8
I tre approcci, diametralmente diversi, sono la perfetta sintesi dell’opportunismo politico, della vera fede e dell’approccio filosofico condensati nel secolo breve, il così complesso e ricco Novecento: la forte influenza della Chiesa Cattolica sulle relazioni internazionali e le questioni interne italiane, incluse le pagine buie come il caso Orlandi, continuano tutt’ora, e tengono vivo l’interesse di studiosi e politici. Come detto all’inizio, la Chiesa sarà sempre una presenza al centro del nostro Stato, sta alla politica e a noi cittadini interfacciarcici, considerando sia la ricca storia materiale e sociale, sia la sua “decadenza”.
Note
- Da A. Giannini, Il cammino della Conciliazione, Milano, Vita e Pensiero, 1946.
- Da https://www.laciviltacattolica.it/articolo/mussolini-ateo-devoto/
- Citato in G. Sale, Le leggi razziali in Italia e il Vaticano, Milano, Jaca Book, 2009.
- Citato in G. Sale, La Chiesa di Mussolini. I rapporti tra fascismo e religione, cit., 27.
- Da Alfredo Canavero, Alcide De Gasperi: cristiano, democratico, europeo; Rubbettino, 2003
- Da A. De Gasperi, Austria II, quaderni di appunti autografi durante il periodo universitario, dichiarazione ai soci dell’AUCT.
- Da https://www.ccdc.it/documento/il-cristianesimo-nel-pensiero-di-gramsci/
- Dalla conferenza “Gramsci e la Religione”, Andrea Oppo, Ghilarza, 3/12/2015, https://www.gliscritti.it/blog/entry/5119