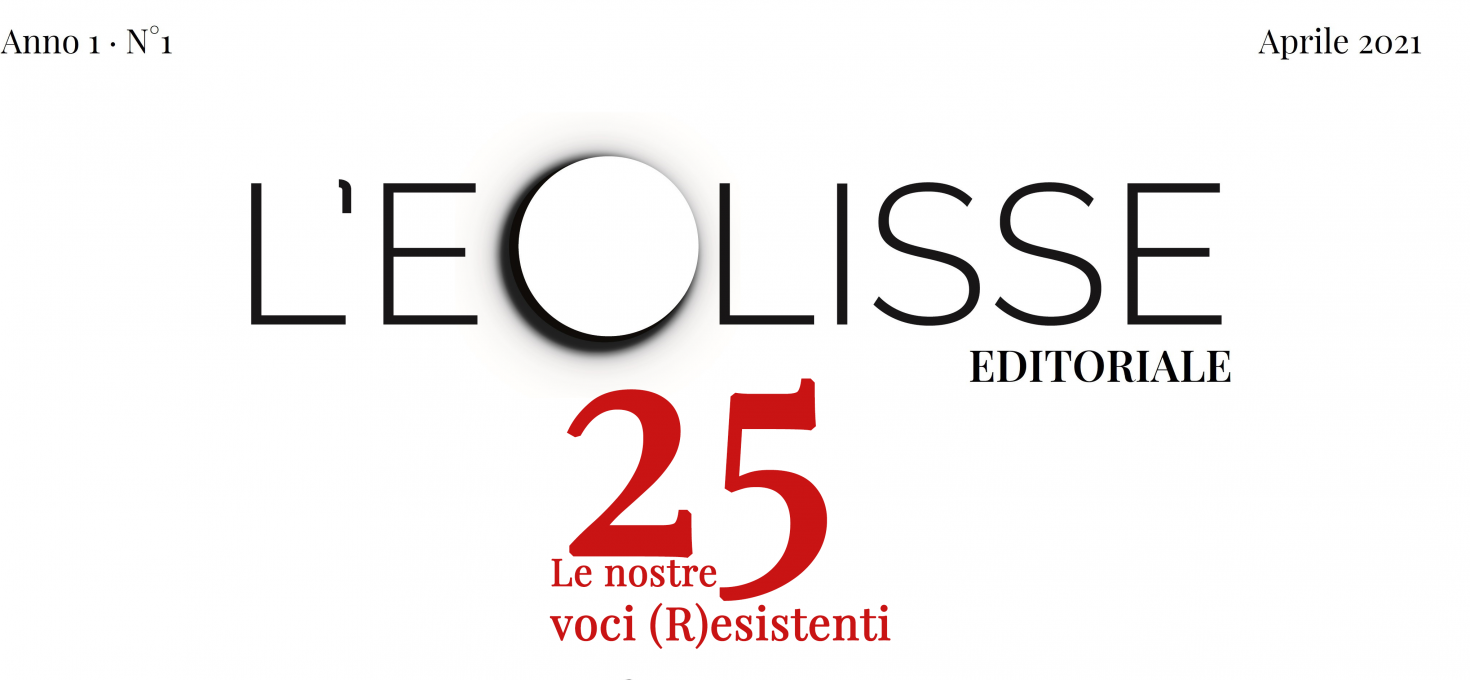La bicicletta della Resistenza: Onorina Brambilla e i GAP
Quando si parla di Resistenza, è importante ricordare il ruolo che le donne hanno ricoperto nella lotta contro il nazifascismo. Tutte loro scelsero di lottare e contribuire alla storia, e tra queste c’è Onorina Brambilla, Nori per gli amici.

Onorina nacque nel quartiere operaio di Lambrate, a Milano. Suo padre fu un operaio antifascista alla Bianchi, fabbrica di biciclette, e per aver rifiutato di prendere la tessera del partito fascista, venne licenziato. Nori fece in tempo a frequentare una scuola professionale per tre anni, prima che i genitori la iscrivessero a un corso di stenodattilografia dopo il quale, a 14 anni, dovette cercare un lavoro per aiutare la propria famiglia. Venne assunta poco dopo dalla ditta Paronitti come impiegata e vi rimase fino al licenziamento nel 1941, avvenuto a causa di un diverbio col padrone. Nel frattempo, dal 10 giugno 1940 l’Italia era in guerra a fianco di Hitler.
Onorina trovò presto un nuovo impiego in una ditta che produce binari: conobbe sempre più operai, distinguendo chi era antifascista da chi non lo era. Intanto, iniziò a studiare l’inglese al Circolo Filologico di via Clerici, nella cui biblioteca circolavano ancora molti libri censurati dal regime, fondamentali nella sua formazione.
La caduta di Mussolini il 25 luglio 1943 colse il popolo italiano di sorpresa, tra disordini e entusiasmi, che, però, furono repressi subito dal maresciallo e nuovo capo del governo Pietro Badoglio, il quale informò la nazione che «la guerra continua». In agosto Milano, centro nevralgico dell’Italia settentrionale, fu soggetta a un ciclo di feroci bombardamenti, in quanto la distruzione della città avrebbe messo l’Italia intera in ginocchio. Onorina tenne il suo primo comizio antifascista nel rifugio anti bomba: era convinta che i mesi che gli uomini avevano passato a sfuggire fossero stati l’occasione per le donne di affermare i loro diritti.
«Secondo me sono state le donne a dare inizio alla Resistenza… la loro partecipazione fu dovuta a motivazioni personali; a differenza di molti uomini che scelsero di andare in montagna per sottrarsi all’arruolamento nell’esercito di Salò, nessun obbligo le costringeva ad una scelta di parte; fu anche l’occasione per affermare quei diritti che non avevamo mai avuto, mai come in quei mesi ci siamo sentite pari all’uomo….»
A seguito dell’armistizio con gli Alleati dell’8 settembre 1943, i tedeschi occuparono il Nord Italia, con l’aiuto dei fascisti. In quei giorni, Nori e sua madre entrarono a far parte dei Gruppi di Difesa della Donna, che ebbero un ruolo fondamentale nell’aiutare la Resistenza Antifascista: questi gruppi procuravano ai partigiani cibo e indumenti. Inoltre, Onorina era addetta alla stampa clandestina, dimostrando spirito di iniziativa e impavidità.
Dalla fine di ottobre del ’43, si formarono i primi GAP, i Gruppi di Azione Patriottica, comandati da veterani che avevano già combattuto in Spagna contro il franchismo. Il loro obiettivo era provocare i nazifascisti con attentati e sabotaggi, e rendere più ampia possibile la partecipazione popolare al movimento insurrezionale. Il comandante dei GAP di Milano era Giovanni Pesce, nome di battaglia “Visone”, il quale aveva già svolto numerose azioni di sabotaggio a Torino e era stato costretto a trasferirsi nel capoluogo lombardo in seguito a alcune drammatiche uccisioni di suoi compagni.
Onorina colse subito l’occasione e si mise in contatto con Giovanni per collaborare con il III GAP “Egisto Rubini”; ancora non lo sapevano, ma i due sarebbero diventati coniugi. Venne nominata ufficiale di collegamento poco dopo aver lasciato il lavoro a marzo 1944, con il compito di trasportare le armi necessarie per le operazioni militari. Con il nuovo nome di “Sandra”, si spostava per le strade di Milano sulla sua bici azzurro cielo, spesso rischiando la vita per passare in mezzo ai rastrellamenti antifascisti, ma la sua prontezza di spirito la salvava sempre dai sospetti dei soldati nei suoi confronti. Tantissime donne come lei facevano da staffetta per portare le armi e riprenderle in consegna dopo un’azione per evitare che i gappisti venissero sorpresi armati e fucilati sul posto. Inoltre, Onorina partecipò a una pericolosa operazione nota come “la battaglia dei binari”, che ebbe luogo il 24 giugno 1944 alla stazione di Greco: l’obiettivo era il sabotaggio dei convogli ferroviari che portavano i prigionieri nei lager. Fu lei il collegamento tra i ferrovieri e i gappisti e fu sempre lei a portare i quattordici ordigni che, una volta posizionati, scoppiarono simultaneamente.
Il 12 settembre 1944 Nori venne tradita da un partigiano passato al nemico, Giovanni Jannelli, e venne catturata dalle SS nel cuore di Milano, insieme ad altri suoi compagni. Il Comando chiese loro di resistere ventiquattro o quarantotto ore per permettere agli altri gappisti di mettersi in salvo. Onorina rimase in isolamento totale nel carcere di Monza (l’ex Casa dei Balilla) per due mesi; le SS la sottoponevano a lunghi interrogatori e terribili torture pur di farsi consegnare Visone, ma nessuno confessò. L’11 novembre venne caricata con altri prigionieri su un camion e portata nel campo di concentramento di Bolzano. Si trattava di un campo di transito, adibito per una prigionia provvisoria prima della deportazione nei lager tedeschi. Ancora oggi non è chiaro perché i cinquecento prigionieri politici che si trovavano lì non furono mai deportati in Germania. Nonostante le durissime condizioni, i prigionieri riuscirono a mantenere i collegamenti con l’esterno.

Milano venne liberata dai Partigiani il 25 aprile. Onorina riuscì a sopravvivere fino all’arrivo degli Alleati: non appena i tedeschi ebbero lasciato il campo, lei ed alcuni compagni si misero in cammino sotto la neve. Attraversarono la Val di Non e il Tonale, sostando di notte presso dei contadini o dei posti di ristoro dei partigiani delle Brigate Fiamme Verdi. Infine un pullman fornito dai comuni della zona di Ponte di Legno (Brescia) trasportò i fuggitivi fino a Lovere (Bergamo), per permettere loro di proseguire in treno fino a Milano.
Ad attenderli il 7 maggio c’era la manifestazione dei partigiani. Non appena “Sandra” rivide “Visone”, corse in strada e si abbracciarono, finalmente liberi.
Si sposarono il 14 luglio 1945, pieni di gioia per la ritrovata libertà e speranza per una nuova vita.
Dopo la guerra, Onorina fu insignita della Croce al Merito di Guerra al Valor Partigiano nel 1962. Negli anni prima della sua morte, dimostrò sempre ininterrotto impegno nelle iniziative dell’ANPI, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, di cui fu Responsabile della Commissione Femminile. Narrò la sua esperienza nel libro Il pane bianco, ma il suo stimolo principale era il contatto con i ragazzi nelle scuole. Il rapporto con le giovani generazioni era per lei fondamentale, le considerava decisive per una rinascita nazionale: era profondamente convinta che la missione dei giovani fosse non di conformarsi all’ordine precostituito, ma di portare una ventata di progresso e volontà di rinnovare. Solo questo avrebbe permesso al Paese di risolvere i propri problemi.
Onorina si spense il 6 novembre 2010. Le sue ceneri, assieme a quelle di Giovanni Pesce, sono tumulate nel medesimo colombario, nella Cripta del Famedio del Cimitero Monumentale di Milano.
«La Resistenza fu anche l’occasione di affermare quei diritti che non avevamo mai avuti. Mai come in quei mesi ci siamo sentite pari all’uomo. Paradossalmente, con la guerra si crearono le condizioni di una libertà personale mai sperimentata prima. Molte di noi con la Resistenza si guadagnarono la loro autonomia» (O. Brambilla, Il pane bianco, Edizioni Arterigere, Varese 2010).