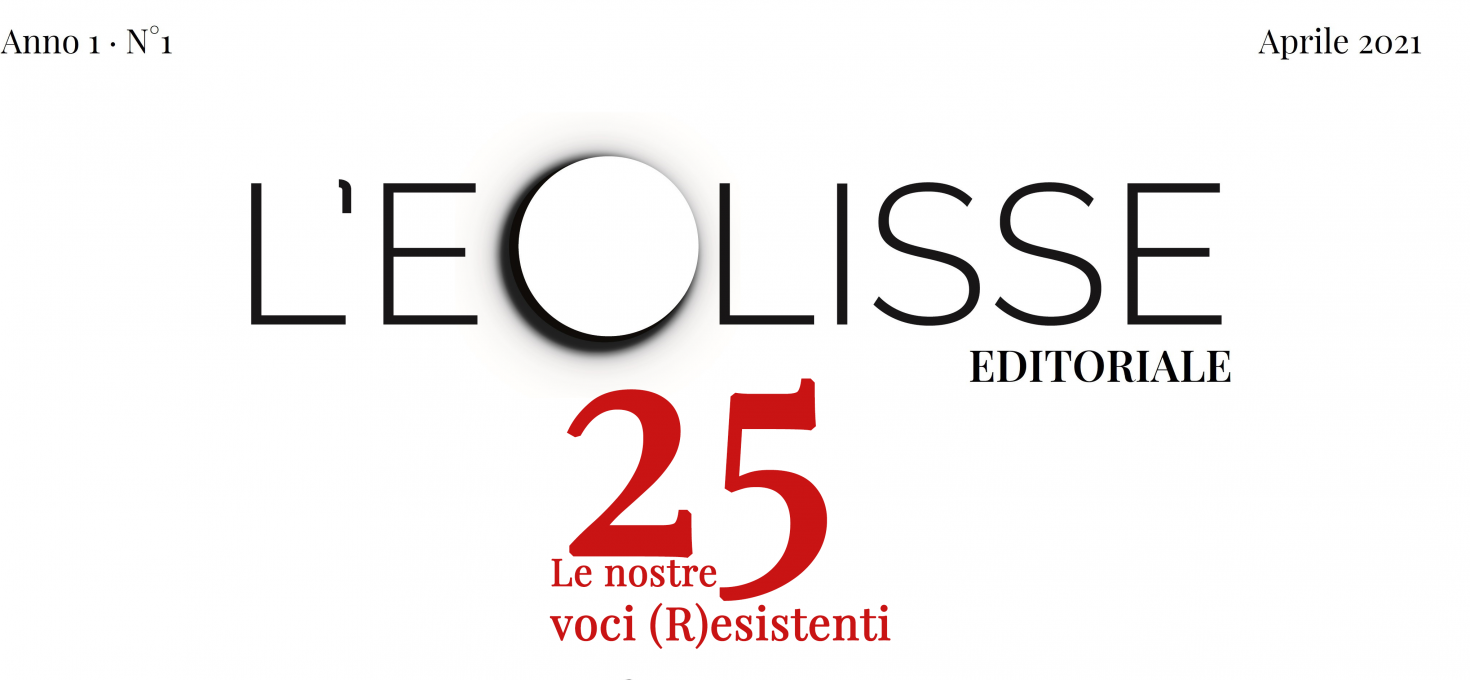Bella Ciao e «l’invenzione di una tradizione»

Dagli anni della Resistenza partigiana alle piazze di Istanbul, passando dall’altopiano del Kurdistan e dalla sede di Charlie Hebdo, Bella Ciao è la canzone partigiana che non ha certamente bisogno di presentazioni. Da quando si è diffusa in tutto il mondo, risuona come canto di protesta in manifestazioni contro i poteri forti e le dittature: fu intonata durante le manifestazioni turche contro il premier Erdogan nel 2013, è stata cantata dal movimento Occupy Wall Street nel 2011 e anche dagli indipendentisti Curdi che lottavano (e lottano tuttora) nella guerra civile siriana.
A renderla ulteriormente celebre hanno poi contribuito le interpretazioni di Goran Bregovic, di Manu Chao e dei Chumbawamba e l’adattamento di Woody Allen e della sua New Orleans Jazz Band, che nel 2010 ne hanno suonato una versione al clarinetto all’Auditorium di via della Conciliazione, a Roma.
Tra le ultime e più celebri rievocazioni del canto c’è certamente quella dei protagonisti de La Casa di Carta, la serie Netflix che ne ha fatto il pezzo portante della sua colonna sonora: esso viene spesso eseguito in lingua italiana durante alcuni passaggi cruciali, proprio a sottolineare la voglia di ribellione del gruppo attorno a cui ruota la trama.
In realtà, per noi italiani, Bella Ciao significa principalmente Resistenza, partigiani e antifascismo, così come ci è stato insegnato in famiglia, a scuola e dai media.
Ma è proprio così? Facciamo un passo indietro.
Luigi Morrone, nel suo articolo La vera storia di Bella Ciao, che non venne mai cantata nella Resistenza, edito dal Corriere della Sera, scrive così: «ogni “testimone oculare” ne racconta una diversa. Lo cantavano i partigiani della Val d’Ossola, anzi no, quelli delle Langhe, oppure no, quelli dell’Emilia, oppure no, quelli della Brigata Maiella. Fu presentata nel 1947 a Praga in occasione della rassegna Canzoni Mondiali per la Gioventù e per la Pace. E così via.»
In effetti, anche dal sito ufficiale dell’ANPI apprendiamo che la storia di Bella Ciao risulta alquanto complessa: l’unica certezza è che la prima incisione della melodia risale al 1919, in un 78 giri del fisarmonicista tzigano Mishka Ziganoff, intitolato Klezmer-Yiddish swing music.
Del testo, invece, sappiamo ancora oggi ben poco: quando comparve la prima volta?
«Ognuno la racconta a modo suo», dice Morrone, «la voce “Bella Ciao” su Wikipedia contiene una lunga interlocuzione in cui si racconta di una “scoperta” documentale nell’archivio storico del Canzoniere della Lame che proverebbe la circolazione della canzone tra i partigiani fra l’Appennino Bolognese e l’Appennino Modenese, ma i supervisori dell’enciclopedia online sono stati costretti a sottolineare il passo perché privo di fonte. […] Non vi è alcuna fonte documentale che attesti che Bella Ciao sia stata mai cantata dai partigiani durante la guerra. Anzi, vi sono indizi gravi, precisi e concordanti che portano ad escludere tale ipotesi. Tra i partigiani circolavano fogli con i testi delle canzoni da cantare, ed in nessuno di questi fogli è contenuto il testo di Bella Ciao.»
Anche lo storico Cesare Bermani sostiene che il canto fosse «poco diffuso» durante la Resistenza: «Si riteneva, non avendo avuto questo canto una particolare diffusione al Nord durante la Resistenza, che fosse sorto nell’immediato dopoguerra». Proprio per questo motivo Bermani parla di «invenzione di una tradizione». Inoltre, la prima presentazione del testo di Bella Ciao appare sulla rivista La Lapa nel 1953 e solo tre anni dopo il canto verrà inserito in una raccolta, Canzoni partigiane e democratiche, a cura della Commissione Giovanile del PSI.
La consacrazione definitiva della melodia arriva nel 1962, grazie alla cantante Giovanna Daffini, che aveva presentato una versione di Bella Ciao nella quale non si parlava di invasori e partigiani, ma di una giornata di lavoro delle mondine, sostenendo di averla imparata nelle risaie di Vercelli e Novara (dove era mondariso prima della guerra), mentre la versione da noi conosciuta del testo compare nel 1964, quando il Nuovo Canzoniere Italiano presentò a Spoleto uno spettacolo dal titolo “Bella Ciao”, in cui la canzone delle mondine apriva il recital e quella dei partigiani lo chiudeva.
In realtà, dagli scritti del Bermani apprendiamo che «nel maggio 1965 in una lettera a l’Unità, tale Vasco Scansani racconta che le parole di Bella Ciao delle mondine le ha scritte lui, non prima della guerra ma nel 1951 in una gara di cori fra mondariso e che la Daffini gli ha chiesto le parole».
Tornando al punto di partenza, se, come dice Bermani, si tratta di «invenzione di una tradizione», anche l’origine in tempo di guerra è inventata. Allora perché Bella Ciao è diventata il simbolo della Resistenza partigiana? A cosa è dovuto il suo successo? Forse alla sua semplicità e fruibilità, al suo motivo allegro o al fatto che non è “etichettata” politicamente come altri testi della Resistenza, che, invece, hanno riferimenti più espliciti al comunismo o al socialismo.
Io non sono una storica e non so quale sia l’origine di Bella Ciao, ma so che chiunque la canti lo fa perché ha voglia di libertà. Quando ascolto le sue parole e il coro di voci che si alzano all’unisono, sento un forte brivido: è il brivido della libertà, guadagnata con il sangue di uomini e donne convinti della possibilità di un futuro migliore.