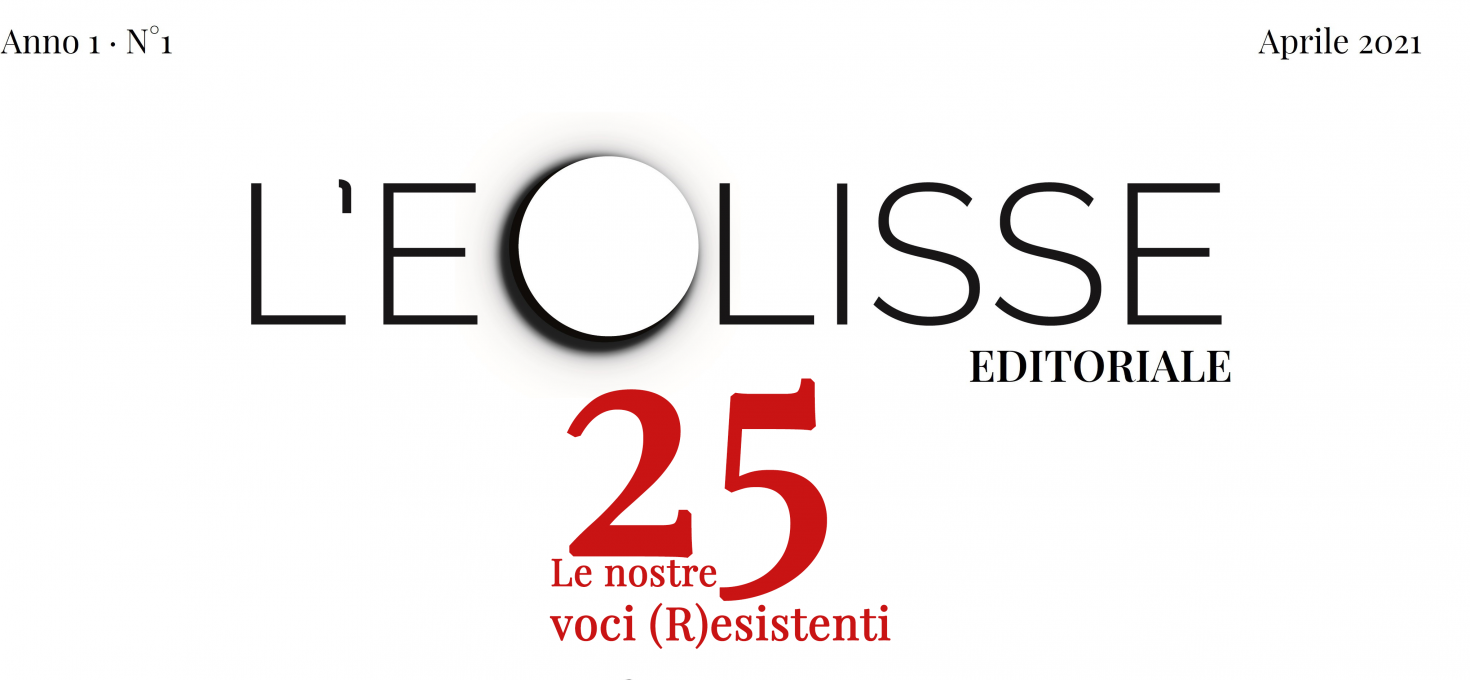Dalla Resistenza alle re-esistenze. Resistenza femminile tra ieri e oggi
25 aprile 2021.
Oggi, come ogni anno, in prossimità o nel giorno stesso di una ricorrenza importante, prestiamo qualche minuto del nostro tempo a ricordare.
La retorica intorno al 25 aprile ci racconta di una Resistenza tenuta in piedi da uomini che, con le armi e sulle note di Bella ciao, combattevano strenuamente per cacciare l’invasore, ovvero i tedeschi e l’ideologia fascista. Per lungo tempo, questa è stata la narrazione che abbiamo sempre ascoltato e che è stata portata avanti dai libri di storia e di filosofia, ovvero che la Resistenza è stata fatta di e dagli uomini. La domanda sorge spontanea: in tutto questo, le donne dov’erano?
Con l’avvento degli anni ’70 e sulla via dei movimenti emancipazionisti della seconda ondata del femminismo, «si è materializzata anzitutto l’esigenza di recuperare un passato rimosso, il vissuto dell’esserci delle donne specie mediante la loro misconosciuta partecipazione alla storia politica del Novecento»1. Con questa dichiarazione, Andreina De Clementi, docente di Storia Contemporanea presso l’Università di Sassari, nonché per molti anni presidente della Società Italiana delle Storiche (SIS) – associazione che più di tutte ha sentito viva questa esigenza da lei messa in luce – e altri collettivi socialmente attivi in ambito accademico, ad esempio il collettivo filosofico dell’Università di Verona, Diotima, hanno intrapreso questo «lavoro di scavo proteso a disseppellire dall’oblio una affatto accertabile presenza femminile»2.
Dunque, attraverso la redazione di lavori critici su opere di importanti scrittrici testimoni e partecipi alla Resistenza (quali Renata Viganò, Alba De Cespedes, Anna Banti) e il sistematico recupero delle testimonianze di partigiane, conservate presso gli archivi delle varie sedi italiane dell’A.N.P.I., si è scoperto e ribadito quanto «le donne combattevano in ogni maniera nella lotta partigiana: staffette, infermiere, cuoche, magliaie, fornaie, lavandaie […] anche combattenti: ed erano sempre pronte»3, pronte quindi anche ad imbracciare in prima persona le armi, sia per ribellarsi contro le brutalità della guerra che vedevano le donne spesso vittime di violenze, anche sessuali, da parte degli eserciti, come ci descrive crudelmente Moravia all’interno de La ciociara, sia perché altre vedevano nella lotta, tanto in quella armata quanto in quella dialettica, non solo la liberazione fisica dall’invasore tedesco, ma anche e soprattutto da un invasore formale, radicato nella società, ovvero il sistema patriarcale, che, mai come negli anni Venti e Trenta della nostra storia italiana, aveva rafforzato il principio secondo il quale le donne esistevano solo in relazione ad un uomo e l’ambiente nel quale realizzarsi e riconoscersi era la sfera domestica. Perciò, la resistenza armata femminile è il risultato dell’esperienza maturata nei decenni precedenti da tutte quelle donne che avevano vissuto sulla propria pelle il sistema repressivo e i suoi dogmi, posti come indiscutibili dal maschio.
In quest’ottica, dunque, la guerra e la Resistenza diventano il riscatto morale e la rivendicazione del diritto di essere donna. Tali esperienze sono state introiettate dalle autrici, anche se, come fa notare la dottoressa Marina Zancan, «sembrano configurarsi, negli immaginari delle scrittrici, come parte di una memoria storica che le contiene e le attraversa, senza tuttavia sedimentarsi in una tematica in sé definita»4. Come emerge dalle seguenti parole, nei libri delle scrittrici di questa fase, l’esperienza della Resistenza si fa allegoria proprio di questa duplice liberazione, non diventando il tema esclusivo e totalizzante della narrazione, bensì il presupposto per intraprendere una riflessione sul personale e sul corpo nello spazio, tema caro al femminismo. Quindi, il tema principale di queste scritture è «la scrittura stessa» e la Resistenza, intesa come «il luogo […] della propria individualità»5.

Un’altra questione con cui le donne partigiane dovettero scontrarsi fu il confronto con i maschi, i compagni. Un ulteriore scontro, quello contro una mentalità corrente, una mentalità che vedeva la donna incapace di sparare, di unirsi ad una lotta fisica per il semplice fatto di essere donna.
Questo è lo scenario che riscontriamo ne L’Agnese va a morire di Renata Viganò, ovvero la storia di una graduale presa di coscienza dove l’Agnese, donna comune dal carattere schivo (complice una vita difficile), che mai aveva avuto interesse per le «cose di politica e di partito, cose da uomini»6, a seguito dell’arresto del marito Paolo, per tutti Palita, accusato di cospirazione contro il regime, inizia a cambiare prospettiva su quelle cose “da uomini”. Agendo inizialmente più per istinto, come nel caso della presunta uccisione del tedesco che aveva sparato per gioco alla sua gatta, la quale rappresentava ciò che le restava di Palita, la sua militanza diventerà man mano più mirata e consapevole, dapprima nel ruolo di staffetta, poi nel ruolo di amministratrice del corpus delle staffette, fino ad arrivare ad essere considerata sullo stesso piano dei partigiani, senza alcun trattamento di favore.
La frase «Chissà se sarò buona»7 risuona più e più volte nelle parole dell’Agnese, che percepisce fin da subito il peso della sua responsabilità, ovvero di star combattendo per quella causa sostenuta in vita anche da Palita. L’Agnese, che risulta il nodo focale della narrazione, ma mai il centro (occupato invece dall’impegno partigiano suo, delle altre donne e uomini) è il risultato della commistione dell’esperienza di questa donna, realmente esistita e che Viganò conobbe, e della militanza partigiana della scrittrice.
Per quanto la critica abbia più e più volte mitizzato il personaggio di Agnese, da Innocenti che la definisce quasi una “martire” con poteri sovrumani, «un personaggio capace in tutto e per tutto di portare fino in fondo (fino alla morte) il proprio impegno resistenziale»8, a Vassalli, per cui l’«Agnese esce in pratica dalla realtà per diventare incarnazione di un mito destinato a compiersi con la sua morte»9, Viganò in persona, invece, che nutre per l’Agnese una profonda stima, demitizza la sua figura, riportandola su un piano realistico, in quel «clima di allora nella vita partigiana, antiretorico, anti-drammatico, casalingo e domestico»10.
Agnese, dunque, è una donna che crede nella causa per cui sta combattendo, che non agisce casualmente, bensì è animata proprio da quelle sue parole, “se sarò buona”, che la rendono umana, più vicina al lettore anche grazie alla capacità con cui Viganò ha saputo rappresentare i lati più femminili di Agnese, che la rendono non una donna che imita i partigiani maschi, ma una donna partigiana con le sue peculiarità di donna. Ed ecco, quindi, che Agnese è “mamma”: si occupa dei partigiani come fossero figli suoi, consola, piange e non nasconde le lacrime, ma è anche combattente che porta bombe e volantini nascosti nelle sporte e prende il comando di brigate partigiane.
Secondo il mio personalissimo parere, di Agnese, anche grazie alla magistrale trasposizione cinematografica omonima di Montaldo del ’76, è proprio questo che è sopravvissuto: non la morte in sé, non il sacrificio, ma la resistenza di una donna che ha fatto ciò che si doveva fare, e come lei tante altre donne. Anche nel presente, in questo presente fatto di incertezza, abbiamo tante nuove Agnese che resistono contro un nuovo nemico invisibile, il coronavirus.
Il coronavirus è stata una di quelle variabili che nessuno si sarebbe aspettato, ma, quando tutto il mondo fuori urlava e si disperava per la progressiva perdita di libertà, le donne si sono rimboccate le maniche e hanno iniziato una resistenza silenziosa, che, però, nel suo silenzio ha fatto rumore. Non sono eroine, sono semplicemente donne ed è nella natura delle donne fare ciò che è necessario.

Ma, anche questa volta, la lotta e la resistenza è contro un duplice nemico, il virus da una parte e il rischio dall’altra, anche se per “rischio” non mi riferisco a quello che si corre con il contagio. Questo rischio lo corre proprio il genere femminile in generale, in quanto un’idea corrente potrebbe cancellare decenni di diritti conquistati. Infatti, proprio perché le donne in primis si sono adoperate in prima linea durante questa pandemia, anche e soprattutto con le cure rivolte a malati, ad anziani e bambini, c’è il rischio che quello della cura torni ad essere l’unico ruolo di impiego delle donne, e ci sono tutte le condizioni perché ciò diventi una realtà fattuale e non il solito discorso retorico.
A causa di diverse variabili non indifferenti, lo scenario a cui stiamo assistendo è un ridimensionamento del ruolo della donna nella società: con le chiusure per prevenire il contagio, l’occupazione femminile è stata quella che ha sofferto di più e ha visto un crollo rispetto a quella maschile. Secondo il il Global Gender Gap Index (report annuale che verifica il livello di disuguaglianze di genere secondo determinati parametri sociali quali occupazione, istruzione, salute ed empowerment politico), complice anche e soprattutto la pandemia, saranno necessari 136 anni circa per colmare il divario di genere.
Anche le chiusure di scuole e asili nido hanno portato ad un aumento dei doveri familiari, che hanno costretto le donne a dover coniugare in maniera impeccabile vita lavorativa e vita familiare, conciliando smart-working, faccende domestiche e affiancamento dei figli nella didattica a distanza. Lo stare a casa è stata la soluzione al contagio, ma non per tutti: la pandemia ha visto una crescita esponenziale dei femminicidi e delle violenze di genere. Secondo il rapporto del Servizio analisi criminale della Polizia, nel 2020 il numero delle vittime di femminicidio è aumentato di un punto in più rispetto all’anno precedente, passando dalle 111 vittime del 2019 alle 112 del 2020.
Tutti questi dati, a mio parere necessari per avere chiaro quanto sia tangibile la nuova crescita della disparità di genere, aprono la strada ad un solo scenario, uno scenario tragico, uno scenario al quale è doveroso iniziare a porre rimedio, non solo “facendo ciò che è giusto e necessario” e con una sistematica sensibilizzazione, ma con un’immediata presa di coscienza secondo il “modello Agnese”.
Bibliografia
- ANDREINA DE CLEMENTI, Uguaglianza e differenza nella storiografia italiana, in «Genesis», VIII/1, 2009, p. 87.
- Ivi, p. 88.
- RENATA VIGANÒ, Donne della Resistenza, Bologna, STEB, 1955, p. 7
- MARINA ZANCAN, Le autrici. Questioni di scrittura, questioni di lettura, in Letteratura italiana del Novecento. Bilancio di un secolo, a cura di Alberto Asor Rosa, Torino, Einaudi, 2000, p. 121.
- Ibidem, p. 121.
- RENATA VIGANÒ, L’Agnese va a morire, Einaudi, Torino, 1949, p. 20.
- Ibidem, p. 20.
- ORSETTA INNOCENTI, Agnese e le sue sorelle: immagini femminili nella Resistenza, in «Patria Indipendente», a. MMIV, n. 2, art. del 22/02, p. 16.
- SEBASTIANO VASSALLI, Introduzione de L’Agnese va a morire, Einaudi, Torino, 1949, p. 3.
- RENATA VIGANÒ, La storia di Agnese non è una fantasia, in L’Agnese va a morire, Einaudi, Torino, 1949, p. 217.