Lo sport è davvero attività fisica
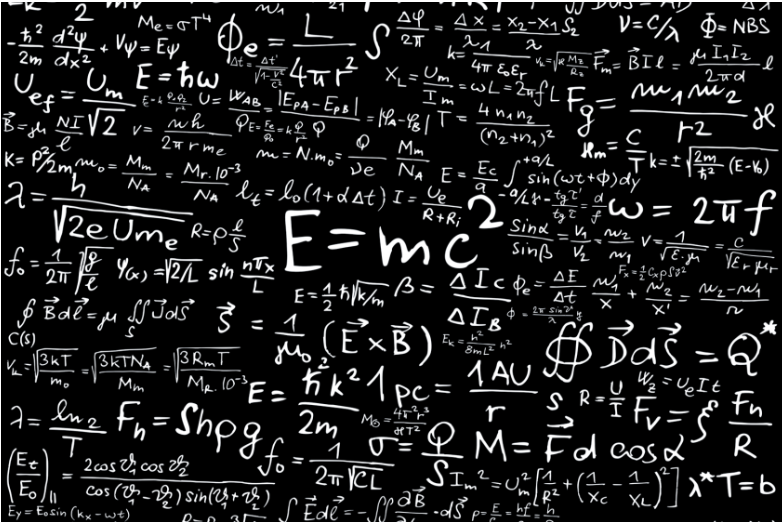
Le tre leggi di Newton descrivono in modo elegantemente deterministico come prevedere il futuro. Non servono sfere di cristallo e doti di divinazione: basta conoscere la velocità iniziale di un proiettile e la sua angolazione rispetto al terreno per costruire la sua traiettoria e sapere a che distanza cadrà. Newton è stato in grado di riassumere in tre semplici leggi il moto del mondo macroscopico, che si parli di una mela che cade dall’albero oppure delle orbite dei pianeti del Sistema Solare. L’applicazione di queste (e di molte altre) ha trovato prevedibilmente grande successo nello sport e nelle sue più raffinate tecniche.
La prima legge afferma che un corpo mantiene il proprio stato di quiete o di moto rettilineo uniforme, finché la risultante delle forze agenti su di esso è nulla, ovvero ci dice che per far variare la velocità di un corpo dobbiamo sempre applicare una forza, in caso contrario questo continuerà per sempre a muoversi alla stessa velocità (o se era fermo rimarrà tale). La forza in fisica è un vettore, dotato di modulo, che ne descrive l’intensità, direzione e verso; per visualizzarla basta immaginare una freccia.
Ma allora perché in autostrada, anche se il tachimetro non si sposta dai 130 km/h, il serbatoio si svuota comunque e anche troppo velocemente? Perché se accelero la mia bicicletta fino a 10 km/h per poi smettere di pedalare, questa prima o poi si fermerà? Ciò non contraddice il primo principio, in quanto quello che fa frenare la macchina o la bicicletta è la forza d’attrito (del suolo, dell’aria e delle parti che compongono la bicicletta o la macchina!). L’attrito è dovuto alle interazioni tra materiali e/o sostanze ed eliminarlo del tutto è impossibile: ciò lo rende la principale causa di consumo di carburante e diventa trascurabile (ma non assente) solo nello spazio.
La seconda legge enuncia che : l’accelerazione è nella direzione della forza ed è proporzionale alla sua grandezza e inversamente proporzionale alla sua massa (o meglio a=F/m); questa aumenta per quanta più forza applichiamo (più forza applichiamo maggiore sarà l’accelerazione) e diminuisce quanta più è la massa del corpo che spostiamo. Questo spiega perché frenare un automobile è più difficile che frenare una bicicletta.
La terza legge di Newton, detta anche legge di conservazione della quantità di moto, recita, nella sua forma più semplice: ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. La quantità di moto è il prodotto di una massa per la sua velocità ed è una quantità che, in una situazione su cui non intervengono forze esterne, viene sempre conservata.
Il puro gesto di correre è una conseguenza di questo: l‘atleta esercita una spinta con il piede sul terreno, questo fa altrettanto sul piede del corridore, spingendolo in avanti. È ancora più evidente nel fenomeno del rinculo della pistola: il proiettile viene sparato ad una velocità molto elevata, l’arma quindi verrà spinta indietro con uguale quantità di moto.
Un altro contesto applicativo per la terza legge è quello degli urti: nel golf la mazza colpisce la pallina, prima ferma, portando la sua velocità a valori molto diversi da zero, perché, in buona approssimazione, la quantità di moto tra i due oggetti si conserva. Ciò ci collega al concetto di “impulso”, ovvero il prodotto tra la forza e il tempo: possiamo ottenere lo stesso risultato applicando una forza molto intensa per un breve periodo di tempo oppure una forza meno intensa per un periodo maggiore.
Questo aspetto è molto importante in fisiologia muscolare: se vengono generate forze troppo intense si possono avere danni alle strutture contrattili (strappo muscolare) o tendinee (tendinite).
Si può fare ricorso alla quantità di moto anche nell’ambito delle arti marziali: per definizione, si conserva il prodotto tra la massa e la velocità; ciò implica che un karateka sarà in grado di colpire il suo avversario con lo stesso impulso sia con un pugno “lento”, accompagnandosi con tutto il corpo (massa maggiore e velocità minore), sia con un solo colpo del braccio, ma molto veloce.
Un elemento cardine nel successo nelle discipline sportive è l’equilibrio, e la branca della fisica che se ne occupa è la statica. Occorre fare riferimento al concetto di baricentro, il punto teorico in cui si concentra il peso di un corpo: per rimanere in equilibrio è necessario che il baricentro si trovi sulla linea di appoggio, la retta immaginaria perpendicolare al terreno che passa per il punto in cui i piedi toccano il suolo. Più il baricentro è basso, più è facile restare diritti. Si spiegano così fenomeni comuni, come il fatto che sia più difficile stare in equilibrio su un piede solo, ma il baricentro risulta fondamentale per discipline in cui mantenersi in equilibrio determina la vittoria, come il judo e il sumo, oppure ambiti dove l’equilibrio è fattore determinante per il punteggio, come la ginnastica artistica.
In un sistema isolato in moto rotazionale, si conserva il momento angolare, definito come il prodotto vettoriale del raggio per la quantità di moto. È possibile verificare questa legge sedendosi su una sedia girevole con dei libri pesanti in mano: se teniamo le braccia aperte, il moto sarà più lento, perché il “braccio” della forza è ampio. Se invece le raccogliamo vicino al petto, la rotazione sarà più veloce, senza che noi abbiamo aumentato la spinta.
Ciò spiega perché le ballerine chiudono le braccia per guadagnare velocità: chiudendo le braccia il raggio diminuisce, quindi è necessario che aumenti la velocità affinché questa quantità venga conservata. La stessa legge spiega perché una trottola sta in equilibrio finché gira.
È estremamente affascinante fermarsi a pensare che dietro, o dentro, i nostri gesti più semplici o le tecniche sportive più complesse ci siano delle forze nascoste, che abbiamo imparato a osservare e delle cui possiamo prevedere le conseguenze, al ritmo di un’orchestra di cause ed effetti.
p. 4→
← p. 2

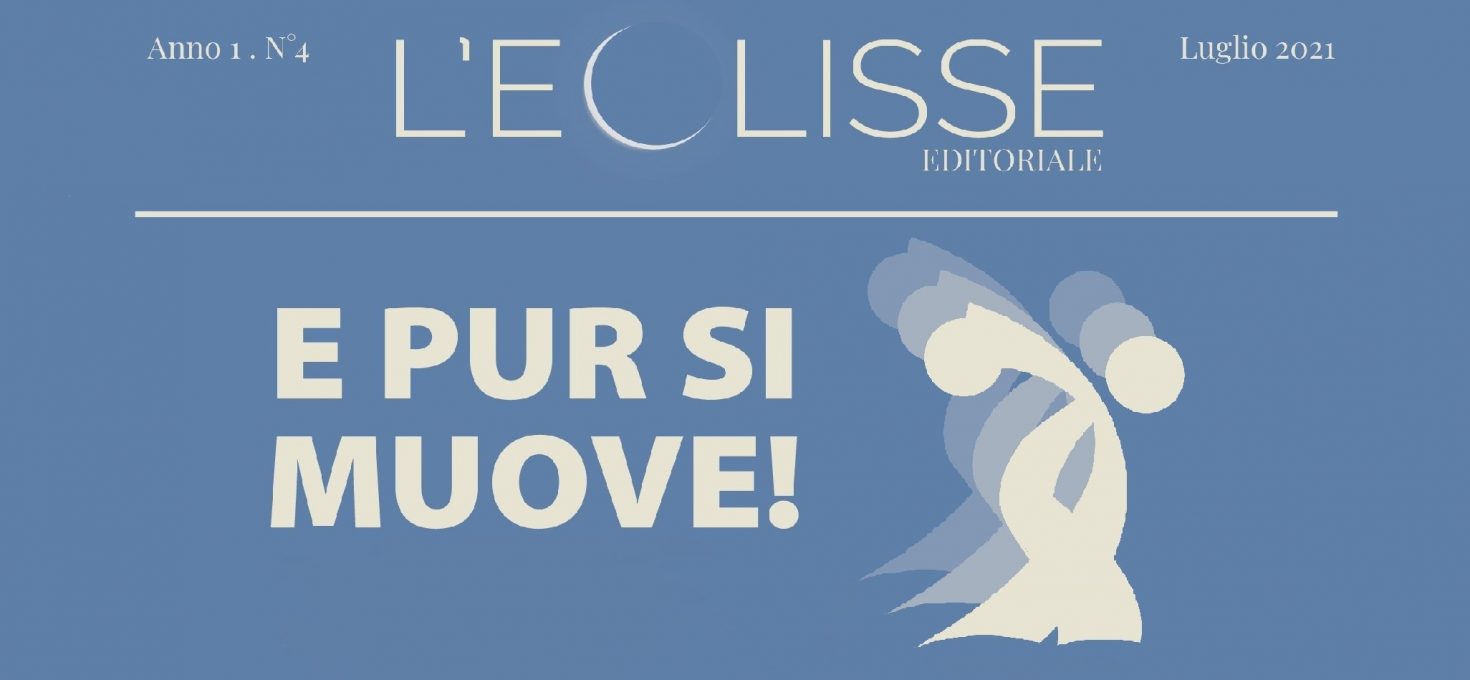

[…] di riunirsi e lo sport, come vi abbiamo raccontato quattro anni fa nell’editoriale a tema, E pur si muove!, è a tutti gli effetti una parte importante del panorama culturale di una nazione, anche se spesso […]