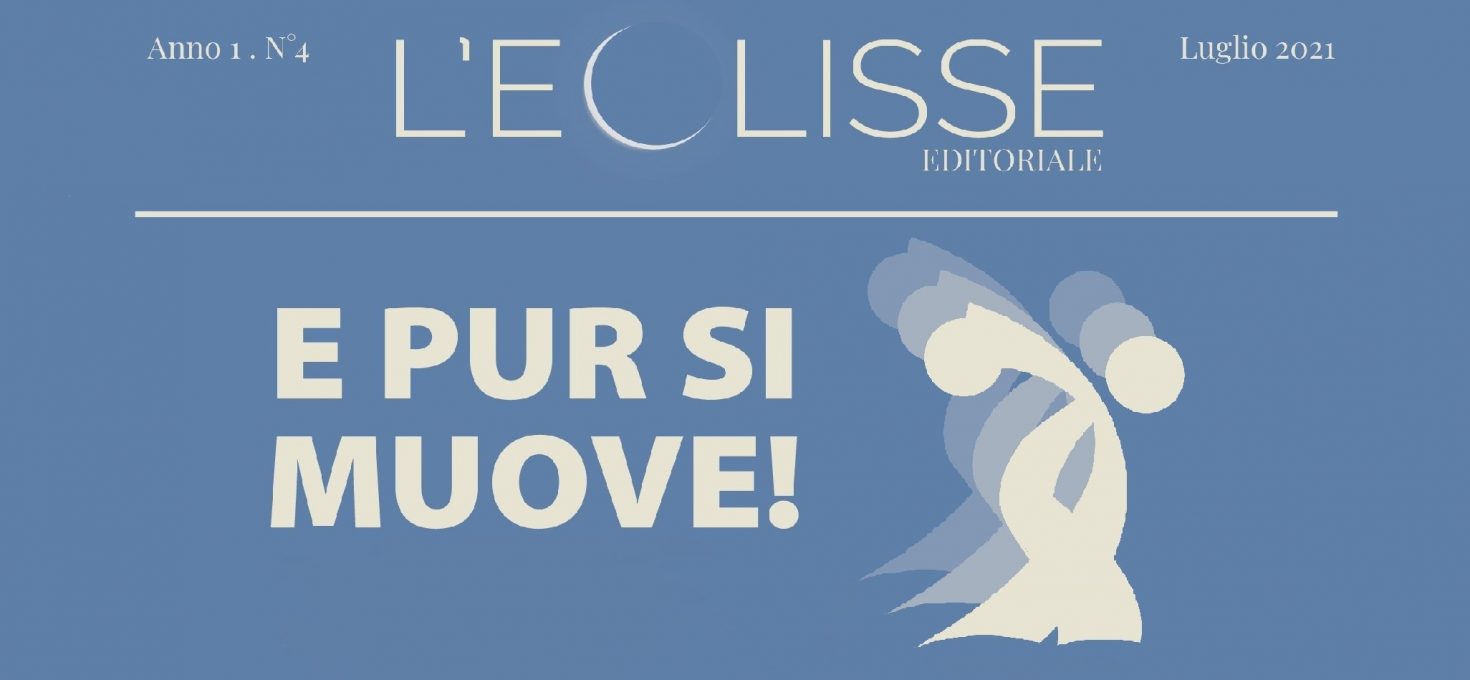Dall’inconscio al movimento: Ohad Naharin, la Batsheva Dance Company e il linguaggio Gaga
Ricordo che, poco dopo aver scoperto il lavoro del coreografo contemporaneo Ohad Naharin ed esserne rimasta folgorata, ne ho parlato a mia madre, sempre pronta a scoprire qualcosa di nuovo e ascoltarmi quando sono entusiasta di qualcosa. Quella sera, abbiamo guardato lo spettacolo del 2010 Decadance (lo potete trovare intero su youtube, qui). Più o meno a metà della performance, davanti ad un passo a due che a me ha fatto venire letteralmente la pelle d’oca, mia madre ha iniziato a commuoversi: è stata una reazione forte, soprattutto considerando che non è mai stata un’appassionata di danza. Viene da chiedersi il perché ci sia stata una reazione così potente in lei (e nelle tantissime altre persone che ammirano gli spettacoli di questo coreografo), anche se credo che la risposta sia piuttosto semplice: Naharin, attraverso i corpi dei suoi ballerini, va a toccare le corde più profonde degli esseri umani. Egli riconosce e sottolinea le radici ancestrali su cui poggiano la danza e il ballo, lasciandole esprimere genuinamente. I movimenti dei suoi ballerini sul palco ci sembrano quasi animaleschi, per ricordarci che, per quanto civilizzata e moderna ci sembri questa quotidianità, il nostro muoverci nel mondo è formato da comportamenti dettati dai medesimi istinti che ci guidavano quando eravamo primati. La danza, in particolare, è un bisogno che l’essere umano ha manifestato sin dall’alba dei tempi: è una forma artistica che abbiamo sempre praticato come parte integrante di rituali collettivi, di momenti di preghiera e di condivisione. Ancora oggi, nel momento in cui il mio orecchio entra in contatto con certi ritmi e melodie, al mio corpo viene istintivo muoversi.


L’istinto di ballare ed entrare in contatto col proprio corpo si manifesta in Ohad Naharin sin dalla tenera età: nasce nel 1952 e cresce in un kibbutz in Israele, vive quindi la sua infanzia e adolescenza insieme ad una comunità di famiglie, dove può iniziare ad esplorare la propria corporeità e le proprie sensazioni attraverso il movimento e il ballo. La sua creatività è evidente anche quando presta servizio nell’esercito israeliano, dove inventa piccole coreografie per intrattenere i compagni. Dopo l’esperienza militare, costruisce pian piano la sua carriera da ballerino: inizialmente si unisce alla compagnia di danza di Tel Aviv, la Batsheva Dance Company, che lo porta a lavorare con Martha Graham, per poi spostarsi negli Stati Uniti. Qui, oltre a conoscere la ballerina Mari Kajiwara, che diventerà sua moglie, viene accettato nella prestigiosa compagnia di Maurice Béjart, da cui poi si staccherà autonomamente per “l’eccessiva intensità delle prove”.
Tornato in Israele, assume la direzione della Batsheva Dance Company (dove lavora tutt’ora) ed è proprio qui, nella sua terra natia, che inizia a sviluppare il suo linguaggio Gaga: con questa parola bisillabica, tipica di un vocabolario infantile, il coreografo definisce un linguaggio che utilizza le braccia, le gambe e il busto al posto della parola scritta per raccontarci qualcosa.
Naharin si allontana dai rigidi schematismi della danza classica, avvicinandosi, in questo modo, alla componente istintiva e senza filtri dell’animale-uomo. Il danzatore – e questo deve essere ben chiaro – non potrà mai raggiungere la perfezione, e per questo non deve neanche cercarla, ma deve entrare in contatto con l’essenza più profonda che lo domina per migliorare la sua consapevolezza. Il corpo, mentre si muove, deve essere lasciato libero di prendersi il suo spazio e riempirlo con le forme che crea. “Prima di comandare al corpo cosa deve fare, devi ascoltarlo” dice Ohad Naharin ai suoi ballerini. Anche per questo motivo, nella sala prove non esistono specchi, perché distraggono il ballerino e lo fanno focalizzare sull’aspetto esteriore del movimento.
Grazie a tutti questi presupposti, le coreografie interpretate dai danzatori della Batsheva Dance Company, appaiono estremamente potenti e personali. Tra i pezzi più famosi, troviamo Echad mi yodea, dove vengono inseriti anche elementi provenienti dalla tradizione culturale ebraica, che è un’altra componente molto presente nelle opere di Naharin.
In sostanza, danzare è un atto estremamente intimo: tutt* noi non dovremmo essere restii a farlo, perchè ci mette in connessione con il luogo che abitiamo ogni giorno. Dovremmo danzare tutt* più spesso, qualunque sia l’età e la nostra predisposizione alla danza. In particolare, questo messaggio viene espresso chiaramente in un pezzo all’interno dello spettacolo Decadance: i ballerini, vestiti con dei normalissimi completi neri, eseguono una breve coreografia iniziale, per poi scendere in platea e portare sul palco persone scelte a caso nel pubblico. I passi dei professionisti guidano i movimenti impacciati delle persone “normali” e si mescolano in una genuina esperienza collettiva. L’atmosfera che si forma è quella gioiosa e tribale di una festa tra amici, anche se ciò a cui stiamo assistendo è un puro momento di condivisione tra sconosciuti.
Con Ohad Naharin e il linguaggio Gaga, la danza ritorna alla sua dimensione primordiale, mettendo in risalto movimenti semplici che riescono a far trasparire le nostre emozioni inconsce e ancestrali.
p. 8→
← p. 6