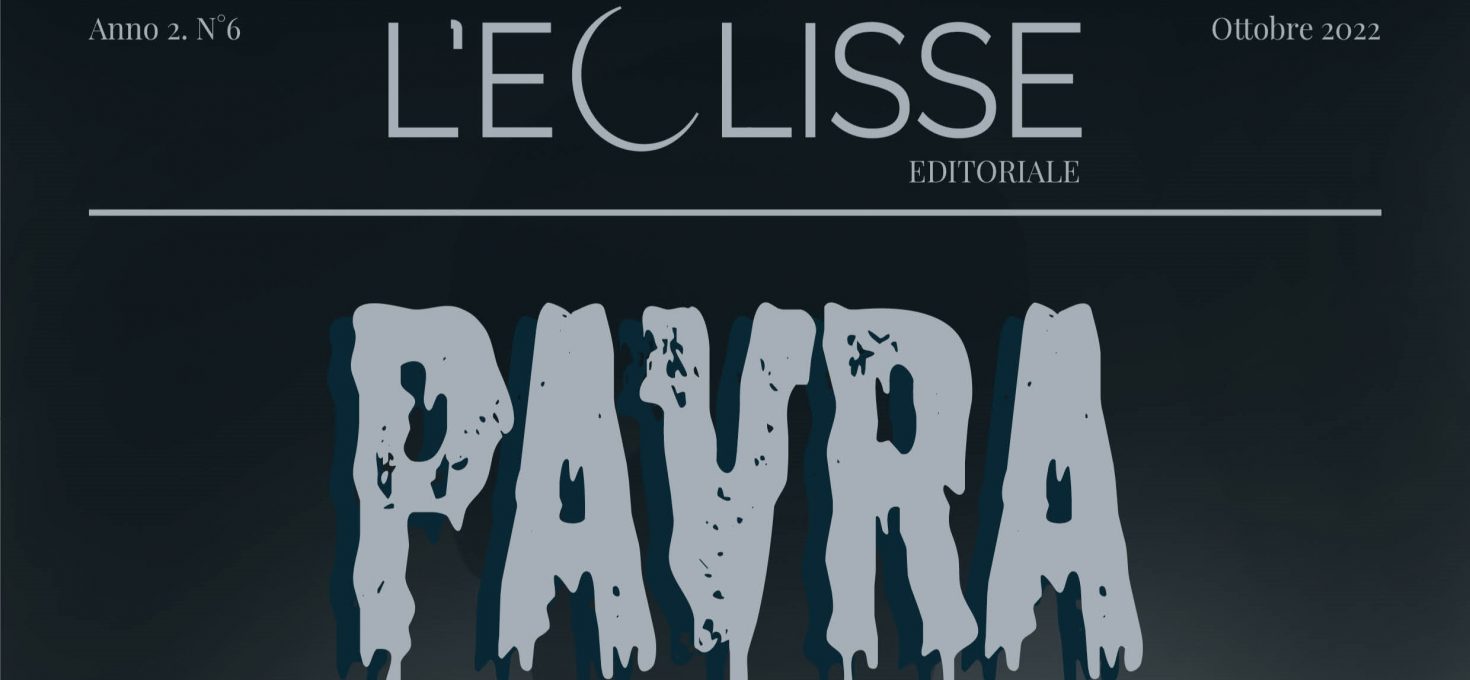La poetica di Jordan Peele: l’umano come più grande paura
Notte fonda. Da poco coricato nel letto sento il bisogno di andare in bagno. Varco la soglia della mia camera e, da qualche parte nell’oscurità, si trova la porta del bagno. Dopo un solo passo, il mio corpo viene colpito da un fremito di timore: «meglio accendere la luce», penso. L’accendo e vado verso la porta.
Questo semplice racconto introduttivo ha la grande valenza di esemplificare al meglio il concetto di timore o, se vogliamo, di paura. Difatti, cosa mi costava non accendere la luce e andare verso il bagno, per lo più in un luogo tanto conosciuto come casa mia? La risposta è figlia della nostra natura umana, legata ancora ai primordi della nostra specie. La paura è qualcosa che portiamo con noi fin dall’alba dei tempi e tuttora ci accompagna lungo la nostra vita.
La nostra paura non è semplicemente rivolta al mostruoso, l’innaturale, all’altro da noi, bensì si volge verso i meccanismi più torbidi e inconsci della nostra mente. La ricerca di noi stessi passa anche nell’analizzare ciò che terrorizza e inquieta le nostre vite. Quale miglior mezzo se non l’arte per analizzare questo tema? Tra tutte le arti, il cinema è sicuramente una delle più dirette, delle più crude, che ci feriscono l’animo.
Tra i vari artisti capaci di tale analisi, troviamo Jordan Peele, regista afroamericano, che ha reso l’indagine della paura il suo marchio di fabbrica autoriale.
Capitolo 1: Peele

Peele, attore e comico, riesce a dare il meglio di sé nel dramma. La carriera da comico inizia nel 2003 nel programma televisivo “Mad Tv”. Dopo svariati ruoli in serie e film, debutta sul grande schermo dietro la macchina da presa nel 2017.
L’analisi orrorifica di Peele tocca le paure più connesse all’animo del nostro tempo: la più grande paura dei personaggi dei suoi film, infatti, non è qualcosa di esterno alla loro natura, ma, viene messa alla berlina la società umana colma degli incubi peggiori che la feriscono. È la natura umana spaventata da se stessa e dall’istituzione sociale, base di tutte le civiltà, che funge da punto di partenza di un grande calderone tematico portato sul grande schermo dal regista americano. Al suo interno, possiamo individuare due argomenti pilastro della poetica peeliana: il razzismo e la paura dell’oblio (sinonimi di esclusione o morte).
Ora andrò a focalizzare il mio articolo sulle tre opere del regista.
Capitolo 2: Bianche Perversioni (Get Out, 2017)
Quale miglior debutto potrebbe mai sognare un regista emergente se non uno alla pari di “Get Out”? Il lungometraggio con Daniel Kaluuya (Oscar Miglior Attore 2021) è la spietata e malata analisi del razzismo, qui messo in scena quasi come una malattia congenita dell’uomo, e della psicopatica smania umana di sfuggire dalla soglia funerea della morte.

Chris Washington (Kaluuya) viene ospitato dalla famiglia della sua fidanzata bianca, tuttavia prova una sorta di razzismo latente verso i bianchi, mischiato a imbarazzo e confusione perché non è abituato a frequentare i bianchi. Allo stesso tempo, la famiglia Armitage è il quadro perfetto di quella classe agiata bianca soffocata da nevrosi e paure, in preda ad una psicopatologia quotidiana inguaribile. Niente e nessuno è amico di Chris, nemmeno i pochi afroamericani che incontra lungo il film. Isolato e inquietato, Chris dovrà sfuggire dal vortice ipnotico in cui Peele ci fa cadere (come in una celebre sequenza del film) che porta lo spettatore faccia a faccia con la pazzia umana.
La conclusione del film non ci fa uscire completamente liberi e guariti dalle nostre paure, anzi le acuisce all’estremo. La tensione sociale e razziale del film mostra una realtà non tanto lontana dalla nostra: paradossalmente, la famiglia bianca non ne esce solo come puramente razzista, ma anche come estremamente classista, malamente utopista e inguaribilmente spaventata dalla soglia finale, la morte.
Capitolo 3: Tu sei l’altro (Us, 2019)
Oltre al messaggio antirazzista in “Us” (Noi, 2019), scorgiamo molto di più. Qui, il pericolo non è più la psicosi di un’intera famiglia, ma il terrore scaturisce da qualcosa di estremamente intimo. In viaggio con il marito e i due figli, Adelaide torna a Santa Cruz dopo trent’anni dall’ultima misteriosa volta. Ogni cosa è al suo posto finché, una notte, quattro individui si introducono in casa loro per ucciderli. Quei quattro individui sono sosia dell’intera famiglia.

Fonte: https://cinemacao.com/2019/03/26/critica-nos-us-2019/
Da questo presupposto, parte la seconda opera di Peele. Aldilà di considerarla migliore o peggiore rispetto alla precedente, dobbiamo sottolineare come l’analisi artistica del regista prenda una strada ancor più strettamente di critica sociale. Grazie a magnifiche sequenze, vengono toccati temi come lo schiavismo (del passato e del presente) o l’alienante meccanismo produttivo e capitalistico della nostra organizzazione sociale. Se in “Get Out” la paura più grande era la morte, dunque la panacea era continuare a vivere tramite qualsiasi mezzo, in “Us” il terrore è quello dell’esistere senza vivere, che colpisce i quattro gemelli e la sola cura è la ribellione. Purtroppo, la sopravvivenza sociale è una triste verità della società occidentale – parlo ora unicamente dell’Occidente per non scomodare l’Oriente, che conosco poco – in cui molti non vivono, anzi esistono (che è ben diverso!). Il finale non porta ordine al conflitto iniziale, al contrario esplode il caos: si tratta forse dell’anarchia caotica che, a poco a poco, colpirà tutto l’ingranaggio sociale della nostra realtà?
Capitolo 4: Preda e Predatore (Nope, 2022)
Nel terzo tassello della sua produzione, Peele abbandona quasi del tutto il termine cardine del razzismo, lanciandosi in una rappresentazione più complessa, che rende “Nope” il film più intricato del regista. Una famiglia afroamericana, celebre per affittare cavalli a produzioni cinematografiche, viene tormentata dalla presenza di una singolare nuvola in cielo che ingoia ogni cosa che appaia sotto di sé. In questo caso, le poche righe che ancora posso permettermi non daranno giustizia alla complessa struttura filosofica del film, ma, nonostante questo, cercherò di spiegarvi almeno dei due principali significati che l’opera si attribuisce.
Il primo è la rappresentazione quasi plastica della sfida tra preda e predatore, duello in cui le due parti si confondono: l’essere umano, da preda instupidita, diviene a poco a poco predatore. Il secondo è l’enorme critica messa in scena in maniera sibillina dalla macchina cinematografica moderna (una sorta di mostro che ingoia ogni cosa senza rimorso) contro la cinematografia indipendente (portata in scena da una piccola telecamera). Peele si permette di parlare del proprio mondo lavorativo e ne tratta in maniera fortemente critica.
Capitolo 5: La rinascita dell’horror autoriale main-stream
Peele ha il grande merito di aver riportato insieme ad altri (come Ari Aster e Robert Eggers) un tipo di visione autoriale dell’horror nelle grandi sale, facendolo divenire mainstream – basti pensare agli incassi delle sue produzioni. Non credo si possa ancora parlare di “maestro del cinema”, ma penso che la nuova generazione di registi della paura (analizzata sempre da me anche nell’articolo su The Northman di Robert Eggers) stia portando nella produzione cinematografica una freschezza rinvigorente. Starà ora a Peele rinnovarsi ancora di più e cercare, forse, un giorno, di uscire dalla chiave horror per aprirsi a nuovi generi.
L’horror è una delle vie migliori per analizzare le nostre paure, ansie e nevrosi. La verità su noi stessi è forse una rivelazione troppo grande per poterla raggiungere, per cui l’arte cerca di aiutarci in questa ricerca, traducendo le palpitazioni dell’animo non donandoci la verità assoluta, ma nuovi dubbi da cui partire.
PAVRA
Editoriale · L’Eclisse
Anno 2 · N° 6 · Ottobre 2022
Copertina di Laura Maroccia.
Hanno partecipato alla realizzazione di questo editoriale: Greta Beluffi, Matteo Capra, Michele Carenini, Anna Cosentini, Joanna Dema, Clara Femia, Eugenia Gandini, Marta Gatti, Chiara Gianfreda, Nikolin Lasku, Rosamaria Losito, Matteo Mallia, Laura Maroccia, Giovanni Melli, Marcello Monti, Valentina Oger, Alessandro Orlandi, Matteo Paguri, Luca Ruffini, Arianna Savelli, Tommaso Strada, Vittoria Tosatto, Marta Tucci, Marta Urriani, Francesco Vecchi, Adriano Zonta.