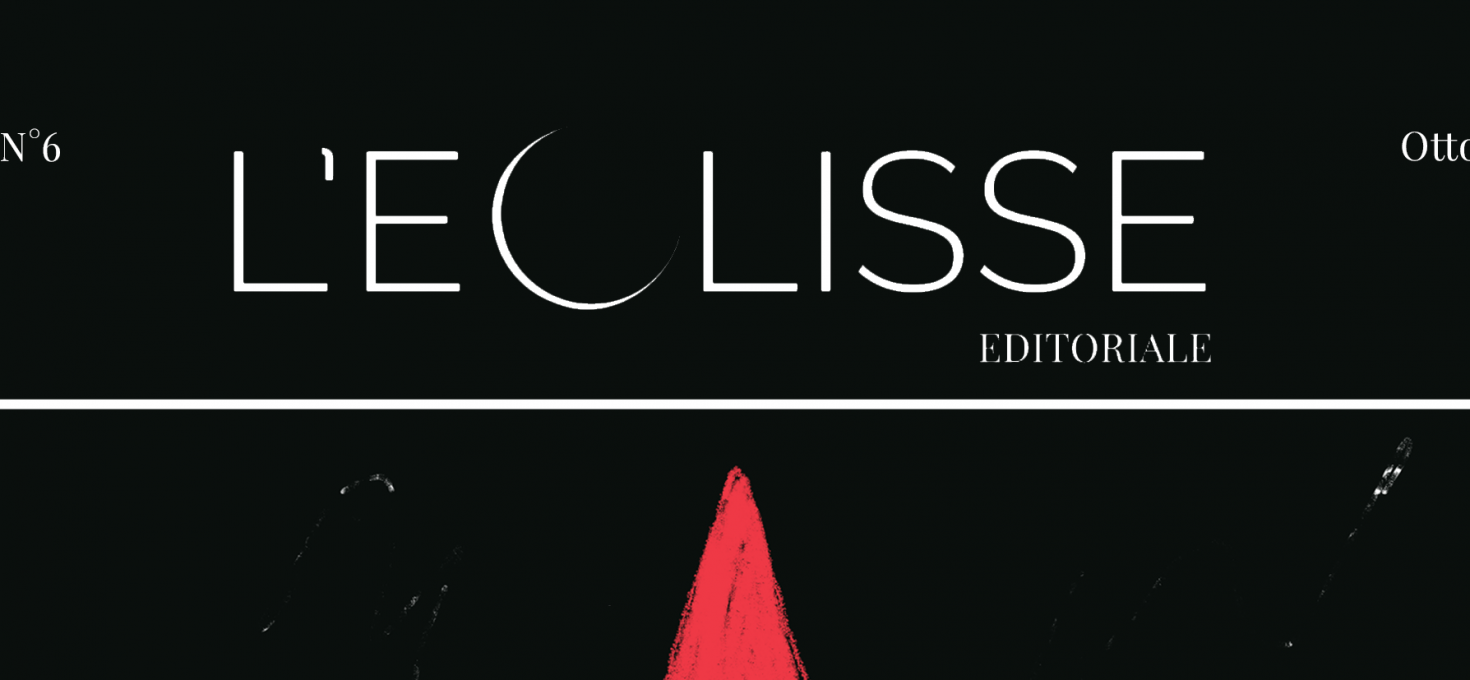Far finta di essere sani
«Vivere, non riesco a vivere / Ma la mente mi autorizza a credere / Che una storia mia, positiva o no / È qualcosa che sta dentro la realtà».
Così inizia la canzone Far finta di essere sani1 , pubblicata nell’omonimo disco nel 1973 da Giorgio Gaber. Questa canzone, che quest’anno compie 50 anni, è ancora fortemente contemporanea nella descrizione della nostra società.
Giorgio Gaber, pseudonimo di Giorgio Gaberščik, nasce a Milano nel 1939 ed è ricordato come uno dei più importanti cantautori e precursori del teatro canzone della seconda metà del secolo scorso. Durante tutta la sua carriera, Gaber si è occupato di politica e della società nel suo senso più ampio: attraverso le canzoni, dipingeva il panorama politico e sociale italiano, senza risparmiare critiche. Nel 1970, rinuncia al successo televisivo degli anni precedenti e decide di portare le sue canzoni a teatro, creando “il Signor G”, un personaggio che recita lui stesso. Gaber lo descrive come un uomo comune, dicendo “il signor G è un signor Gaber, che sono io, è Luporini, noi, insomma, che tentiamo una specie di spersonalizzazione per identificarci in tanta gente”2.
Gaber non porta solamente le sue canzoni a teatro, ma le arricchisce con monologhi e racconti. Inizia anche in questo periodo la collaborazione con l’amico Sandro Luporini, il quale lo aiuta a scrivere i testi sia dei monologhi che delle canzoni. Nella stagione 1972-1973, tra le canzoni che più rimangono impresse nella mente delle persone (e che sono tra le più celebri ancora oggi) sono La libertà e Lo shampoo: in quest’ultima, attraverso la metafora della schiuma, Gaber tratta del tema della rinuncia al pensiero critico da parte della maggior parte della società.
Per la stagione teatrale 1973-1974, Gaber e Luporini portano Far finta di essere sani, spettacolo che verrà rappresentato nel corso degli anni 182 volte e visto da circa 186,000 persone. Gaber approfondisce un tema ancora contemporaneo, ossia l’incapacità dell’uomo di far coesistere l’ideale con il personale, la sfera politica con quella personale e intima. Un’incapacità che non è, appunto, tipica solamente dell’uomo della seconda metà del Novecento, ma è un sentimento che persiste ancora tutt’oggi.

L’uomo che viene dipinto in questa canzone è un uomo fortemente turbato dalla società consumistica: sia il protagonista che la moglie (“una donna normale”) sono portati dalla società dei consumi e dalla pubblicità a comprare oggetti di cui non hanno un reale bisogno, ma che viene loro indotto. Lui decide di comprare “una moto / Telaio e manubrio cromato / Con tanti pistoni, bottoni e accessori più strani”, mentre lei, in piena crisi matrimoniale, “riesce anche ad esser fedele / Comprando sottane, collane e creme per mani”. La società dei consumi, iniziata in Italia con il boom degli anni ’60 dopo un decennio difficile a seguito della Seconda guerra mondiale, è la protagonista di questo brano. Se, da un lato, il protagonista della canzone compra oggetti di cui non ha un reale bisogno, accessoriando la sua moto nel modo più completo possibile, la moglie riesce addirittura a sublimare una potenziale crisi matrimoniale comprandosi accessori e creme. Entrambi sono persone semplici, non hanno grandi pretese. Sono persone omologate alla massa, comprano oggetti che ormai hanno tutti e che tutti sentono il bisogno di avere. Ciò che Gaber analizza sono uomini e donne che vivono in una bolla creata dalla società massificata, che appiattisce tutte le differenze e le singolarità degli individui, addirittura fino ad standardizzare i loro acquisti.
L’uomo che descrive Gaber siamo noi, un uomo che sente il bisogno di sfogare la sua solitudine e alienazione nei bisogni materiali, nelle cose. Sono passati cinquant’anni dall’uscita di questo brano, ma potrebbe essere stato scritto qualche mese fa. L’umanità occidentale, permeata dalla pubblicità e dai beni materiali, non è riuscita ad evolversi in meglio; forse siamo solo peggiorati. Compriamo sempre di più e pensiamo sempre di meno. Le nostre vite, per un motivo o per un altro, sono sempre più simili a ripetizioni automatizzate: tutte uguali. Il bisogno che ci creano le grandi aziende e le pubblicità (un tempo attraverso la televisione, oggi forse sempre di più attraverso gli adv sui social) colmano un vuoto quasi esistenziale che è in noi. Non sappiamo neanche più perché compriamo così tanto, lo facciamo e basta, senza pensare a tutte le conseguenze che ciò comporta: dall’ambiente allo sfruttamento in altri continenti.
“Liberi, sentirsi liberi / Forse per un attimo è possibile / Ma che senso ha se io sento in me / La misura della mia inutilità”: l’uomo di Gaber si rende conto di far fatica a sentirsi veramente libero e, nel momento in cui, forse, ci riesce, si rende conto della sua inutilità. Ed ecco che il consumismo si insinua nella sua (nostra) vita, apparendo come una risposta palliativa al senso di vuoto che permea l’esistenza. L’uomo arriva anche a contemplare il suicidio, ma decide di rimandarlo: il signor G è la personificazione dell’uomo comune che vive in una realtà quasi psicotropa, in cui non distingue realtà e finzione, nella quale non riesce neanche a prendere la decisione di porre fine al suo dolore esistenziale.
Inoltre, ’uomo di cui ci parla Giorgio Gaber non riconosce nemmeno i piani del reale e dell’ideologia: vi è una forte tensione tra gli ideali (“Le masse, la lotta di classe, i testi gramsciani”) e la massificazione, che ha portato inevitabilmente all’omologazione. All’interno della canzone vi è questa forte tensione tra il piano ideologico, rappresentato dal comunismo e dalla lotta di classe – ideali ai quali il Signor G dovrebbe tendere – e il piano reale, che lo porta a essere un semplice omologato della borghesia, piegandosi allo sviluppo dei bisogni materiali in maniera quasi ossessiva.
«Il Signor G vive, nello stesso momento, la voglia di essere una cosa e l’impossibilità di esserla3»
L’uomo vorrebbe riuscire a tendere verso gli ideali ideologici in cui crede, ma alla fine cede all’omologazione borghese. Il Signor G è un uomo stanco, che sogna di avere energie sufficienti per riuscire a realizzare uno di quei viaggi in paesi lontani, “Che va a realizzarsi in India o in Turchia / Il suo salvataggio è un viaggio in luoghi lontani”. Ovviamente, sono tutti sogni che non riesce a realizzare a causa della sua immobilità, che potremmo paragonare allo Spleen di Baudelaire.
L’uomo contemporaneo non è molto cambiato rispetto a quello di cinquant’anni fa descritto da Gaber. Ancora oggi, ci ritroviamo nella stessa situazione del Signor G: abbiamo tanti ideali, tanti sogni, idee da sviluppare per il futuro, ma, allo stesso tempo, facciamo fatica a concretizzarli nella vita di tutti i giorni, proprio perché viviamo in una società che ci impedisce di sviluppare realmente la nostra individualità e tende a volerci omologati. E noi, a causa di una natura tendenzialmente pigra, facciamo fatica ad emanciparci da questa condizione. Quelli che ci riescono, sono pochi e spesso li invidiamo.
La canzone di Gaber e Luporini finisce con una immagine forse ancora più drammatica: non sono solo gli adulti a vivere una vita triste, priva di veri sentimenti. Gaber, prima del ritornello, termina la canzone con questa immagine: “E vedo bambini cantare / In fila li portano al mare / Non sanno se ridere o piangere e batton le mani”. Ci descrive i bambini che vengono portati in gita, forse una colonia estiva tipica del tempo, i quali, però, non sanno se ridere o piangere: non sanno nemmeno esprimere il proprio lato più vulnerabile, ossia quello delle emozioni. Come risposta a questa sensazione di vuoto emotivo, questi bambini compiono un gesto puramente meccanico, privo di vera razionalità: battono le mani. Un gesto che si compie spesso, senza effettivamente pensarci, lo si fa come risposta in determinate situazioni senza chiedersi realmente perché lo si fa.
Il mondo di Gaber, che alla fine è ancora il nostro, è un mondo drammatico, nel quale le persone fanno finta di star bene, ma che è solo un’illusione di cui facciamo anche fatica ormai a renderci conto. L’illusione di star bene e la finzione del sé sono talmente radicate in lui – e in noi – che facciamo addirittura a rendercene conto. Le canzoni di Giorgio Gaber, anche se a decenni di distanza, sono ancora, per fortuna o purtroppo, ancora molto contemporanee.
Note
- https://www.youtube.com/watch?v=X9yvGh3qzxc
- G. Gaber, «Gaber-fluxus», in M. L. Straniero, Il signor Gaber, Gammalibri, 1979
- https://www.lanazione.it/viareggio/cultura/gaber-luporini-88889a32
- https://www.teatronazionalegenova.it/spettacolo/far-finta-di-essere-sani/