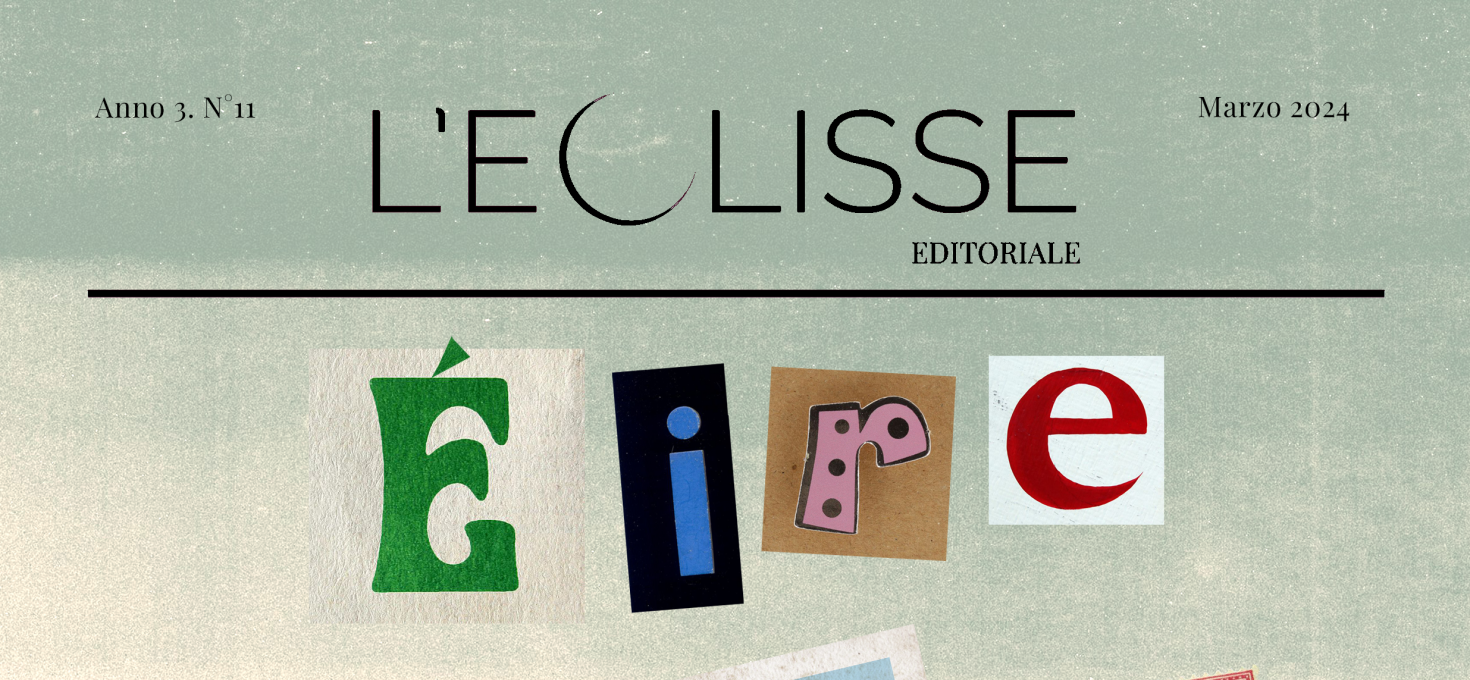Una storia post-coloniale dell’Irlanda
L’eredità imperiale e l’identità irlandese oggi
Come abbiamo imparato tutti alle scuole elementari, l’Irlanda è un’isola collocata all’estremità occidentale del continente europeo, confina con il Regno Unito e ha per lingua principale l’inglese. Tuttavia, pochi sanno perché si parli l’inglese e, non di rado, l’Irlanda viene intesa come parte integrante del Regno Unito (confusione fatta pure dalla nostra premier qualche tempo fa)1. Per darvi un altro esempio, la mia insegnante di geografia alle medie sostenne davanti alla classe che la lingua irlandese è una forma di inglese antico! La storia di quest’isola viene spesso ignorata in Italia, nonostante il fascino che essa esercita su di noi con i suoi paesaggi, la sua mitologia e le sue città. Quest’articolo, quindi, si pone l’obiettivo di spiegare in maniera introduttiva come la Storia irlandese ha influenzato l’identità contemporanea del suo popolo. Purtroppo, una spiegazione esaustiva non è possibile all’interno di un singolo articolo, ma la mia speranza è quella di suscitare interesse e spingere i lettori ad approfondire questa tematica.
Il primo punto da tenere in conto è la geografia stessa dell’Irlanda. L’Irlanda è “condannata” dalla sua posizione topografica, ai limiti del continente e circondata da mari impervi e difficili da navigare. Questa collocazione ha causato una marginalizzazione dell’Irlanda dai circuiti storici europei, isolandola da fenomeni comuni al resto del continente: per fare due esempi concreti, l’Irlanda non conobbe mai né la dominazione romana, né, tantomeno, le invasioni barbariche del V secolo d.C.. Anche geneticamente gli irlandesi sono abbastanza diversi dai loro vicini, tanto che il popolo più simile sotto quest’aspetto è quello basco. Infine, l’idioma autoctono dell’isola è il gaelico irlandese, una lingua di ceppo celtico che non ha nulla a che vedere con il vicino germanico inglese, tant’è che la formulazione del periodo in gaelico viene fatta nell’ordine di verbo-complemento-soggetto, al contrario del soggetto-verbo-complemento inglese. (McCloskey, 2018)
Queste premesse hanno relegato l’Irlanda in una posizione decisamente svantaggiata rispetto al vicino più grande e più popoloso, ovvero l’Inghilterra2, che era appunto maggiormente integrata nei circuiti commerciali europei. A seguito dell’invasione normanna dell’Irlanda nel XII secolo, l’isola è pressoché sempre rimasta in mano inglese: se non nella sua interezza, almeno in parte, com’è il caso, ai giorni nostri, dell’Irlanda del Nord.
Tuttavia, la vera svolta arriverà nel XVI secolo, con la nascita dell’anglicanesimo per mano di Enrico VIII. Gli irlandesi, aggrappandosi al cattolicesimo, si opposero strenuamente alla conversione, visto che questa sarebbe consistita nel riconoscere l’autorità del sovrano inglese come legittima e di volontà divina. Nonostante le persecuzioni religiose operate sia dalla corona che da Cromwell, colui che spodestò la monarchia per impedire la presa di potere assoluto da parte della corona nel XVII secolo (diventando poi a sua volta dittatore), il cattolicesimo ha sempre mantenuto la sua importanza nella società irlandese. Tale importanza sarà decisiva, visto il futuro dell’isola: il cattolicesimo è, così, diventato una parte integrante dell’identità irlandese e un elemento fondamentale di distinzione dall’invasore. Basti pensare che gli appartenenti alla diaspora irlandese si proclamano ancora cattolici con fierezza, come l’attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden3. La religione cattolica, sebbene motivo di orgoglio, ha ancora una profonda influenza anche negativa in Irlanda: i contraccettivi sono stati legalizzati solo alla fine del Novecento e l’aborto soltanto nel 2018 (Kelly, 2020)4. Addirittura, senza il battesimo non si poteva accedere a determinate scuole, sia pubbliche che private5. Tuttavia, l’influenza della Chiesa irlandese diminuisce di anno in anno, a causa dei continui scandali che l’hanno vista protagonista e dell’allontanamento dalla religione delle nuove generazioni, sempre più multiculturali6.
Tornando al XVII secolo, viste le difficoltà nel sedare le rivolte sull’isola e nel creare una classe dirigente locale leale alla corona, l’Inghilterra decise nel 1609 di trapiantare un gruppo di nobili lealisti nell’isola, che si insediarono nell’Ulster, la regione geografica che descrive l’odierna Irlanda del Nord. La maggior parte di questi veniva dalla Scozia ed erano tutti rigorosamente anglicani. Essi contribuirono a declassare gli irlandesi a sudditi di serie B agli occhi dei sovrani, pagandone a caro prezzo le conseguenze nei secoli a venire. Le ripercussioni di questa azione politica sono visibili tutt’ora nell’Irlanda del Nord, che è in mano agli eredi di questi Homini Novi della nobiltà inglese.
È importante sottolineare che l’Irlanda venne incorporata nel Regno Unito nel 1801, con il tentativo di anglicizzare gli abitanti dell’isola. Infatti, l’uso della lingua irlandese venne vietato e chiunque non parlasse l’inglese veniva sistematicamente escluso dalla vita pubblica e dalla cittadinanza. Queste tensioni, inoltre, raggiunsero il culmine a metà dell’Ottocento, in particolare con la grande carestia del 1847, sicuramente l’evento più traumatico della storia irlandese e che contribuì maggiormente a fortificare l’identità del suo popolo. A causa di un batterio, più precisamente la Phytophthora Infestans, che attaccò le patate, all’epoca l’unico mezzo di sostentamento per l’irlandese medio, il Paese venne colpito da una terribile carestia. L’Inghilterra sarebbe potuta intervenire per cercare una soluzione alla drammatica situazione; tuttavia, in nome del libero mercato e del liberalismo, non fu inviata nessuna provvista supplementare. Vi è tutt’ora un dibattito sulla natura di questo mancato intervento, se si tratti di un’incompetenza amministrativa criminalmente negligente o di un genocidio voluto di proposito (Cleary, 2005). Nell’arco di un paio d’anni un milione di persone morì di fame e un altro milione lasciò l’Irlanda. La carestia ebbe anche conseguenze a lungo termine, impoverendo l’isola e rendendola terra di emigrazione nei secoli a venire: oggi l’Irlanda ha una popolazione inferiore a quella che aveva nell’Ottocento (l’unico caso sul continente europeo) e solo adesso sta conoscendo una crescita demografica importante7.
Con l’arrivo del Novecento e del nazionalismo, che passò dalla sua fase embrionale ad una più compiuta, gli scontri tra irlandesi e inglesi aumentarono. Come sottolinea lo storico Hobsbawm, verso metà dell’Ottocento il nazionalismo in Europa non aveva ancora assunto una dimensione di massa, nonostante avesse già i suoi teorici e venisse insegnato ad alcuni ceti sociali (Hobsbawm, 1975). Questo fenomeno, col progredire del XIX secolo, si andò ad acuire per via dei contrasti tra “grandi nazionalismi”, come l’inglese o l’austriaco, per esempio, e quelli più piccoli, ovvero con una popolazione esigua e senza una entità statale pre-esistente, come quelli irlandese e ceco. Significativa è, in questo senso, la famosa frase di Churchill, secondo il quale la «stranezza» degli irlandesi derivava proprio dalla loro «mancanza di volontà di essere inglesi»8, descrivendo così i tentativi per l’indipendenza irlandese, la quale trovava non a caso le sue radici nell’identità celtica. Ad esempio, le attività organizzate dalle associazioni (GAA, le scuole di St. Enda e St. Rita) includevano dei corsi di gaelico e la pratica degli sport tradizionali, come il hurling e il calcio gaelico, attualmente i due sport più seguiti e praticati sull’isola. Nel frattempo, in Inghilterra si discuteva della possibilità di concedere l’home rule all’Irlanda, ovvero una modalità di governo autonomo simile ai dominion coloniali. Per essere più precisi, i dominion erano delle colonie inglesi abitate principalmente da coloni, le quali nel Novecento guadagnarono una notevole autonomia. Tra queste figurano il Canada e l’Australia. Tuttavia, la decisione sull’home rule irlandese venne rimandata per via del primo conflitto mondiale.
Così iniziarono le prime rivolte vere e proprie: la prima nel 1916, poi la guerra di indipendenza del 1921-1922, entrambe violente e sanguinose, ma l’home rule venne infine ottenuto nel ‘22. Tuttavia, la questione non si sopì con gli accordi di pace, vista la divisione dell’Irlanda tra Nord e Sud, che innescò una guerra fratricida tra coloro che volevano l’indipendenza totale dell’Irlanda dal Regno Unito e coloro che volevano mantenere la pace dopo anni di guerra (1922). La conclusione di queste lotte interne è ben nota, visto che l’Irlanda del Nord rimane ancora oggi parte del Regno Unito, con, tra l’altro, una situazione securitaria molto precaria, che si infiammò negli anni ’70 per via dei violentissimi attacchi dell’IRA (Irish Republican Army) e le risposte altrettanto violente delle forze armate inglesi. Questo periodo è caratterizzato da due aspetti fondamentali: il primo riguarda le operazioni militari inglesi, che seguivano una dottrina del terrore, uccidendo e torturando spesso e volentieri persone innocenti, come nel caso delle aggressioni dei Black and Tans, un corpo d’armata speciale, durante la guerra d’indipendenza; il secondo aspetto riguarda la marginalizzazione delle comunità cattoliche nel Nord, le quali venivano spesso escluse dalla vita politica del Paese tramite il gerrymandering, ovvero la pratica di disegnare il confine delle circoscrizioni elettorali per assicurarsi la maggioranza alle elezioni.
Infine, è necessario menzionare il sostegno economico della diaspora irlandese negli Stati Uniti verso i movimenti di indipendenza, da sempre i più importanti sostenitori esterni del progetto indipendentista. Senza tale sostegno, forse l’Irlanda oggi non sarebbe indipendente.
Nel 1948 l’Irlanda raggiunse l’indipendenza totale, tramite l’uscita dal Commonwealth e la nascita della Repubblica Irlandese. Dopo anni di dominio, il Paese porta ancora alcune vestigia della dominazione britannica: la lingua inglese, il sistema di common law, le tradizioni culinarie e l’impianto urbanistico, per esempio. Ciononostante, l’identità irlandese è più forte e definita che mai, grazie a una rinascita del gaelico e alla consolidazione di alcune tradizioni distintive (gli sport, la musica, l’arte, la letteratura)9.
Con ciò si può dire che la storia coloniale dell’Irlanda sia effettivamente finita? Tutt’altro, visto che l’isola continua ad essere divisa e ci sono ancora atteggiamenti ambigui da parte del Regno Unito. Basti vedere come si sono svolti i negoziati della Brexit: il Regno Unito avrebbe voluto includere l’Irlanda all’interno della sua area doganale, escludendola quindi da quella dell’Unione Europea e minacciando la carenza di derrate alimentari se gli irlandesi non avessero acconsentito, riaprendo vecchie ferite mai veramente ricucite10. Nonostante ciò, stiamo assistendo a dei cambiamenti epocali: in primo luogo, la porzione di cattolici nordirlandesi è diventata maggioritaria nella demografia del Paese; in più, le ultime elezioni sono state vinte da Sinn Fein, il partito indipendentista11. Questi due fattori sono cruciali nel rendere la prospettiva di un’Irlanda unita sempre più concreta, come sottolineato dall’ex-taoiseach (l’equivalente del primo ministro nella Repubblica d’Irlanda) Leo Varadkar, il quale ha ammesso che l’unificazione non è un’ipotesi da escludere e che, anzi, sarebbe opportuno prepararsi a questa eventualità12.
Dunque, questa storia travagliata, ma sui generis, dell’Irlanda potrebbe raggiungere la sua conclusione in un futuro prossimo. Sarà necessario che l’Inghilterra si prenda le responsabilità delle sue azioni e che l’Irlanda del Nord venga integrata nella Repubblica. Solo allora si potrà veramente parlare di una storia post-coloniale dell’Irlanda e l’eredità imperiale sarà davvero estinta.
Note
- La Repubblica, “Brexit, gaffe di Meloni: Dublino diventa una città inglese”, 25/06/2016.
- N.B. Il termine “Inghilterra” descrive l’area geografica dell’isola, invece “Regno Unito” fu inventato a fine Ottocento per poter integrare le popolazioni celtiche. Con “Impero Britannico” si intende l’insieme costituito dall’Inghilterra e le sue colonie.
- ABC News, ”Here’s a look at Biden’s Irish roots as he visits his ancestral homeland”, 11/04/2023.
- CNN, “Five years after Ireland’s historic abortion referendum, access to care is still ‘patchy’” 23/05/2023.
- The Guardian, “No baptism, no school: Irish parents fight for equal access to education”, 21/10/2015.
- The Journal, “Census reveals 10% drop in number of Catholics in Ireland and rise in people with no religion” 26/10/2023.
- Statista, 2022.
- The Irish Times, “What did Churchill really think about Ireland”, 08/02/2012.
- The Irish Times, “Census 2022: Number of Irish speakers increases but only 10% can speak it very well“, 30/05/2023.
- The Irish Times, “Brexit: Tory MP backtracks over food scarcity in Ireland“, 8/12/2018.
- Politico, “Sinn Féin scores record win in Northern Ireland as voters rage at DUP blockade of Stormont“, 21/05/2023.
- BBC, “Leo Varadkar says Ireland ‘on path to unification”, 07/09/2023.
Bibliografia
Girvin, The origins of contemporary Ireland: new perspectives on the recent past, 2013
Cleary, Postcolonial Ireland, 2005
Kelly, The Contraceptive Pill in Ireland c.1964–79: Activism, Women and Patient–Doctor Relationships, 2020
McCloskey, The Syntax of Irish Gaelic, 2018
Hobsbawm, The Age of Capital, 1975
di Liam G. Mariotti