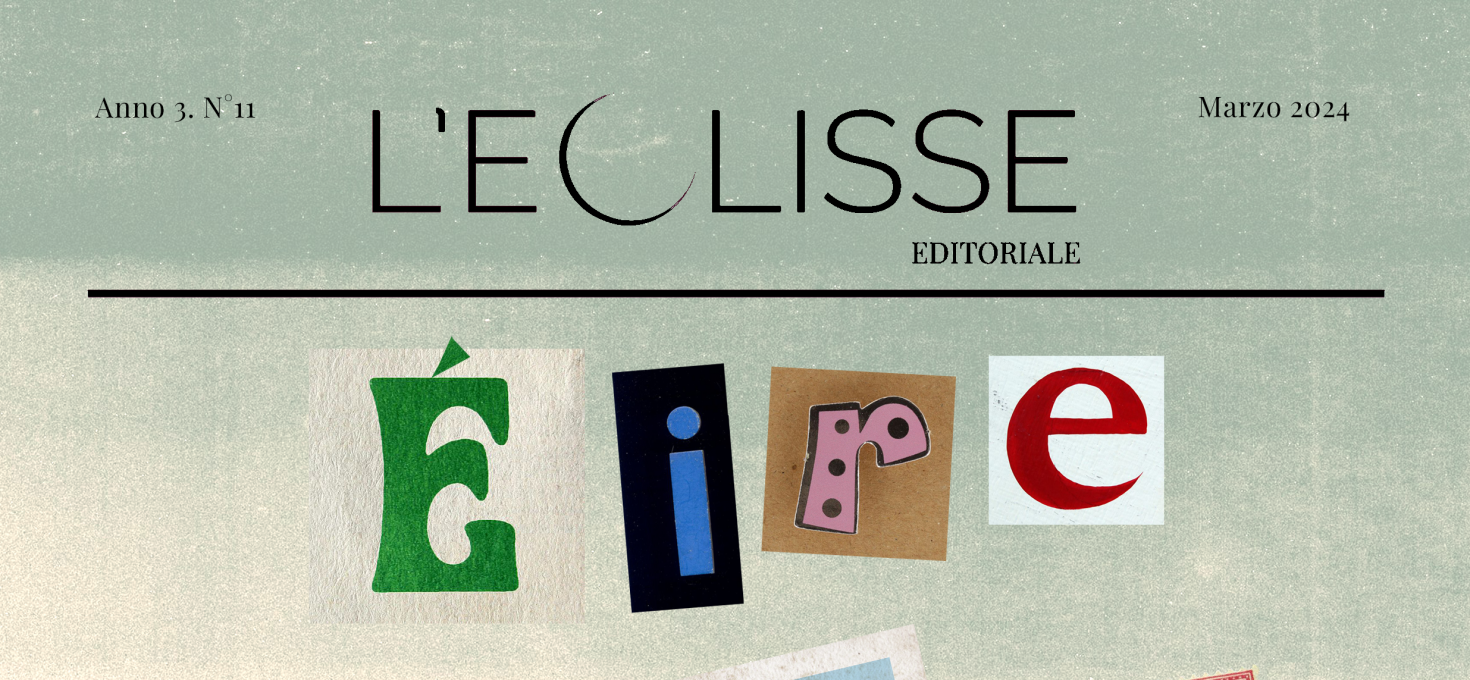Magdalene Laundries: i panni sporchi d’Irlanda

But this island’s run by sharks with children’s bones stuck in their jaws1
(I Love You, Fontaines D.C.)
Per raccontare la storia delle case Magdalene, spesso bisogna cominciare dal rinvenimento di una fossa comune a High Park, nel sobborgo dublinese di Drumcondra, dove la congregazione di Nostra Signora della Carità2 possedeva un terreno su cui sorge il St. Mary’s Refuge. A seguito di alcune pesanti perdite finanziarie, nel 1993 le suore misero in vendita il terreno per un milione e mezzo di sterline e, per correttezza, avvertirono l’acquirente della presenza di 133 salme sepolte. Gli scavi, però, portarono alla riesumazione di ben 155 corpi, a fronte di soli 75 certificati di morte forniti, una mancanza di per sé grave e penalmente perseguibile. Per insabbiare lo scandalo, le salme vennero cremate e tumulate in un’altra fossa comune nel vicino cimitero di Glasnevin; soltanto una donna venne riconosciuta e reclamata dalla famiglia. Malgrado non sia possibile risalire alle singole identità delle persone sepolte a Glasnevin, l’originario luogo di sepoltura è il primo tassello utile a spiegare una vicenda situabile fra il macabro e l’illegale. Il St. Mary’s Refuge, infatti, era una Magdalene Laundry chiusa nel 1991, poco prima della vendita del terreno.
Il sistema delle Magdalene laundries (“lavanderie”, o asylums, intesi come “rifugi”) nacque nella seconda metà del Settecento a Londra, con l’istituzione del Magdalene Hospital for the Reception of Penitent Prostitutes, e si diffuse nel Regno Unito, in Irlanda (all’epoca parte della corona britannica), nei dominion3 di Canada e Australia e nel vicino reame di Svezia. L’obiettivo era recuperare le cosiddette fallen women, eufemismo ottocentesco che etichettava come “prostitute” le donne sessualmente attive prima del matrimonio, e reinserirle nella società, insegnando loro un mestiere “adatto al genere femminile”. Tra le varie opzioni, quella della lavandaia divenne la più diffusa: era una professione prettamente femminile, non richiedeva una gran formazione e si addiceva perfettamente alla metafora battesimale, all’acquasanta che lava via il peccato originale. Inoltre, quale miglior patrona se non Maria Maddalena, la meretrice che Cristo accolse tra i propri seguaci? Poco importa se si trattava di un fraintendimento di proporzioni bibliche, dato che l’analogia tra Maria di Magdala e la prostituta citata nel Vangelo non è mai stata confermata da nessuna fonte e, anzi, sarebbe stata messa in discussione un paio di secoli più tardi. L’immagine delle case Magdalene come luoghi di redenzione dal peccato venne confezionata ad hoc ed era pronta a essere venduta all’opinione pubblica, cattolica o protestante che fosse, alle porte dell’età vittoriana e delle sue contraddizioni.

Rispetto agli altri Paesi, in Australia e Irlanda erano le congregazioni cattoliche a gestire le lavanderie. Il caso dell’Irlanda si distingue in primis a causa della fortissima influenza della Chiesa cattolica sulla società; un’influenza dalle radici millenarie, risalenti all’Alto Medioevo, che si rafforzò sotto la colonizzazione britannica nel XVII secolo e i conseguenti tentativi di conversione all’anglicanesimo. Gli irlandesi sono cattolici: questo è l’assioma della resistenza contro gli invasori protestanti. Chi altro, quindi, dovrebbe farsi carico di queste pecorelle smarrite se non coloro che già si preoccupano della salute spirituale dell’isola? Il potere detenuto da vescovi, preti e suore era tale da condizionare la politica e, capillarmente, la vita quotidiana degli irlandesi, anche dopo l’indipendenza nel 1922. Lo Stato accettò di buon grado che la Chiesa continuasse a occuparsi di chi, per un’infinita serie di motivi, non si adattava all’ideale di “brava donna irlandese”.
Per cominciare, una brava irlandese non pratica il sesso fuori dal matrimonio, figurarsi a pagamento, dato che il sesso è qualcosa di sporco, peccaminoso. Il fatto che un rapporto sessuale potesse non essere consenziente era trascurabile ai fini della redenzione, così com’era totalmente irrilevante l’identità dell’uomo, il suo stato civile e l’eventuale rapporto di amicizia o parentela. Se tutto ciò, per immane disgrazia, fosse risultato in una gravidanza, il problema non si sarebbe posto più di tanto: la gestante sarebbe stata spedita in una delle Mother and Baby Homes, case deputate all’accoglienza delle madri nubili che, successivamente, avrebbero potuto espiare la propria colpa nelle lavanderie. Orfanotrofi e famiglie affidavano poi alle laundries ragazzine che, secondo loro, avrebbero potuto mettersi nei guai, o che erano troppo povere per studiare. Il compito educativo delle case Magdalene rimase dunque immutato.
Inoltre, una brava irlandese non delinque e non devia dai binari. Era lo Stato stesso, nei fatti, a trasferire nelle case Magdalene detenute e donne affette da disturbi mentali o disabilità (gli asylums assunsero così l’accezione di “manicomi”). Ciò avveniva perché serviva manodopera a bassissimo costo, dato che le ospiti o, più correttamente, le prigioniere non percepivano alcuno stipendio. Ma per chi lavoravano le Maddalene? Che cosa lavavano oltre ai propri “peccati”? Le camicie del Taoiseach (corrispondente al nostro Presidente del Consiglio), oppure le lenzuola del Palazzo presidenziale, l’Áras an Uachtarain. Tra i clienti abituali spiccavano la Guinness (sì, quella della birra) e la Banca d’Irlanda, ma ci sono dipartimenti governativi, alberghi, golf club, carceri, scuole, ospedali, negozi, famiglie. Avrete già capito che quella delle Magdalene Laundries era una forma di schiavitù legalizzata che in Irlanda, tuttavia, degenerò al punto da diventare un servizio statale. In altre parole, lo Stato era invischiato fino al collo, così come le istituzioni religiose: il loro era un legame così stretto da rasentare la fusione.

Nessuno sapeva nulla, nessuno disse nulla per decenni, finché il vaso di Pandora non venne finalmente scoperchiato: nel 1997 venne trasmesso il documentario Sex in a Cold Climate su Channel 4 (canale della TV britannica, ndr), che include le interviste a quattro ex-Maddalene. L’onda dello scandalo iniziò a crescere sempre di più e divenne ormai impossibile contenerla, anche per la Chiesa. Negli anni a venire, ulteriori articoli e documentari (ne esiste solo uno di produzione irlandese: The Forgotten Maggies (2009), diretto da Steven O’Riordan) portarono alla luce i segreti delle case Magdalene, l’acqua sporca che avrebbe dovuto scivolare nello scarico e sparire nelle fogne. Dai racconti delle sopravvissute emerge infatti un mondo parallelo in cui l’identità personale non era ammessa e, per questo, i vestiti all’arrivo venivano sostituiti da divise ruvide e scomode, il proprio nome veniva rimpiazzato da uno nuovo, ritenuto più adatto. Le testimonianze presenti nei documentari sopracitati riportano persino di capelli tagliati per curare, o anche solo prevenire, qualsiasi moto di vanità o ribellione contro le suore, le quali imponevano il silenzio per evitare fraternizzazioni e rivolte. C’era molto altro per cui ribellarsi, in effetti, se a tutto questo si aggiungono sia i ricordi delle penitenti molestate, se non stuprate, negli uffici e nei confessionali da sacerdoti venuti a dire messa, che il turpe giro di affari delle Mother and Baby Homes. I figli delle donne ospitate nelle strutture non venivano dati, bensì venduti in adozione, anche all’estero, obbligando le madri a firmare il consenso.
L’evasione costituiva il modo più pericoloso per uscire da una Magdalene laundry: il rischio era quello di essere riacciuffate dagli uomini della Garda Síochána, la polizia irlandese, o di smarrirsi in strade sconosciute, senza una vera istruzione di base, oltre ai lavori manuali, che consentisse loro una vita dignitosa nella società civile. Tuttavia, scappare non era l’unica via: nel migliore dei casi, dopo alcuni mesi o addirittura anni, un parente, rigorosamente uomo, decideva che la punizione per aver trasgredito alle regole era durata abbastanza; perciò, si presentava dalle suore per riportare a casa l’ex-peccatrice. Altre volte, erano le stesse religiose a piantare in asso le Maddalene a una fermata dell’autobus, perché non servivano più o avevano finito di scontare la pena carceraria. C’è poi chi sarebbe uscita da lì dentro una bara, nella speranza che la sua morte venisse effettivamente dichiarata all’anagrafe. Abbiamo visto che non è poi così scontato, come non lo è tornare a vivere nel mondo esterno, una volta smessi i panni del peccato: le testimonianze delle sopravvissute alternano infatti sentimenti di vergogna, inadeguatezza e paura. C’è chi non si è mai sposata per non diventare proprietà di qualcun altro, chi ha vissuto con difficoltà o rifiuto la sessualità all’interno della vita matrimoniale, e chi ha continuato a cercare un figlio perduto – o una madre perduta.
Nei primi anni Duemila, lo Stato si dimostrò sordo alle proteste, riversando ogni responsabilità sulle congregazioni religiose direttamente coinvolte. La situazione ha iniziato a cambiare nel 2011, quando l’organizzazione Justice for Magdalenes Research (JFMR) ha presentato un’istanza all’ONU, che esortava il governo irlandese a fare chiarezza sul fenomeno. È stata così creata l’Inter-Departmental Committee4, una commissione d’inchiesta in seno a sei ministeri che nel 2013 ha pubblicato il McAleese report (dal senatore Martin McAleese, membro indipendente della Commissione). I risultati delle indagini hanno evidenziato che solo dal 1922 sono state più di 11.000 le recluse nelle case Magdalene, ma non è stata riconosciuta la sistematicità degli abusi fisici e sessuali da parte delle suore, né la convenienza economica delle lavanderie; inoltre, le morti accertate dal rapporto sono solamente 879 (sebbene il JFMR, per contro, ne stimi almeno il doppio)5. Ciononostante, in seguito alla pubblicazione del report l’allora Taoiseach Enda Kenny ha pubblicamente chiesto scusa e confermato i risarcimenti alle vittime ancora in vita, per un ammontare che varia tra i 34,5 e i 58 milioni di euro, in base alla durata della detenzione. La Chiesa, dal canto suo, non ha versato un centesimo, minimizzando o addirittura negando le violenze. Perciò, il rapporto con la popolazione si è definitivamente incrinato, in concomitanza con la Quiet Revolution, il processo di secolarizzazione del Paese: la percentuale di irlandesi che va a messa6 è scesa a un numero cinquant’anni fa impensabile.

La prima Magdalene laundry in Irlanda venne aperta nel 1767, mentre l’ultima chiuse i battenti nel 1996, dopo essere diventata una casa di riposo per le poche Maddalene rimaste, ormai anziane. Nel corso di 229 anni, circa 30.000 tra donne, ragazze e bambine hanno lavato, cucito e rammendato i panni dello Stato e della Chiesa e di chiunque non fosse così povero da trovarsi costretto a provvedere al proprio bucato – almeno fino all’avvento delle lavatrici. La tragedia delle Magdalene Laundries è uno dei tanti, troppi esempi di controllo sulle donne da parte di un’istituzione, sia essa religiosa o statale; un fenomeno che oggi l’opinione pubblica tende ad associare superficialmente a Paesi come l’Afghanistan e l’Iran, come se fosse un tipo di oppressione estranea alla storia occidentale. Eppure, non è così.
“La strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni” diceva qualcuno, ma in questo caso non si salvano neppure le intenzioni.
Oltre alle fonti che trovate nei collegamenti ipertestuali presenti nell’articolo, si citano la puntata numero 99 del podcast Who Did What Now della divulgatrice irlandese Katie Charlwood, il documentario Sex in a Cold Climate e il sito del JFMR per tutte le informazioni riguardanti i motivi d’ingresso delle prigioniere nelle case Magdalene e il lavoro svolto per lo Stato irlandese.
Note
- “Ma quest’isola è governata da squali che hanno ossa di bambini incastrate nelle fauci”
- “Sisters of Our Lady of Charity of the Good Shepherd”, spesso abbreviato in “Sisters of Our Lady of Charity”. Il nome per esteso in italiano è “Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore”, ma per motivi stilistici si è scelto di usare l’abbreviazione.
- Status dei territori appartenenti all’Impero britannico, dotati però di forme di autogoverno, antecedente alla costituzione del moderno Commonwealth.
- “Commissione Interdipartimentale”.
- Un articolo dell’Irish Examiner riassume le criticità del McAleese report.
- Secondo il censimento del 2022, il 69% degli irlandesi si dichiara cattolico, la percentuale più bassa di sempre, anche se questo non implica l’essere praticante. Il tasso di partecipazione settimanale alle funzioni religiose attualmente si attesta al 14% (dieci punti in meno rispetto al periodo pre-pandemico).
di Joanna Dema