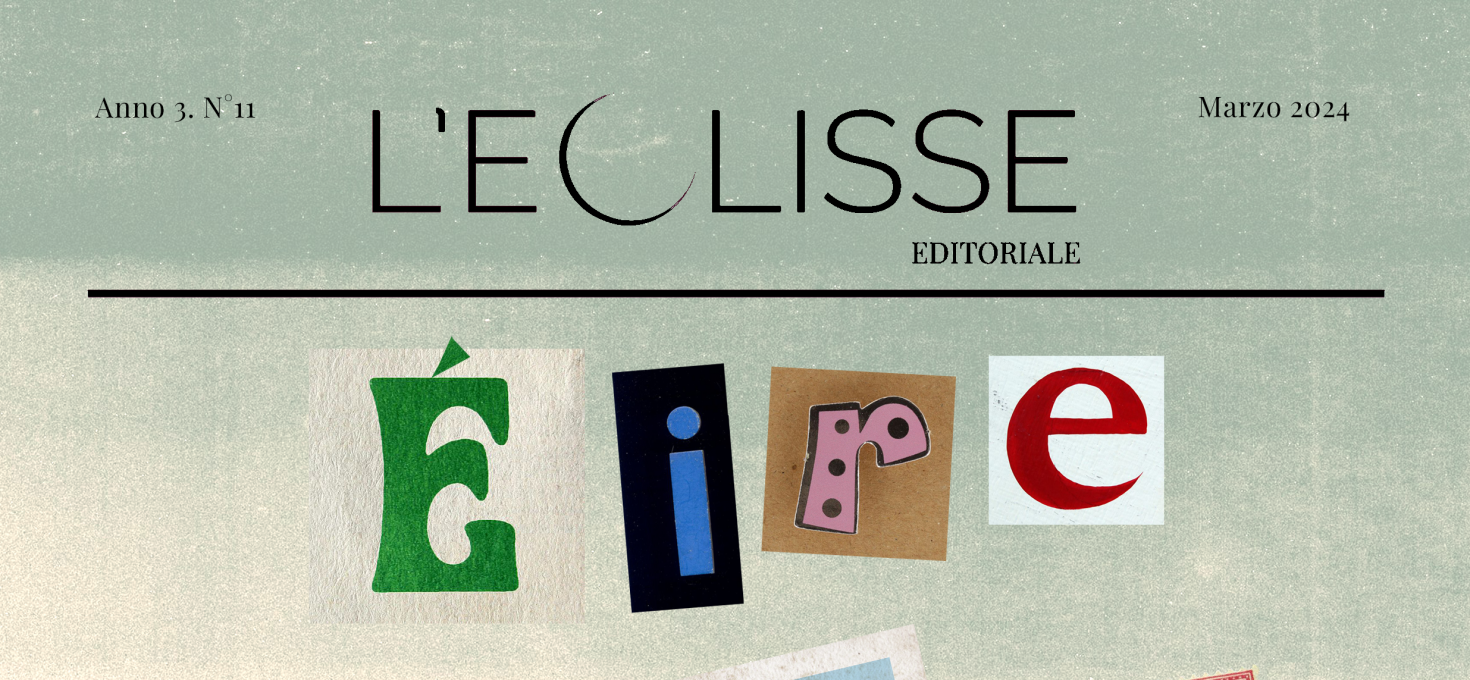Gente di Dublino (e dintorni)

Lə appassionatə della lettura, sicuramente, conosceranno già il nome di Sally Rooney, l’autrice irlandese che da qualche anno spopola sui social media, ma divide il pubblico e la critica. I romanzi di Rooney, ad oggi tre – Parlarne tra amici, Persone normali e Dove sei, mondo bello?, tutti editi in Italia da Einaudi – mettono al centro millennials persə nelle loro insicurezze e affettə da incomunicabilità patologica, senza mancare di includere discussioni su temi come ambientalismo e lotta di classe. Il suo successo è materiale inesauribile per i dibattiti letterari, e sul web si possono trovare innumerevoli articoli che la elogiano o la considerano sopravvalutata, soprattutto per la sua abitudine di non includere le virgolette nei dialoghi e per il suo stile scarno, diretto, senza fronzoli, messo al servizio di storie tutto sommato poco interessanti, animate però da un’introspezione psicologica nei personaggi che riesce a creare una forte empatia coə lettorə, specialmente coetaneə dell’autrice. Scrive Shehrin Hossain per The Daily Star: «Questa è la specialità di Rooney: la sua attitudine per il realismo psicologico molto specificatamente millennial che l’ha resa famosa. È in grado di esaminare con mano esperta la disillusione che tuttə sembriamo provare, senza però alienare mai i suoi personaggi. […] È interessata all’asimmetria che esiste nelle relazioni umane, nelle emozioni come una forza esterna – cose con cui la maggior parte di noi si deve confrontare»1.
Lo stile di Rooney è ormai diventato quasi un marchio di fabbrica e il suo nome viene usato come strumento di marketing per indicare romanzi con precise caratteristiche: sono ambientati in una capitale (Dublino, Londra, New York) e seguono protagoniste tra i venti e i trent’anni, spesso studentesse universitarie o donne nei primi anni delle proprie carriere (quasi sempre in ambito artistico o letterario), alle prese con l’amore, l’amicizia, il sesso e la propria salute mentale. Quasi sempre, dalla descrizione di una quotidianità inquieta sgorgano riflessioni sui grandi problemi del mondo moderno, ai quali, in genere, non vengono proposte soluzioni. I libri di Rooney hanno contribuito a creare una nuova classificazione di questo genere di romanzi, particolarmente in voga su TikTok: i sad hot girl books, ovvero libri per ragazze belle e tristi.
Tuttavia, il successo di Sally Rooney ha permesso la diffusione anche di un’altra (vaga) categoria di romanzi: quelli irlandesi. Non a caso, anche all’interno della categoria dei sad hot girl books viene riconosciuto un singolare primato agli autori e soprattutto alle autrici irlandesi, come Megan Nolan (i cui libri sono editi in Italia da NN Editore), Claire Keegan (Einaudi) e Naoise Dolan (Blu Atlantide). La melancolia e il senso di solitudine, tanto amato dalle lettrici di sad hot girl books, sembra essere una prerogativa irlandese. Un po’ come, negli anni Duemila, lə giovani lettorə trovarono conforto nella letteratura giapponese, specialmente quella di Murakami Haruki, il cui lavoro più famoso, Norwegian Wood, tra l’altro, metteva anch’esso in scena un protagonista giovanissimo e disilluso verso la politica e l’amore, nel bel mezzo dei moti sessantottini a Tokyo.
Anche chiudendo TikTok, è innegabile che, negli ultimi anni, la letteratura irlandese contemporanea stia conquistando gran parte del mondo dell’editoria britannica – e di conseguenza, con un po’ di ritardo, ma comunque con forza, sta raggiungendo anche tutte le altre, compresa quella italiana. Basta guardare ai candidati per il Booker Prize, il premio letterario più importante del mondo anglofono, che da qualche anno vedono una predominanza di cognomi che iniziano per O’ e Mc. In un articolo del 2019, Alex Clark del The Guardian attribuiva questo boom della narrativa irlandese a un coraggio degli editori: «La scrittura irlandese non si è mai rifiutata alla sperimentazione e lə lettorə non hanno mai temuto questa tendenza. In generale, c’è un approccio molto più rilassato al genere, una distinzione molto meno marcata tra autorə “d’élite” e commerciali e meno rigore sui confini tra narrativa, saggistica e altre forme artistiche»2.
Effettivamente, l’Irlanda ha dato i natali ad alcuni dei più grandi innovatori della forma letteraria, da James Joyce a Samuel Beckett, passando da Oscar Wilde e C.S. Lewis, l’autore delle Cronache di Narnia. Dall’Irlanda sono arrivate la storia di vampiri più famosa di tutti i tempi (no, non Twilight, ma il capolavoro di Bram Stoker, Dracula) e la novella che l’ha ispirata, Carmilla, di J. Sheridan Le Fanu. Quest’esuberanza letteraria ha regalato alla – demograficamente – piccola isola quattro premi Nobel: George Bernard Shaw, William Butler Yeats, Beckett e Seamus Heaney. Però, se una certa temerarietà editoriale sicuramente offre una risposta al perché il mercato e i premi più prestigiosi sembrino essere stati improvvisamente invasi da scrittorə irlandesi, essa non è sufficiente per comprendere l’amore che un pubblico estremamente eterogeneo e globale sta sviluppando per questo tipo di letteratura.
Sono numerose le testate che negli ultimi anni si sono poste questa domanda. Le risposte evidenziano sia motivazioni pratiche (per esempio le condizioni di Welfare estremamente favorevoli aglə artistə, o ancora la nascita di riviste letterarie di altissimo livello, una fra tutte The Stinging Fly), sia la presenza di un motivo più profondo e impalpabile, che potremmo riassumere nel concetto di relatability.
La relatability è quella capacità dell’arte di essere compresa a livello profondo dallə suə interlocutorə, fungendo da specchio e, a volte, anche da analisi di una particolare demografica. Per i romanzi irlandesi, questa demografica è costituita principalmente da giovani adultə, alla presa con le conseguenze del capitalismo post-crisi del 2008 e con la condanna di essere sempre connessə in un mondo che va a fuoco, metaforicamente e letteralmente. La letteratura irlandese contemporanea, erede di una tradizione narrativa antichissima che si intreccia a un contesto sempre più multiculturale, nata dalle ceneri di una storia fratricida e sanguinosa, rinata in una società progressivamente meno legata alla Chiesa cattolica, punto di riferimento morale e comportamentale per secoli, riesce a captare una generale sensazione di solitudine e confusione che ben si accorda alle sensibilità di millennials e gen z. A questo proposito, il professor Liam Harte, docente di letteratura irlandese all’Università di Manchester, ha dichiarato alla BBC che «[glə scrittorə irlandesi] si confrontano con una specie di bussola morale che lə lettorə cercano, per avere una guida attraverso il caos, e la Storia irlandese altro non è se non in uno stato di flusso perpetuo»3, aggiungendo che, sebbene i romanzi provenienti dall’Éire tendano ad essere ben ancorati all’isola e alle sue problematiche specifiche, hanno sempre una «risonanza globale che parla ad altre culture in cui il passato è ancora una presenza soffocante… parlano di traumi, tirano in causa ansie universali»4.
Ovviamente la relatability è altamente soggettiva e libri come Persone normali di Sally Rooney o Atti di sottomissione di Megan Nolan non incontrano i gusti di tuttə lə lettorə. Tuttavia, sembra che la maggior parte del pubblico, soprattutto femminile, riesca a empatizzare con le narrazioni delle giovani voci irlandesi, che nel frattempo non sembrano intenzionate a fermare la loro inesorabile conquista degli scaffali delle nostre librerie.
Note
- «This is Rooney’s specialty: the flair for the very specifically millennial psychological realism that has made her famous. She is able to examine with a practiced hand the disillusion that we all seem to feel, without ever alienating her characters. […] She’s interested in the asymmetry existing in human connections, in emotions as an external force» (traduzione mia)
- «Irish writing has never shied away from experimentalism, and nor have readers been frightened off by it. There is, in general, a far more relaxed approach to genre, a less divisive bracketing of “posh” and commercial writers, and less policing of the boundaries between fiction, nonfiction and other art forms» (traduzione mia)
- «[Irish writers] deal with a kind of moral compass that readers look to for guidance through the chaos, and Irish history is nothing if not in a state of constant flux» (traduzione mia)
- «global resonance that speaks to other cultures where the past is still a suffocating presence… [they’re] also about trauma, [they speak] to universal concerns» (traduzione mia)
Éire
Editoriale · L’Eclisse
Anno 3 · N° 11 · Marzo 2024
Copertina di Maria Traversa.
Si ringrazia Liam G. Mariotti.
Hanno partecipato alla realizzazione di questo editoriale: Greta Beluffi, Bianca Beretta, Alice Borghi, Matteo Capra, Michele Carenini, Ginevra Cesati, Anna Cosentini, Joanna Dema, Clara Femia, Mariairene Fornari, Eugenia Gandini, Chiara Gianfreda, Nikolin Lasku, Rosamaria Losito, Matteo Mallia, Laura Maroccia, Alessandro Mazza, Marcello Monti, Edoardo Naggi, Valentina Oger, Alessandro Orlandi, Erika Pagliarini, Matteo Paguri, Virginia Piazzese, Lorenzo Ramella, Luca Ruffini, Gioele Sotgiu, Tommaso Strada, Vittoria Tosatto, Marta Tucci, Marta Urriani.