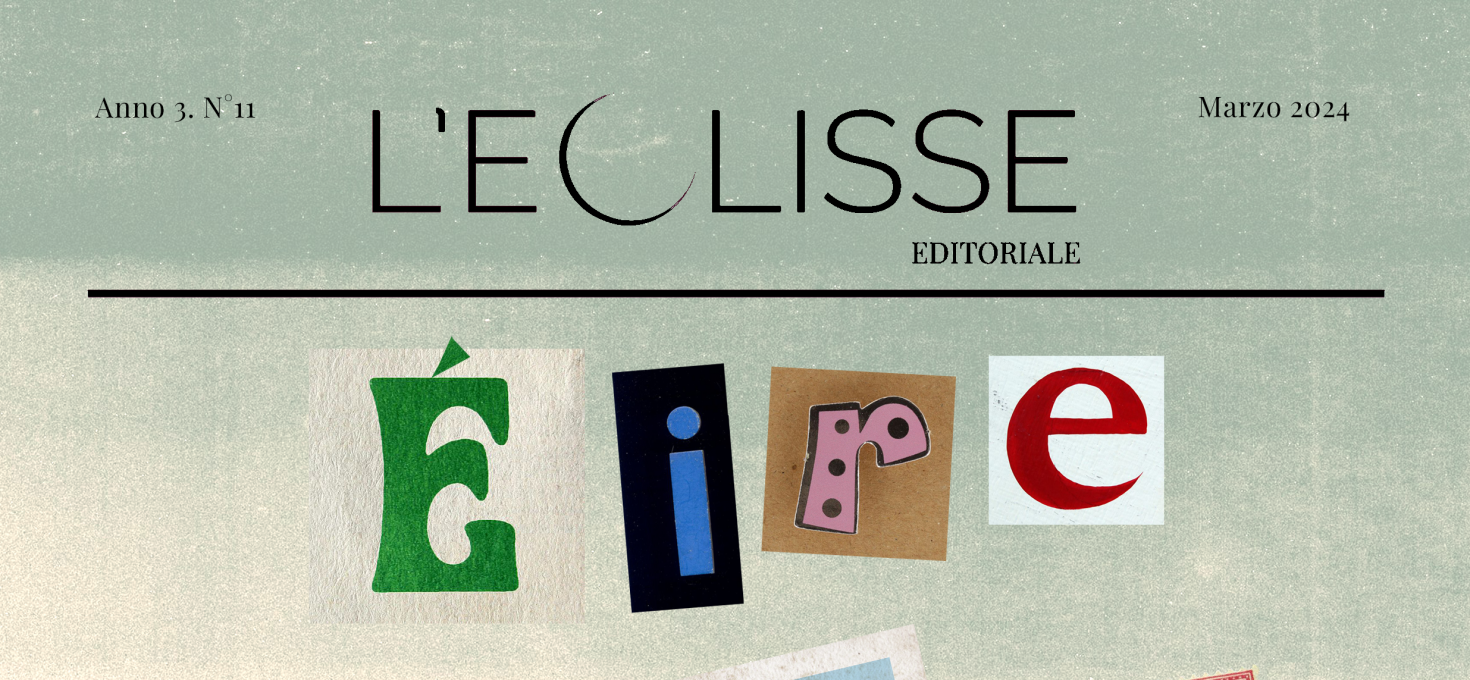I Troubles non sono mai finiti
Tra gli anni Settanta e Novanta del secolo scorso, si è verificato uno dei più grandi e duraturi conflitti settari della storia contemporanea europea. I Troubles, che spesso vengono raccontati come un “semplice” conflitto tra cattolici e protestanti, in realtà sono stati un avvenimento ben più complesso, che riflettono secoli di dominio coloniale inglese sull’isola irlandese. Questo conflitto, formalmente terminato nel 1998, ha ancora diversi risvolti politici e sociali all’interno dell’Irlanda del Nord.
I Troubles hanno visto contrapposti i protestanti dell’Ulster e la comunità cattolica: i primi erano unionisti e lealisti (quindi a favore di rimanere nel Regno Unito), mentre i secondi avevano idee repubblicane e nazionaliste, aspirando a un ricongiungimento con la Repubblica d’Irlanda. Il conflitto non nasce puramente come un conflitto religioso, ma ha cause soprattutto politiche e sociali. Storicamente, la minoranza cattolica aveva subito discriminazioni da parte della maggioranza protestante sin dagli anni ‘20, quando la Repubblica d’Irlanda riuscì a rendersi indipendente dalla Gran Bretagna. Nella regione dell’Ulster, i protestanti, discendenti dei coloni inglesi delle plantations1 del XVII secolo, non si erano mai effettivamente assimilati con la popolazione (autoctona) a maggioranza cattolica. Già nel 1922, circa due terzi della popolazione della regione – circa 1 milione di persone – erano protestanti, mentre il restante terzo – circa 500.000 persone – si identificava come cattolico.
Dal punto di vista politico, l’Ulster Unionist Party (UUP) era riuscito dal 1922 a controllare il governo nordirlandese grazie alla pratica di gerrymandering2. I cattolici lamentarono per decenni la discriminazione perpetrata dai protestanti in diversi ambiti della vita pubblica: nell’allocazione di case popolari, negli investimenti a favore dei quartieri cattolici o protestanti, nell’assegnazione dei posti di lavoro nella pubblica amministrazione e soprattutto nelle continue vessazioni e persecuzioni da parte della polizia. La discriminazione non era quindi basata principalmente su divergenze teologiche, ma aveva fondamenta culturali3 ed identitarie. Il governo unionista decise di non inserire la storia e la lingua irlandesi nei curricula scolastici, fu proibita l’esposizione del tricolore repubblicano e per quasi vent’anni, ossia dal 1956 al 1974, lo Sinn Féin (il partito repubblicano irlandese) fu messo al bando. La vita culturale e politica per i cattolici divenne quindi insostenibile.
In tale contesto, la Northern Ireland Civil Rights Association (NICRA) nacque nel 1968, come tanti altri movimenti di attivismo politico. Il 5 maggio, la NICRA organizzò una manifestazione a Derry (ufficialmente Londonderry) contro le pratiche di gerrymandering e la continua discriminazione dei cattolici. La marcia assunse una dimensione violenta quando la NICRA, avvisata che gli unionisti avrebbero organizzato una contromanifestazione, decise di non cancellare il proprio corteo. La protesta presto si trasformò in un tumulto violento: la Royal Ulster Constabulary (RUC), la polizia nordirlandese, utilizzò manganelli e cannoni d’acqua contro i manifestanti cattolici. Questo scontro seminò il germe primordiale di un ampio conflitto che durò circa vent’anni. Un anno dopo, nell’agosto del 1969, ebbe luogo la famosa Battle of Bogside: questa volta furono i lealisti a organizzare una manifestazione a Derry, nel quartiere a maggioranza cattolica di Bogside. Ancora una volta, la RUC intervenne a favore dei lealisti. Gli abitanti di Bogside iniziarono dunque a barricarsi all’interno del quartiere e reagirono alla polizia lanciando pietre e bombe Molotov. La RUC reagì di conseguenza con gas lacrimogeno: la situazione era decisamente degenerata. Dopo la Battle, il quartiere di Bogside fu rinominato dagli abitanti “Free Derry” e rimase inaccessibile alla polizia fino a ottobre dello stesso anno.
In questi anni di tumulti e disordini fu attiva la IRA, ovvero la Irish Republican Army, il corpo paramilitare a sostegno dei nazionalisti e con l’obiettivo di riunificare politicamente l’isola. Dopo gli anni Sessanta, l’IRA abbandonò ufficialmente la lotta armata; quindi, fu fondata la Provisional Irish Republican Army (Provisional IRA), supportata dall’IRA. Gli unionisti crearono a loro volta diverse forze paramilitari, tra cui la Ulster Defence Association (UDA) e la Ulster Volunteer Force (UVF).
Negli anni Settanta, i maggiori scontri tra le due fazioni si concentrarono nelle aree di Belfast e Derry, nonostante l’introduzione di politiche sociali e volte alla maggior inclusione ed equità dei due gruppi. Le forze militari britanniche, inviate per ristabilire l’ordine, iniziarono a dividere i quartieri e le città con filo spinato per contenere gli scontri: presto, però, questi muri invisibili iniziarono a trasformarsi in muri veri, fatti di pietre e acciaio, denominati “peace walls”. Ovviamente, questo tipo di politica non fece altro che ghettizzare ulteriormente i due gruppi e accrescere le divergenze. Non a caso, l’evento più conosciuto dei Troubles è il Bloody Sunday (gennaio 1972): durante una manifestazione per i diritti civili organizzata dai cattolici a Londonderry, l’esercito britannico sparò sulla folla. La diretta conseguenza fu il riarmo della popolazione cattolica e l’aumento di affiliazione alla Provisional IRA. Il 1972 fu l’anno più sanguinoso per l’Irlanda del Nord: 480 persone persero la vita4.
Sempre durante gli anni Settanta, il conflitto si trasformò da guerra civile tradizionale – con anche il coinvolgimento delle truppe britanniche – a un conflitto caratterizzato principalmente da azioni segrete su scala minore. Ebbe così inizio il periodo del terrorismo, durante il quale gli unionisti facevano scoppiare bombe in Irlanda, mentre i nazionalisti in Inghilterra. Il conflitto iniziò a intravedere una possibile soluzione nel 1985 con l’Anglo-Irish Agreement: in sostanza, le parti contraenti concordarono che il futuro dell’Irlanda del Nord dovesse dipendere dal consenso dei suoi cittadini. Inoltre, fu stabilito che il potere politico dovesse tornare nelle mani del governo nordirlandese in modo condiviso tra unionisti e nazionalisti: infatti, il Regno Unito aveva sospeso le attività del governo di Belfast a seguito degli scontri e aveva assunto il potere ad interim. L’accordo saltò a causa del rifiuto dei lealisti. Perciò, gli scontri continuarono.
A seguito di altri accordi, come la Downing Street Declaration (1993) e vari cessate-il-fuoco, l’accordo finale fu raggiunto il 10 aprile 1998 con il Good Friday Agreement. Con tale accordo fu stabilita la creazione dell’Assemblea dell’Irlanda del Nord, basata sulla condivisione dei poteri, e un accordo transfrontaliero tra Repubblica d’Irlanda e Irlanda del Nord. Grazie a questo accordo, il Regno Unito riconobbe all’Irlanda del Nord un proprio organo legislativo e uno esecutivo. Inoltre, nel maggio dello stesso anno, fu tenuto un referendum congiunto – sia in Irlanda che in Irlanda del Nord – per l’approvazione del Good Friday Agreement. Il referendum fu approvato dal 94% della popolazione irlandese e dal 71% dalla popolazione nordirlandese. Tuttavia, i Troubles terminarono ufficialmente solamente l’anno seguente, nel 1999, quando la Repubblica d’Irlanda eliminò dalla propria Costituzione tutti i riferimenti alla rivendicazione territoriale dell’Ulster e l’IRA terminò ufficialmente le sue attività terroristiche e paramilitari.
Il conflitto trentennale causò circa quattromila morti e 47.000 feriti, la maggior parte giovani. Sebbene i Troubles siano ufficialmente terminati nel secolo scorso, il conflitto settario tra nazionalisti cattolici e lealisti protestanti si protrae ancora ai giorni nostri, anche se in forme minori. Nelle aree più rurali e povere del Paese, i gruppi paramilitari continuano ad esercitare il proprio potere e influenza. Colm Walsh, sociologo della Queen’s University di Belfast, sostiene che i gruppi paramilitari protestanti si sono trasformati in “qualcosa di molto più simile alla criminalità organizzata e persino ai gruppi mafiosi”5. I gruppi paramilitari, infatti, operano nelle aree più povere della società, dove le disuguaglianze sociali che lo Stato non riesce a colmare sono ben visibili. Proprio come per i gruppi mafiosi, spesso le persone si rivolgono a tali gruppi per risolvere problemi di natura sociale o per farsi giustizia da soli.
A livello politico-istituzionale, le conseguenze dei Troubles sono ancora tangibili. Nella pratica, il sistema politico stabilito a seguito del conflitto, prevede che i due partiti principali – il Democratic Unionist Party (DUP) e lo Sinn Féin – debbano collaborare per formare un governo di coalizione: in questo modo, si evita che uno dei due gruppi possa prendere il sopravvento e creare una situazione simile a quella precedente ai Troubles. Il problema però è che se uno dei due partiti si rifiuta di collaborare, quindi di accettare la carica di capo del governo o vice, il governo nordirlandese passa nella mani del Regno Unito, che assume il controllo politico pro tempore, fino al raggiungimento di un nuovo accordo politico. A seguito delle elezioni del 2022, si è verificata proprio questa situazione: lo Sinn Féin aveva vinto con il 29%, mentre il DUP era arrivato secondo con il 21% dei voti ma gli unionisti si erano sempre rifiutati di formare un governo di coalizione. Le cause dell’opposizione erano essenzialmente le seguenti: il DUP si rifiutava di accettare il patto della Brexit del Regno Unito con l’UE riguardante l’Irlanda del Nord, e, soprattutto, sarebbe stato per la prima volta nella storia nordirlandese l’alleato di minoranza.
Il 3 febbraio 2024, tuttavia, il DUP ha accettato il governo di coalizione guidato dallo Sinn Féin a patto che il primo ministro britannico Rishi Sunak stanzi tre miliardi di sterline a favore della provincia britannica al fine di contrastare la grave crisi economica. Il nuovo governo è quindi guidato da due donne: la prima ministra Michelle O’Neill (Sinn Féin) e la vice prima ministra Emma Little-Pengelly (DUP). Dal punto di vista pratico, questo ribaltamento politico non porterà ad alcun cambiamento nel breve termine; dal punto di vista simbolico, invece, è una grandissima vittoria per i nazionalisti cattolici dell’Irlanda del Nord e della Repubblica d’Irlanda.
Il futuro dell’Irlanda del Nord non sembra poter cambiare nel futuro prossimo, ma, a seguito della Brexit e del predominio dello Sinn Féin, le rivendicazioni politiche sono tornate al centro del dibattito politico in modo ancora più preponderante. Inoltre, è tremendamente difficile immaginare la completa fine del conflitto nel Paese, dato il suo radicamento delle ideologie politiche stesse e i continui, mai veramente terminati, scontri.
Note
- Le plantations furono il frutto della colonizzazione principalmente inglese (e in parte scozzese) dell’Irlanda a seguito della confisca delle terre agricole da parte della Corona.
- La pratica del gerrymandering consiste nel ridisegnare i confini dei collegi elettorali in modo da favorire un candidato (solitamente tipico dei sistemi elettorali maggioritari).
- Per “culturali” si intende l’uso di simboli, rituali, lingua e sistema di convenzioni (vedi anche Émile Durkheim)
- https://www.britannica.com/event/The-Troubles-Northern-Ireland-history