Tenera è la carne
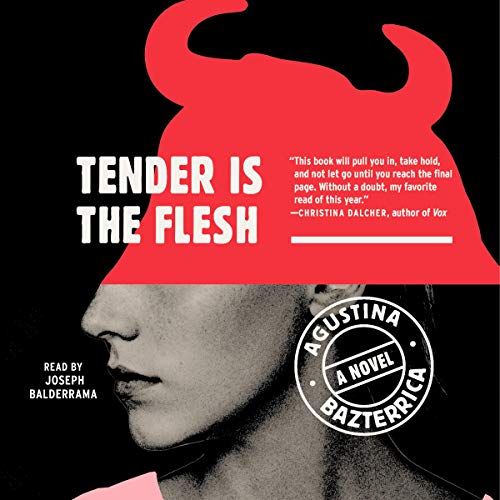
Molti di noi alla parola “cannibale” rabbrividiscono; è un pensiero che incute una paura quasi primitiva, la paura di non sopravvivere. Ma è possibile che esistano dei cannibali tra di noi, nell’ombra, che hanno ceduto alla tentazione (o alla curiosità) di assaggiare carne umana? L’idea sembra fuori dal mondo. Eppure, di recente Hollywood è stata sconvolta da una controversia riguardante la sospetta antropofagia di nientemeno che Armie Hammer. L’attore di Chiamami col tuo nome ha infatti ricevuto diverse accuse da sue ex partner, le quali nel 2021 hanno diffuso online delle conversazioni private in cui lui esprime le proprie fantasie sessuali di cannibalizzarle. In particolare, si legge chiaramente che Hammer voglia tagliarne un alluce “per conservarlo in tasca”, berne il sangue, addirittura chiedendo a una delle sue partner di poter staccarle una costola per mangiarsela. Ovviamente l’attore ha reagito con violenza smentendo tutto, eppure in seguito a queste vicende (per la cronaca, finora ancora irrisolte) si è aperta una questione: che sia una fantasia sessuale o un metodo (per usare un eufemismo) “alternativo” di alimentazione, può esistere un cannibalismo etico? Se ci fosse un consenso reciproco, sarebbe ancora moralmente riprovevole? L’autrice argentina Agustina Bazterrica si interroga sulla natura nascosta dell’istinto cannibale, in Tenera è la carne.

Tenera è la carne (titolo originale Cadáver exquisito) è un romanzo distopico che affronta il tema delle condizioni dell’allevamento di bestiame attraverso la metafora del cannibalismo. Nel mondo alternativo che viene descritto (forse non così lontano dal nostro), tutti gli animali hanno contratto un virus mortale per l’uomo, e ciò ha portato allo sterminio di ogni forma di vita non umana. I giornali parlano di cospirazioni, mentre i medici spiegano che le uniche alternative in questa situazione disperata sono diventare vegani oppure mangiarsi a vicenda. Ben presto, il governo spinge per quest’ultima soluzione e rende il cannibalismo istituzionalizzato, industrializzato e normalizzato. Incredibilmente, anche i cittadini si abituano a questa scelta e, in maniera non dissimile dal Newspeak orwelliano, si instaura un nuovo linguaggio per questo nuovo consumo. Lo nota anche Marcos, il protagonista, un macellaio che ha dovuto adattare la sua professione per sbarcare il lunario. Adesso lui lavora con “carne speciale”, ottenuta da “teste”, ovvero esseri umani allevati specificamente per il consumo. Bazterrica ci porta a fare il tour dell’impianto di lavorazione della carne nel quale Marcos accoglie clienti dalle richieste più disparate e sconvolgenti (ad esempio, si aprono battute di caccia esclusivamente per “teste” incinte, cosicché i cacciatori possano cibarsi dei loro feti una volta uccisa la preda). Ben presto però Marcos riceve una femmina FGP, First Generation Pure, una testa nata in cattività e allevata con iniezioni che favoriscono una crescita accelerata. Non sapendo cosa farsene, e ancora traumatizzato dalla recente morte del suo unico figlio, cerca di tenerla nascosta nel granaio di casa sua, ossessionato dal pensiero di doversene prendere cura. Ma ben presto le cose prenderanno una piega inaspettata, portando Marcos a mettere in discussione tutto quello che gli è stato insegnato dall’arrivo del virus.
L’approccio di Bazterrica a una storia così cupa e raccapricciante si può definire solo come asettico, desensibilizzante, tanto che dopo l’ennesima descrizione di come viene trattata una “testa” in cattività, smettiamo anche di trasalire, di avere una reazione emotiva. È questo forse l’elemento più terrificante, perché è esattamente ciò che succede nel mondo di Marcos anni dopo l’introduzione del cannibalismo. Grazie al cambiamento che la lingua subisce, nutrirsi di esseri umani allevati in centri appositi diventa routine, un’azione talmente normalizzata che le persone iniziano a diffidare di chi ancora si rifiuta di mangiare “carne”. L’horror un po’ splatter di Tender is the flesh viene smorzato da una nota di black humour portata dalla sorella di Marcos, terrorizzata dagli animali (esce sempre con un ombrello poiché crede che così nessun uccello possa attaccarla). Si attenua così il crescendo di tensione, che trova il suo culmine nel finale del libro.
In antropologia, si parla di cannibalismo come atto rituale all’interno di culture primitive. Il termine deriva dalla parola “canniba”, con cui gli amerindi delle Piccole Antille si riferivano a alcune popolazioni dedite all’antropofagia. L’atto del cannibalismo rimane uno dei più grandi tabù del pensiero umano occidentale. Per questo motivo, è stato usato come mezzo di propaganda per screditare nemici e avversari. L’antropologo William Arens ricorda che spesso popoli che si consideravano “civili accusavano altre popolazioni, considerate “incivili”, di questo atto inumano1 (si pensi all’archetipo antisemita secondo cui gli ebrei berrebbero sangue umano durante la Pesach, la Pasqua ebraica, per scopi rituali, accusa diffusasi nel Medioevo e ripresa nella Germania Nazista).
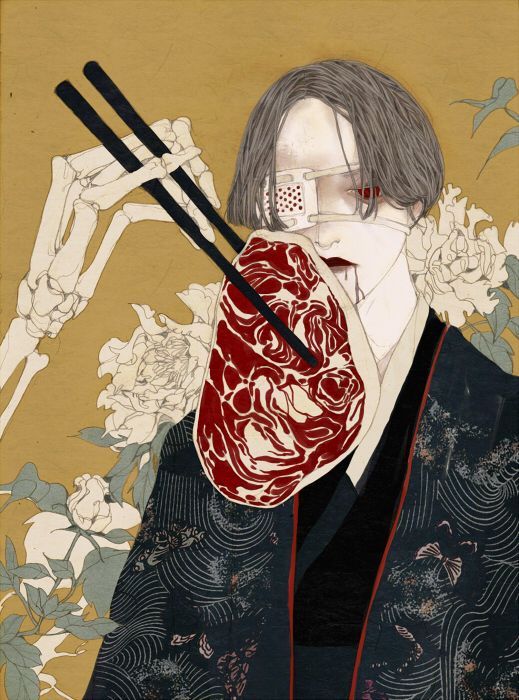
Il cannibalismo è inoltre un tema ricorrente, nella cultura pop e nelle credenze popolari. Generalmente, si pensa che sia frutto di disturbi mentali. Queste convinzioni in realtà non si basano su ragionamenti fondati scientificamente (per ora), ma solo su interpretazioni frettolose o sul fascino sinistro di questa pratica. Le due interpretazioni più comuni sono le seguenti.
Tra gli aborigeni delle zone montagnose della Papua Nuova Guinea, il cannibalismo era una tradizione locale di inumazione, durante la quale si mangiavano i tessuti del parente deceduto in segno di rispetto (chiamato cannibalismo rituale). Tuttavia, proprio in queste popolazioni si diffuse il kuru, una malattia da prioni2 che si manifestava una volta ingeriti i tessuti del deceduto. In realtà questi tessuti dovevano essere già contaminati dalla malattia di Creutzfeldt-Jakob6 per poter trasmettere il kuru. Questi rituali sono stati proibiti a partire dagli anni Cinquanta, ma ormai il collegamento era inevitabile, quasi ovvio: il cannibalismo provocava malattie incurabili e mortali.
Un altro assunto più frequente è che il nostro corpo possa sviluppare una dipendenza dalla carne umana simile al tabagismo, in quanto la carne umana richiede al nostro organismo meno fatica per essere trasformata e digerita. In effetti, il corpo impiega più passaggi per adattare i vegetali che per digerire carne animale, più simile alla nostra. Quindi, secondo questo ragionamento, la più facile digestione spingerebbe la mente a desiderare sempre più carne umana, quasi disabituandosi al cibo “normale”. Si tratta ovviamente di speculazioni, tuttavia mai smentite perché nessuno le ha mai confutate scientificamente, e certamente mai confermate.

Ma quindi può esistere un cannibalismo etico, “sostenibile”? Finora ci sono state solo alcune circostanze storicamente provate in cui degli esseri umani si sono cibati di altri esseri umani. Un esempio abbastanza conosciuto è la carestia del 1921-23 in Russia: molte testimonianze dell’epoca, confermate anche dall’apertura degli archivi sovietici, riferiscono di uccisioni di bambini allo scopo di mangiarli o venderne la preziosissima carne. Tali notizie, una volta diffuse, daranno origine al tormentone dei “comunisti che mangiano i bambini”. Questo evento non sembra però centrare esattamente la definizione di “cannibalismo”. Quest’ultimo, infatti, è un’istituzione culturale, approvata da una determinata società: ma il cannibalismo sembra incompatibile con la sopravvivenza della civiltà medesima. Ci si potrebbe appellare alla sovrappopolazione, come argomento a favore dell’introduzione di questa pratica, ma la vera domanda, in questo caso, sarebbe: resteremmo comunque una civiltà? Forse leggendo Bazterrica abbiamo già ottenuto la risposta.
‘What’s wrong with eating people?’ and ‘What’s wrong with eating animals?’ are essentially the same question. It just comes down to the words we use.
David Tierney
Note
- William Arens. The Man-Eating Myth: Anthropology and Anthropophagy. New York, Oxford University Press, 1979
- Le malattie da prioni sono rare patologie degenerative del cervello (e raramente di altri organi) progressive, letali e attualmente incurabili che derivano dalla trasformazione di una proteina in una forma anomala chiamata prione. (Manuale MSD, versione per i pazienti).
- La malattia di Creutzfeldt-Jakob è una malattia da prioni caratterizzata dal deterioramento progressivo della funzione mentale, acquisibile mangiando manzo contaminato da encefalopatia spongiforme bovina, o “malattia della mucca pazza”. (Manuale MSD, versione per i pazienti).
Tutto fa brodo
Editoriale · L’Eclisse
Anno 2 · N° 3 · Giugno 2022
Copertina di Laura Maroccia.
Hanno partecipato alla realizzazione di questo editoriale: Greta Beluffi, Oscar Benedetti, Matteo Capra, Michele Carenini, Anna Cosentini, Joanna Dema, Francesco Fatini, Eugenia Gandini, Marta Gatti, Chiara Gianfreda, Andrei Daniel Lacanu, Nikolin Lasku, Silvia Loprieno, Rosamaria Losito, Matteo Mallia, Marcello Monti, Valentina Oger, Alessandro Orlandi, Elisa Paccagnella, Luca Ruffini, Arianna Savelli, Tommaso Strada, Vittoria Tosatto, Marta Tucci, Marta Urriani, Francesco Vecchi, Adriano Zonta.

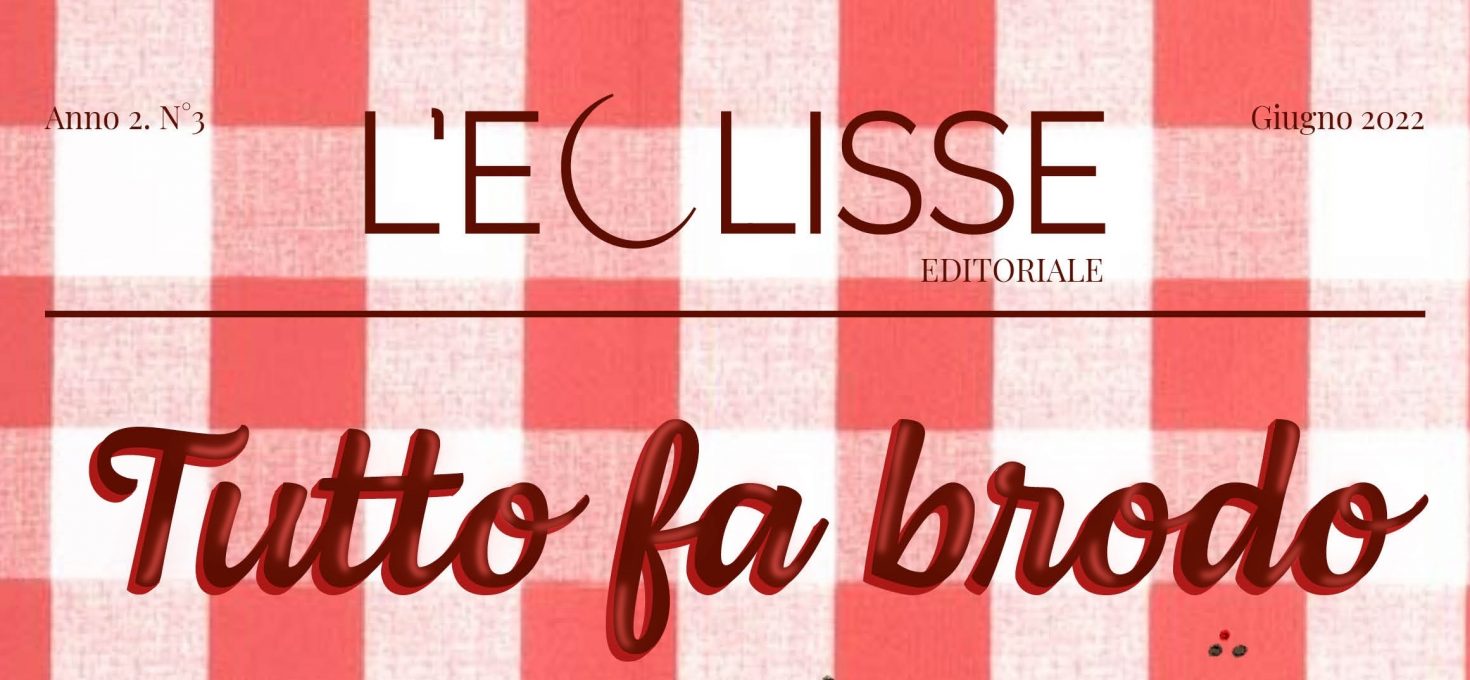
[…] mentre scrivevo l’anno scorso in totale tranquillità, seduta a un tavolino in riva al lago, la recensione di un libro sulla moralità del cannibalismo e delle sue implicazioni oggi. Ebbene, oggi torno con una doppietta letale, non più sull’antropofagia, bensì sul sentirsi […]